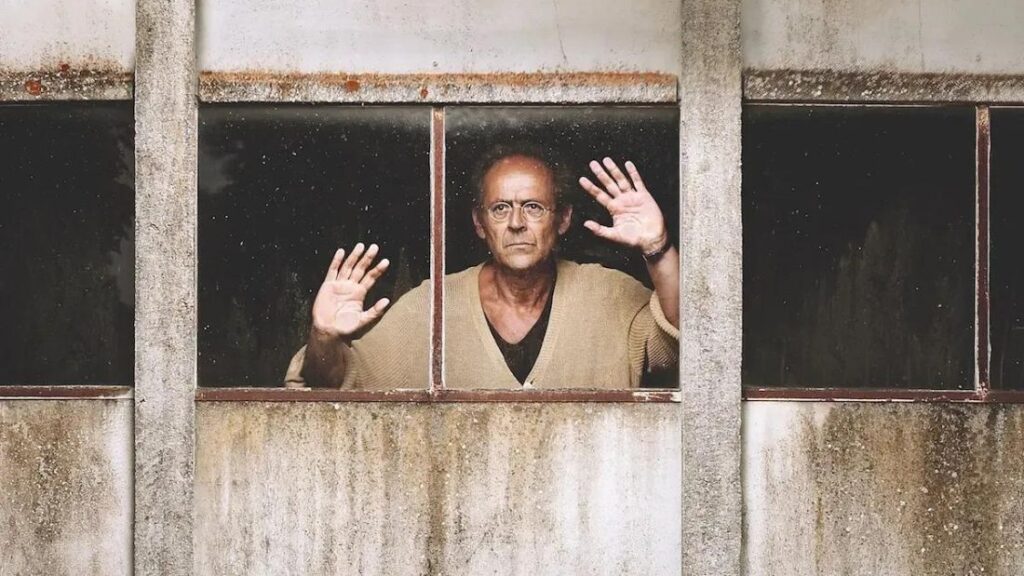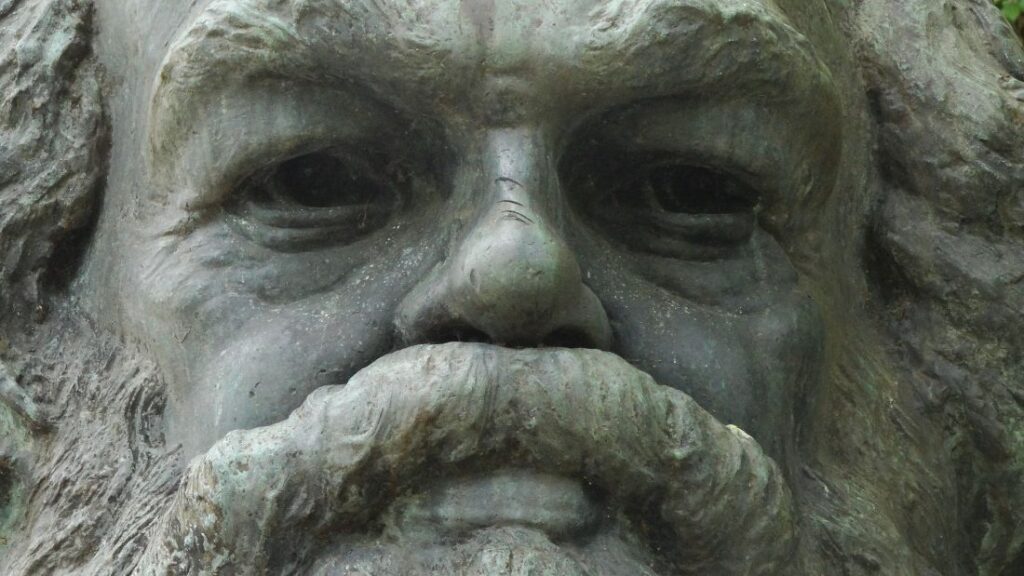Ecco a voi un brano tratto dal libro di Gilles Deleuze e Claire Parnet, Conversazioni, che Ombre Corte ha da poco ripubblicato e la postfazione di Antonio Negri alla nuova edizione del volume. Le pagine che riproponiamo alla lettura sono tratte dal primo capitolo: “Che cos’è, a che cosa serve una conversazione?”(pp. 8-13). Ci sembra particolarmente utile, di questi tempi aridi, ritrovare la nitidezza e l’efficacia di parole, di stili e di metodi che aiutino a fare spazio al nuovo. Ancora una volta, il richiamo è all’esercizio di un pensare estremamente radicale e completamente originale che nasce, tuttavia, dalla più semplice analisi critica del quotidiano: “Creiamo pure delle parole straordinarie, a condizione di farne l’uso più ordinario e di fare esistere l’entità che esse designano allo stesso titolo dell’oggetto più comune. Questa è la definizione dello stile”, scrivono Deleuze e Parnet. Ciò che continua a incantare di questo testo è l’incessante ricerca di trasformazione, attraverso concatenazioni che individuano le linee di fuga possibili e si schiudono a un eterno “divenire”. Che tipo di divenire? “La gente pensa sempre a un avvenire maggioritario (quando sarò grande, quando avrò il potere…). Mentre il problema è quello di un divenire-minoritario: non mimare, non fare o imitare il bambino, il folle, la donna, il balbuziente, lo straniero, ma diventare tutto questo, per inventare nuove forze o nuove armi”.
La postfazione di Negri, che è un’appassionata rilettura contemporanea del testo, mette, non a caso, al centro il divenire-donna, il divenire-molteplice, come eterna spinta ad alzarsi la mattina continuando ad avere voglia di resistere nel mondo
*****
Che cos’è, a che cosa serve una conversazione?
Divenire non significa mai imitare, fare come, e neanche conformarsi a un modello, fosse pure quello della giustizia o della verità. Non c’è un termine da cui si parte, né uno a cui si arriva o si deve arrivare. E nemmeno due termini che si scambiano fra loro.
Chiedere “che cosa stai diventando?” è una cosa particolarmente stupida, dato che man mano che uno diventa, muta in se stesso tanto quanto muta ciò che egli diventa. I tipi di divenire non sono fenomeni di imitazione, né di assimilazione, bensì di doppia cattura, di evoluzione non parallela, di nozze tra due reami. Le nozze sono sempre contro natura. Sono il contrario della coppia. Non ci sono più macchine binarie: domanda-risposta, maschile-femminile, uomo-animale ecc. Ecco, una conversazione potrebbe essere semplicemente questo, il tracciato di un divenire. La vespa e l’orchidea ne danno l’esempio. L’orchidea sembra formare l’immagine di una vespa, ma in realtà c’è un divenire-vespa dell’orchidea, e un divenire-orchidea della vespa, una doppia cattura dunque, poiché “ciò che” ciascuno diviene cambia tanto quanto “colui che” diviene. La vespa diventa parte dell’apparato di riproduzione dell’orchidea, nello stesso momento in cui l’orchidea diventa organo sessuale per la vespa. Un solo e identico divenire, un solo blocco di divenire, o, come dice Rémy Chauvin, una “evoluzione a-parallela di due esseri che non hanno assolutamente niente a che vedere l’uno con l’altro”. Esistono dei tipi di divenire-animale dell’uomo i quali non consistono nell’imitare il cane o il gatto, perché l’animale e l’uomo si incontrano soltanto sul percorso di una deterritorializzazione comune, ma dissimmetrica. È come per gli uccelli di Mozart: c’è sì un divenire-uccello in questa musica, ma preso in un divenire-musica dell’uccello, così che i due formano un solo divenire, un solo blocco, un’evoluzione a-parallela, dunque niente affatto uno scambio, ma “una confidenza senza interlocutore possibile”, come dice un commentatore di Mozart – in breve una conversazione.
I tipi di divenire sono la cosa più impercettibile, sono degli atti che possono essere contenuti soltanto in una vita e espressi in uno stile. E gli stili non sono costruzioni, più di quanto lo siano i modi di vita. Nello stile non sono le parole quelle che contano, e neppure le frasi, i ritmi, le figure. Nella vita non sono le storie, né i principi o le conseguenze. Una parola è una cosa che può sempre essere sostituita con un’altra. Se c’è una parola che non vi piace, che non vi va bene, potete sempre prenderne un’altra, sostituirla con un’altra. Se ognuno fa uno sforzo di questo genere, tutti si possono comprendere, e non ci sono quasi più ragioni di porre domande o di avanzare obiezioni. Non esistono parole appropriate e nemmeno metafore (tutte le metafore sono parole oscene, o ne producono). Ci sono solo parole inesatte per designare qualcosa esattamente. Creiamo pure delle parole straordinarie, a condizione di farne l’uso più ordinario e di fare esistere l’entità che esse designano allo stesso titolo dell’oggetto più comune. Oggi, possiamo disporre di nuove maniere di leggere e forse anche di scrivere. Ma ne esistono anche di cattive e oscene. Per esempio, si ha l’impressione che certi libri vengano scritti per la recensione che ci si aspetta da un giornalista, anche se non c’è più bisogno di recensioni, ma bastano alcune parole vuote (bisogna leggere questo libro! È formidabile! vedrete!), per evitare di leggere il libro e di scrivere l’articolo. Il giusto modo di leggere oggi, è quello di porsi di fronte a un libro così come si ascolta un disco, come si guarda un film o una trasmissione televisiva, come si sente una canzone: ogni atteggiamento di fronte a un libro che richieda per lui un rispetto speciale, un’attenzione di altra sorta, è qualcosa che giunge da un’altra epoca e che condanna definitivamente il libro. Non esiste alcun problema di difficoltà o di comprensione: i concetti sono proprio come suoni, colori o immagini, sono delle intensità che vi possono andar bene oppure no, che passano o non passano. Pop’filosofia. Non c’è nulla da comprendere e nulla da interpretare. Vorrei dire ora cos’è uno stile. È qualcosa che appartiene a coloro di cui si dice solitamente “non hanno stile…”. Non è una struttura significante, né un’organizzazione riflessa, né un ispirazione spontanea, né una orchestrazione, né una musichetta. È un concatenamento, un concatenamento di enunciazione. Uno stile significa riuscire a balbettare nella propria lingua. Non è facile, perché bisogna che si presenti la necessità di un simile balbettamento. Questo non significa parlare da balbuziente, ma balbettare il linguaggio stesso. Essere come uno straniero nella propria lingua. Aprire una linea di fuga. Questi sono gli esempi più evidenti per me: Kafka, Beckett, Gherasim Luca, Godard. Gherasim Luca è un grande poeta fra i più grandi: ha inventato un balbettamento prodigioso, il suo. Gli è capitato di fare delle letture pubbliche dei suoi poemi: duecento persone, e tuttavia bisogna considerarlo un evento, è un evento che passerà attraverso questi duecento senza far parte di nessuna scuola o movimento. Le cose non capitano mai là dove ci si aspetta, né attraverso i percorsi previsti.
Si potrebbe sempre obiettare che i nostri esempi sono troppo facili: Kafka ebreo ceco che scrive in tedesco, Beckett irlandese che scrive in inglese e francese, Luca di origine rumena, perfino Godard svizzero. E allora? Per nessuno di loro il problema è questo. Dobbiamo essere bilingui anche in una lingua sola, dobbiamo avere una lingua minore all’interno della nostra lingua, dobbiamo fare della nostra propria lingua un uso minore. Il plurilinguismo non significa soltanto il possesso di più sistemi ciascuno dei quali sarebbe omogeneo in se stesso; significa innanzitutto la linea di fuga o di variazione che intacca ogni sistema impedendogli di essere omogeneo. Non parlare come un irlandese o un rumeno in una lingua diversa dalla propria, ma al contrario parlare nella propria lingua come uno straniero. Proust dice: “I bei libri sono scritti in una sorta di lingua straniera. Sotto ogni parola ciascuno di essi mette il proprio senso o, per lo meno, la propria immagine, che spesso è un controsenso. Ma, nei bei libri, tutti i controsensi in cui si cade sono belli”1. Questo è il modo giusto di leggere: tutti i controsensi vanno bene, purché non consistano di interpretazioni, ma riguardino invece l’uso del libro, ne moltiplichino l’uso, formino un’altra lingua all’interno di quella che gli è propria. “I bei libri sono scritti in una sorta di lingua straniera…”. Questa è la definizione dello stile. Anche qui c’è un problema di divenire. La gente pensa sempre a un avvenire maggioritario (quando sarò grande, quando avrò il potere…). Mentre il problema è quello di un divenire-minoritario: non mimare, non fare o imitare il bambino, il folle, la donna, il balbuziente, lo straniero, ma diventare tutto questo, per inventare nuove forze o nuove armi.
È come per la vita. C’è nella vita una sorta di goffaggine, di cagionevolezza, di debolezza costituzionale, di balbettamento vitale, che costituiscono il fascino di qualcuno. Il fascino, sorgente di vita, come lo stile, sorgente di scrittura. E la vita non è fatta della vostra storia; coloro che non hanno fascino non hanno vita, sono come morti. Il fatto è che il fascino non coincide in nulla con la persona. È un qualche cosa che fa vedere le persone come tante combinazioni, come tante possibilità uniche uscite da una tale combinazione. È un colpo di dadi necessariamente vincente, perché conferma sufficientemente il caso, invece di delimitarlo, renderlo probabilistico, mutilarlo. In questo modo, attraverso ogni fragile combinazione, viene ad affermarsi una potenza di vita, con una forza, un’ostinazione, una perseveranza nell’essere senza pari. È singolare vedere come i grandi pensatori abbiano una fragile vita personale, una salute molto malferma, e al tempo stesso innalzino la vita a uno stato di potenza assoluta o di “grande Sanità”. Essi non sono persone, ma la cifra della loro combinazione. Certo, fascino e stile sono parole sbagliate, bisognerebbe trovarne delle altre, sostituirle. Il fatto è che il fascino dà alla vita una potenza non personale, superiore agli individui, e contemporaneamente lo stile dà alla scrittura un fine esterno, che travalica lo scritto. Si tratta della stessa cosa: la scrittura non ha il proprio fine in se stessa, proprio perché la vita non è qualcosa di personale. La scrittura ha come unico fine la vita attraverso le combinazioni che vengono da essa estratte. È la situazione opposta a quella della “nevrosi”, dove la vita viene continuamente mutilata, umiliata, personalizzata, mortificata, mentre la scrittura assume se stessa come fine. Nietzsche, l’opposto del nevrotico, uomo dalla gran vita e dalla fragile salute, dice: “Spesso sembra quasi che un artista e, ancor più, un filosofo stiano casualmente nel loro tempo […] al loro apparire e per il loro apparire, la natura, che non salta mai, fa il suo unico salto, un salto di gioia, perché per la prima volta si sente giunta allo scopo, là dove cioè comprende di dover disimparare ad avere dei fini e di aver giocato troppo alto il gioco della vita e del divenire. In questa coscienza essa si trasfigura e sul suo volto posa una mite stanchezza crepuscolare, ciò che gli uomini chiamano ‘la bellezza’”2.
Quando uno lavora, si trova per forza in una solitudine assoluta. Non si può fare scuola, né far parte di una scuola. C’è soltanto il lavoro nero e clandestino. E tuttavia si tratta di una solitudine estremamente popolata. Non di sogni, di fantasmi o di progetti, ma di incontri. Un incontro è forse la stessa cosa di un divenire o delle nozze. È dal fondo di questa solitudine che uno può fare qualsiasi incontro. Si incontra della gente (e a volte senza averla mai conosciuta né vista prima), ma anche dei movimenti, delle idee, degli avvenimenti, delle entità. Tutte cose che posseggono nomi propri, per quanto il nome proprio non designi affatto una persona o un soggetto. Designa invece un effetto, uno zig-zag, qualcosa che passa o succede tra altre due, come sotto una differenza di potenziale: “effetto Compton”, “effetto Kelvin”. Come dicevamo per i modi del divenire: non è che un termine diventi l’altro, ma ciascuno incontra l’altro; c’è un solo divenire che non è qualcosa in comune fra i due termini – dato che essi non hanno niente a che vedere l’uno con l’altro – ma che si trova in mezzo ad essi e che possiede una propria direzione: un blocco di divenire, una evoluzione a-parallela. È questa la doppia cattura, la vespa e l’orchidea: non un qualcosa che si troverebbe nell’uno oppure nell’altro, anche nel caso di uno scambio, di una commistione, ma un qualcosa che si trova fra i due, al di fuori di essi, e che cola in un’altra direzione. Incontrare significa trovare, catturare, rubare, anche se non c’è un metodo per trovare, a parte una lunga preparazione. Rubare è il contrario di plagiare, copiare, imitare o simulare. La cattura è sempre una doppia cattura, il furto un doppio furto, e questo produce non qualcosa di reciproco, ma un blocco asimmetrico, una evoluzione a-parallela, delle nozze, sempre “fuori” e “dentro”. Ecco, una conversazione sarebbe tutto questo.
NOTE
1 Marcel Proust, Contro Sainte-Beuve, trad. it. di P. Serini e M. Bongiovanni Bertini, Einaudi, Torino 1974, p. 103.
2 Friedrich Nietzsche, Schopenhauer come educatore, in Id., Opere, vol. iii, t. ii, trad. it. a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1972, pp. 435 e 406.
*****
Postfazione | In cammino verso il molteplice – di Antonio Negri
Credo che Deleuze avrebbe condiviso la notazione che leggere un libro per la seconda volta non è rileggerlo ma risperimentarlo, se è vero che il mondo (e i libri in esso) noi non lo interpretiamo ma lo sperimentiamo sempre di nuovo. Così mi è avvenuto rileggendo i Dialogues. La prima volta che li avevo letti mi erano sembrati una lucidissima ordinata ricapitolazione di quello che si era configurato come pensiero di Deleuze dopo la pubblicazione di Anti-Edipo e nella preparazione di Mille piani. Claire Parnet mi era sembrata l’intelligente e partecipe intervistatrice che aveva collaborato a questa nuova esposizione. Sempre che si possa chiamare intervistatrice chi partecipa al gioco del dialogo deleuziano: uno spiegarsi l’un con l’altro che sconta l’impossibilità di dialogare linearmente e pone, per l’interlocuzione stessa, un ritmo rizomatico di espressione, mai un cerchio ma al massimo un poligono, preferibilmente il percorrere una cartografia universale, e per ogni lato una via di fuga. Ed è qui che l’interlocutore diviene coautore. Diversissima l’impressione di questa mia seconda lettura. I Dialogues li ho sperimentati questa volta come una nuova trasfigurazione deleuziana, un consistente passaggio del suo pensiero: meglio, come il libro del suo “divenire-donna”. Claire Parnet si presta al gioco, lo sollecita, annulla per parte sua ogni parvenza della macchina binaria che dovrebbe registrare il dialogo: e questo libro di Gilles Deleuze è un “divenire Claire”, ma nello stesso tempo un divenire dentro tutte le facce dell’universo familiare femminile di Deleuze, “divenire Fanny”, “divenire-Josephine la souris”… Questi dialoghi sono il “divenire-donna” declinato dentro la letteratura, dentro la psicoanalisi, dentro il metodo, dentro la politica. Ma che cos’è il “divenire-donna”?
L’idea del divenire-altro si elabora in Deleuze dentro quello straordinario laboratorio di eversione della fenomenologia e dello strutturalismo che è il suo pensiero prima del ’68, quando viene inventata questa formidabile via di dissoluzione del trascendentalismo dei moderni che consiste nello svuotarlo dall’interno, dando alla differenza, alla sua intensità la possibilità di farsi consistente nel divenire.
Il divenire non è più flusso o mediazione ma produzione e composizione. È un pensiero (ed una sperimentazione) della differenza che diventa-altro. Ed è questo, proprio questo, che Foucault riconosce come segno di quella filosofia futura che “sarà deleuziana”. Ma questa scoperta deleuziana, questo disegno post-strutturalista attendeva un altro passaggio per divenire praticabile, per sviluppare la sua produttività: “il divenire-Félix” del lavoro di Gilles. È fra L’anti-Edipo e Mille piani che la nuova possibile cartografia del desiderio è investita da un flusso di realtà. La differenza e l’immanenza deleuziane si trasformano, nel “divenire-Félix”, in una formidabile macchina di essere affermativo.
Nulla di quello che precedentemente Deleuze aveva costruito, ed il senso della differenza per primo, è rimesso in discussione, ma tutto è nuovamente inquadrato nel cerchio dell’espansività rizomatica del desiderio, descritto nell’efficacia creativa dei suoi agencements, costruito in una Babele di gioia espressiva: “il mio incontro con Félix Guattari ha cambiato un sacco di cose”. Nelle grandi opere degli anni Settanta la differenza è assunta a centro-motore di una vera rivoluzione del pensare il divenire, che ha la forza di mutare il nostro modo di desiderare il mondo.
Si determinava qui uno strano paradosso (e quante volte Deleuze e Guattari si sono trovati costretti a dipanarlo); v’è infatti chi, affascinato dalla potenza del loro progetto, lo assume appunto nella sua globalità, e non vede e non sa come sperimentare il divenire nella sua molteplicità! “Gridare ‘viva il molteplice’ non significa ancora farlo: bisogna farlo, il molteplice”. È qui che si collocano i Dialogues, nel fare il molteplice, nel descrivere la geografia degli infiniti percorsi possibili, nel rendersi impercettibile ed invadente degli agencementes molteplici del reale. E dello stesso progetto filosofico. In ciò consiste la trasfigurazione del pensiero di Deleuze verso gli anni Ottanta.
Che cos’è dunque il divenire-altro? Ecco la risposta: se divenire è una geografia, degli orientamenti, delle direzioni, delle entrate e delle uscite; se divenire non è mai un’imitazione o una ripetizione, allora divenire-altro è un incontro di generi, un corto-circuito, una cattura di codici attraverso la quale l’uno diviene-altro. Chi abbia letto Dialogues non dimenticherà più la pagina del divenir-vespa dell’orchidea e del divenir-orchidea della vespa, o quella sul divenir-uccello della musica di Mozart e sul divenir-musica dell’uccello. Così il dialogo si realizza, saltando ogni frase binaria e facendosi, al contrario, agencement esso stesso, degli interlocutori e di vita.
Ma cos’è il divenire-donna? Non è dunque divenire come una donna, farsi-donna, ma percorrere quella linea di fuga che ci porta a sentire, ad essere, ad assumere la posizione della donna, come minoranza che esprime un modo differente (e radicale) di essere (e di agire) nel mondo. Se fosse possibile dichiarare fondamentale una qualsiasi delle mille impercettibili sfaccettature del divenir altro, l’esperienza del divenir-donna lo sarebbe senz’altro.
Lo è perché la donna non è, nel nostro presente, segno di un ordine stabilito ma la traccia stessa, la più privilegiata, di tutte le minoranze, di tutte le linee di fuga. A qual punto bisogna amare le donne per poterne parlare così! Non a caso un altro pezzo, letterariamente e politicamente straordinario, in questi Dialogues, è quello dell’analisi dell’anoressia, impercettibile e potente, di Fanny, la moglie di Deleuze, forse uno dei testi più pregnanti e forti del femminismo contemporaneo.
I Dialogues ebbero comunque vita difficile. Vi fu chi, soprattutto in Italia, considerò, negli anni Ottanta, questo testo come uno, fra gli altri, degli ornamenti del debolissimo pensiero della postmodernità. Erano la leggerezza della scrittura, il gioco continuo sull’impercettibilità del divenir-molteplice che incitavano a questa lettura: scandalo estremo, invero, della recezione di un libro e del pensiero di un autore! Il clima di trionfale imbecillità pubblica attraeva nel suo gorgo anche i Dialogues.
Come si poteva farlo? Il triste sospetto è che non li si leggesse. Perché, nello sperimentare il divenire-molteplice, questi dialoghi (che dialoghi non sono) sono ben poco deboli, al contrario estremamente radicali nelle analisi che rappresentano. Le sperimentazioni critiche che essi offrivano, apertis verbis, non potevano non farsi intendere (anche dal più ottuso dei lettori, da quello cioè che non sapesse assumere la carica dirompente del metodo) per quello che erano: radicali sovvertimenti di alcuni concetti cardinali della modernità (desiderio, identità, privato e pubblico, libertà e Stato, per non dire che i maggiori) e dell’obliqua ombra conservatrice che essi continuavano a gettare sul cosiddetto postmoderno “debole” all’italiana.
Basti leggere i capitoli “Psicoanalisi morta analizzate” e “Politiche”: nel primo la descrizione dei disastrosi effetti di normalizzazione che l’istituzione psicoanalitica aveva prodotto, implementava la critica del paradigma freudiano già sviluppata da L’anti-Edipo; nel secondo quell’animale deterritorializzato che è cittadino del postmoderno, è riconosciuto come attore di una guerra contro lo Stato (“che non è una metafora”) che sola può generare libertà. “Un nuovo tipo di rivoluzione sta diventando possibile”.
Ma v’è di più. In questi Dialogues maturava, come solo nell’inverno può avvenire (sono appunto questi les années d’hiver come Guattari li chiama), quel nuovo esperimento di scrittura filosofica che sarà Qu’est-ce que la philosophie?
Se una critica infatti poteva essere rivolta ai due poderosi tomi del ’72 (L’anti-Edipo) e dell’80 (Mille piani), era quella di un asistemismo programmatico che del “divenir-altro” faceva una vicenda mitica. Lo dico senza nessuna svalutazione teorica: era, quella, una mitologia filosofica di potenza presocratica, quale era già stata nuovamente auspicata dal Systemprogram di Holderlin, Schelling ed Hegel nello Stift di Tübingen. C’era in questi libri una immaginazione selvaggia, una forza del desiderio che tutto infrangeva, un gioco aperto di insistenze e consistenze ontologiche che scardinava ogni pedagogia (per non dire genealogia) del pensiero filosofico.
Nei Dialogues, opera di transizione, senza nulla perdere in radicalità, l’arma prima forgiata costituisce nuove figure ed appresta nuovi regimi di enunciazione per quella vecchia materia e per nuovi stati di cose. Questo cammino sarà completato in Che cos’è la filosofia?, dove il compito socratico di apprendere a pensare l’immanenza sarà metodicamente riorganizzato.
I Dialogues preparano dunque l’ultima formulazione del pensiero di Deleuze e Guattari introducendo, nel loro mondo, un nuovo piano di riflessione (oltre a consistenti invenzioni teoriche come la nuova interpretazione dell’hecceitas-evento, l’approssimazione del discorso infinitivo indiretto, per non dire del concetto come “sorvolo” e i già ricordati elementi di definizione del concetto-chiave di divenire-produrre). Ed è interessante sottolineare che questi nuovi contributi strettamente filosofici sono soprattutto da leggere nel capitolo “Sulla superiorità della letteratura anglo-americana”: paradosso deleuziano dei più tipici!
Ecco che cosa mi sono apparsi, ad una seconda lettura, questi Dialogues. Come il libro che, nella sperimentazione del “divenire-altro”, del “divenir-donna”, nel medesimo tempo allarga la presa metodica del discorso deleuziano e ne radicalizza il punto di vista minoritario, imprime una spinta fortissima alla realizzazione onniversale del metodo e apprende la critica del quotidiano. È un libro da leggere, pagina per pagina, forse il mattino, prima di uscire di casa, se si vuol resistere, nel quotidiano, al quotidiano. Se con dolcissima radicalità, si vuol vivere
Nota dell’editore alla nuova edizione: la traduzione di Giampiero Comolli – relativa al testo della prima edizione francese del 1977 – è stata ripresa, con alcune variazioni e rettifiche, dalla prima edizione italiana del 1980 (Feltrinelli). A lui e a Raul Kirchmayr, traduttore di L’attuale e il virtuale, scritto da Deleuze nel 1995 e pubblicato come capitolo quinto nell’edizione del 1996 (coll. Champs), va il nostro ringraziamento per la loro gentile concessione.
Titolo dell’opera originale: Dialogues. Flammarion, Paris 1977, 1996
Questo articolo è stato pubblicato su Effimera il 5 giugno 2023