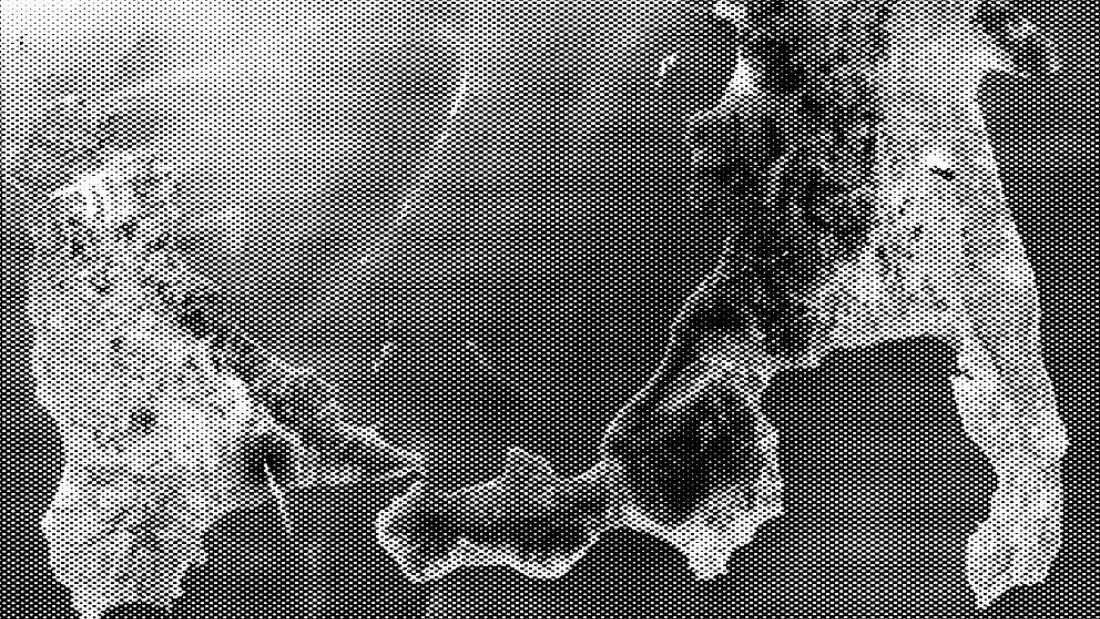Ogni nazione, in genere, si caratterizza più per le differenze al suo interno che per la omogeneità di tradizioni, culture, sviluppo economico, condizioni di vita e di lavoro. Pur facendo parte della stessa nazione gli Scozzesi sono diversi dai Gallesi, i Baschi dagli Andalusi, i Valloni dai Fiamminghi, i Corsi dai Normanni, i Bavaresi dai Prussiani e i Salisburghesi dai Carinziani. Il senso di una nazione sta proprio nel tenere insieme differenti tradizioni e diverse condizioni economiche e sociali in una comune appartenenza segnata dalla storia, dalla geografia, dalla religione, dalla lingua e da tante altri requisiti che sono più forti e unificanti delle differenze territoriali. Ma se queste differenze si cristallizzano in disuguaglianze permanenti (che incidono sulla qualità della vita quotidiana) il senso di appartenenza nazionale può sgretolarsi. Differenze e disuguaglianze non sono sinonimi e non sono direttamente conseguenziali. L’una non presuppone necessariamente l’altra. Si può essere differenti per tradizioni, culture, geografia da altri abitanti della stessa nazione senza che ciò impedisca di usufruire delle stesse opportunità lavorative, di godere delle stesse possibilità di realizzazione professionale, di studiare in condizioni similari, di avere accesso agli stessi servizi sanitari in grado di curare anche malattie gravi o di poterle prevenire, di potersi spostare da un luogo all’altro senza gravi difficoltà, di avere a disposizione asili per figli e nipoti e servizi territoriali per parenti anziani, di poter frequentare una biblioteca, un cinema, un teatro, una sala concerti e (caso mai) sviluppare il proprio talento in uno di questi campi. Nascere e abitare in luoghi diversi della stessa nazione non può significare essere destinati a due diverse forme di cittadinanza, una piena (con uno standard alto di servizi a disposizione) e l’altra dimezzata (con uno standard nettamente inferiore alle necessità minime di civiltà).
Lo svantaggio di luogo
In altre nazioni, certo, ci sono territori meno sviluppati dal punto di vista economico e sociale. Ma In genere ciò è causato dal rapporto difficile tra aree costiere e aree interne, con un vantaggio di quelle vicine al mare rispetto a quelle collinari e montane, tra i territori attorno alle metropoli (Parigi, Londra, Lisbona, Vienna, ad esempio) rispetto alle aree ancora in gran parte agricole o non densamente abitate. In Italia rispetto a questo tipo di differenze che pure esistono (mare-entroterra; pianura e zone collinari e montane; città-campagna; aree metropolitane-aree interne) si è affermata una differenza longitudinale tra Nord e Sud che ha assorbito e superato in estensione e continuità storica tutte le differenze geografiche e sociali precedenti. E c’è di più. Se in altre nazioni dell’Europa occidentale alle disparità economiche dei diversi territori non si somma necessariamente anche una disparità di servizi alle persone, in Italia i due svantaggi si sovrappongono: dove c’è minore sviluppo economico c’è anche minore presenza dello Stato nell’offrire quei servizi che il reddito personale o familiare non consente. Ma non è affatto detto che a una disparità economica tra cittadini che abitano in luoghi diversi corrisponda di per sé anche una disparità di servizi a disposizione. In Italia invece sì. Siamo una nazione a due velocità in economia e a due velocità nei servizi ai cittadini. Cioè, si è consolidata una “disuguaglianza doppia” tra cittadini della stessa nazione, una economica e una di cittadinanza. Tutto ciò è normale? È scontato, cioè, che se un luogo è più indietro nello sviluppo produttivo necessariamente deve subire per i suoi abitanti uno svantaggio nelle cure sanitarie, nello studio, nei trasporti, negli asili, nello sport, nella fruizione culturale, etc. etc.? Se sul libero mercato sono i privati in gran parte a determinare le occasioni di lavoro, nel campo dei servizi è lo Stato a farlo (attraverso i ministeri, le regioni, i comuni), e quindi lo “svantaggio di luogo” è più insopportabile perché è prodotto non dagli “spiriti animali” del mercato ma dalla incapacità o dalla non volontà di organizzare lo Stato in maniera tale da non sommare allo svantaggio economico anche quello civile. La “disuguaglianza di luogo” non ha niente a che fare con la diversa collocazione territoriale della popolazione, non è qualcosa di naturale ma una conseguenza delle scelte politiche e istituzionali: si può vivere in una nazione fortemente differenziata per geografia senza venir meno al dovere fondamentale dello Stato di non far pesare a vita il luogo di nascita e il posto dove abbiamo deciso di risiedere.
Addentriamoci ora nei numeri di questa anomalia italiana, che dimostrano una cosa che è sotto gli occhi di tutti ma che la politica non vuole affrontare per quello che è, il consolidarsi di una nuova forma di divario tra Nord e Sud: ancora prima delle differenze negli indicatori economici e del prodotto interno lordo (Pil) c’è una differenziazione profonda nelle condizioni quotidiane di vita tra le due aree del Paese che è diventata una “disuguaglianza di luogo” o la manifestazione più evidente di un diritto di cittadinanza dimezzato in una parte della nazione. Ci faremo accompagnare nella descrizione di questa vera e propria “mappa delle disuguaglianze territoriali” da alcuni studi pubblicati di recente e che meriterebbero maggiore diffusione: Il Rapporto sulla popolazione a cura di Billari eTommasini (il Mulino, 2021); Il divario di cittadinanza, di Bianchi e Fraschilla (Rubbettino, 2020); L’Italia longeva, di Caselli, Egidi e Strozza (il Mulino, 2021) e dal Rapporto 2022 della Svimez.
Ma i meridionali non vivevano più a lungo?
Negli anni più difficili per il Sud (sicuramente gli ultimi 30), noi meridionali abbiamo reagito con l’orgoglio dell’appartenenza territoriale alla constatazione evidente dell’aumento del divario con il Centro-Nord, esagerando e sublimando le nostre virtù naturali al confronto con gli svantaggi della civiltà industriale. Ma nel giro di pochi decenni alcune delle certezze “consolanti” si sono letteralmente frantumate.
In definitiva, ci dicevamo, loro beneficiano di uno sviluppo industriale imparagonabile rispetto al nostro, con una produzione di rifiuti tossici in grado di avvelenare l’aria e i polmoni, mentre noi ci godiamo un ambiente naturale incontaminato: loro la ricchezza, noi la bellezza; loro il benessere economico noi la natura. Pensavamo, in fondo, che la vita in una civiltà pienamente produttiva ha come bilanciamento lo stress della competizione e dell’accumulo, una vita amicale e sentimentale più nevrotica e isolata: loro i soldi e la realizzazione lavorativa, noi un senso di comunità più solidale e appagante. Insomma, più poveri di risorse ma più ricchi di umanità.
Nel Centro-Nord immaginavamo più malattie e decessi per patologie legate a ritmi di vita usuranti, mentre noi ci vantavamo dei nostri vecchi centenari e del minor numero di infarti e di tumori. I loro ospedali più attrezzati e specializzati ci ospitavano quando dovevamo curare malattie gravi o subire interventi delicati (che non potevamo affrontare nei nostri) ma non veniva scalfito il convincimento di vivere più a lungo, in migliori condizioni di salute e con minore stress.
I nostri ragazzi, destinati in breve tempo all’emigrazione o alla disoccupazione, ci sembravano più svegli e più preparati ad affrontare il mondo perché venuti su in quartieri dove la strada ti fa crescere in fretta e ti prepara a difenderti dagli altri e dalla vita. Ed eravamo convinti che i loro ragazzi abbandonassero più frequentemente la scuola per poter presto guadagnare, e che frequentassero meno le università, mentre i nostri li facevamo studiare e laureare: prima o poi la cultura e la preparazione intellettuale (ottenuta nelle nostre università che ritenevamo le migliori) avrebbero fornito ai nostri giovani delle chance superiori ai loro coetanei settentrionali dediti solo al lavoro. E se i nostri bimbi, figli e nipoti, non avevano la possibilità di frequentare gli asili-nido (quelli pubblici per un’impressionante carenza, quelli privati per i costi) ci consolavamo pensando che le mamme (che qui non trovavano lavoro) potevano almeno crescere in casa i loro figli, utilizzando anche la disponibilità dei nonni, convinti che la crescita tra gli affetti familiari avrebbe compensato il più ritardato avvio all’apprendimento scolastico e collettivo.
Ci consolava immaginare che i meridionali avrebbero vinto la battaglia demografica con in media due figli in più rispetto al resto del Paese. Negli anni a venire l’Italia avrebbe avuto bisogno di noi, dei nostri figli e dei nostri nipoti! Insomma, avevamo costruito un racconto sulla nostra arretratezza in gran parte rassicurante, immaginando di poter contare sulla legge naturale dell’equilibrio sociale, una specie di contrappeso civile e umano: chi ha di più sul piano delle ricchezza e delle opportunità lavorative, avrà di meno in una società più atomizzata, con pochi bimbi, con rapporti umani meno soddisfacenti, con un ambiente devastato e pieno di tossine, con ragazzi che non studiano per andare subito al lavoro, con vecchi abbandonati negli ospizi. E invece i dati degli ultimi anni hanno smentito clamorosamente tutte le considerazioni ottimistiche dei meridionali.
I duri dati
Cominciamo dalla longevità degli italiani. Il dato è apparentemente incoraggiante: in poco più di un secolo l’età media degli italiani si è raddoppiata, oggi è di 83 anni (85,2 anni per le donne e 80,9 per gli uomini) mentre nel 1900 era poco più di 41 anni (41,8 per le donne e 41,6 per gli uomini). Arrivare a ottanta anni di vita in Italia è di questi tempi la norma e morire prima è meno probabile rispetto ad alcuni anni fa. Arrivare a compiere 90 anni di vita è una prospettiva sempre più diffusa. Siamo appena dietro al Giappone in questa classifica della longevità. Ma c’è un ma: se le donne italiane vivono in media 4 anni e 3 mesi in più degli uomini, quelle che risiedono in Calabria o in Campania vivono tre anni in meno di quelle toscane che raggiungono in media gli 86,4 anni di vita; se invece paragoniamo l’età media di una donna della provincia di Bolzano (87,3) gli anni perduti delle nonne meridionali arrivano a quasi 4. Per gli uomini la Campania è la regione con la più bassa durata della vita (in media si campa 2 anni e 7 mesi in meno della media nazionale) mentre le donne muoiono 2 e mezzo prima delle loro connazionali del Centro-Nord. La regione del Nord che detiene il record assoluto della longevità è il Trentino Alto-Adige, mentre la regione settentrionale meno longeva è il Piemonte; nel Sud le tre regioni con più bassi tassi di longevità sono la Campania, la Calabria e la Sicilia. I tumori sono responsabili di 1/3 degli anni perduti in tutto il Sud. Incidono la mancata diagnosi precoce e le cure in ritardo o non adeguate, cioè le carenze dell’organizzazione ospedaliera e territoriale. Anche se, e va ricordato, ci sono alcune aree della Sardegna e della Calabria con il più alto numero di centenari in rapporto al peso della popolazione.
Eppure, la situazione non stava in questi termini solo 40 anni fa. In uno dei suoi libri più acuti e controversi (L’Italia nuova. Identità e sviluppo 1861-1988) lo storico Silvio Lanaro ricordava che all’inizio degli anni Ottanta del Novecento la speranza di vita di chi risiedeva nel Nord era in media di quasi due anni inferiore rispetto a chi, invece, viveva al Sud. Attribuiva quella disparità alla “mortalità da progresso”, cioè al fatto che lo sviluppo industriale e lo stress da benessere causavano più tumori e infarti, mentre un ambiente più incontaminato e meno sfruttato industrialmente come quello meridionale (e ritmi meno logoranti) consentiva quasi due anni di vita in più. Se poi si vanno a riprendere le statistiche ufficiali relative al 2001 si scopre che la polarizzazione attuale (si vive in media due anni e mezzo in più nel Centro-Nord) non era affatto così appena venti anni fa. Nel 2001 si viveva in media 82,9 anni per le donne e 76,7 anni per gli uomini. Ebbene le donne della Sardegna, della Basilicata, della Puglia, del Molise e dell’Abruzzo vivevano di più della media nazionale, mentre quelle della Calabria erano in linea; stessa cosa per gli uomini: i Calabresi, i Lucani, i Pugliesi, gli Abruzzesi e i Molisani vivevano di più della media nazionale, mentre i Siciliani erano quasi in linea. I Campani erano gli unici meridionali ad essere già all’epoca sotto la media nazionale con entrambi i sessi. Ed è singolare verificare come in Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia-Giulia e in Lombardia l’età media della vita nel 2001 era inferiore alla media nazionale.
Dunque, nel giro di poco più di 40 anni (con una accelerazione negli ultimi 20) la situazione si è totalmente capovolta. Le statistiche sanitarie ci dicono che, oggi, chi vive nel Sud muore in media due anni e mezzo prima di chi risiede al Nord e al Centro. Cos’è cambiato di così radicale (e in così pochi decenni) per giungere ad un capovolgimento del genere? Certo, non bisogna mai dimenticare il successo nell’allungamento della vita che ha riguardato l’Italia intera. Ciò è dovuto a più fattori: l’allargamento del benessere rispetto alle epoche precedenti, l’istruzione di massa che ci ha resi più aperti a nuovi stili di vita, l’aumento dell’attività sportiva di massa, la riduzione del fumo, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la minore esposizione a rischi per la salute grazie alle lotte delle organizzazioni sindacali, la ricerca scientifica che anche in Italia ha raggiunto buoni livelli, ma soprattutto la riforma sanitaria del 1978 che ha garantito l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini a prescindere delle condizioni economiche dei singoli. Purtroppo, questo generale innalzamento delle aspettative di vita incontra tre limiti: uno ha a che fare con il sesso, l’altro con le condizioni di reddito e di istruzione, il terzo con la residenza. Insomma, il dato non è omogeneo, anche se porta l’Italia nel suo complesso tra i primissimi posti al mondo per aspettativa di vita. Per quanto riguarda il sesso, le donne vivono più a lungo ed è questo un dato generale della popolazione mondiale, anche se in Italia la forbice si sta riducendo di anno in anno in gran parte per la maggiore uso di tabacco tra le donne. L’aspettativa di vita ha poi degli sbalzi impressionanti a seconda di quanto si guadagna e del titolo di studio che si possiede (come avviene anche in altre nazioni). Infine, l’aspettativa di vita cambia di diversi punti percentuali a seconda dei territori in cui si risiede, delle strutture sanitarie in cui si è curati e della capacità di prevenzione dei diversi sistemi sanitari regionali.
Perché si muore prima nel Sud?
Indubbiamente, sono innanzitutto le diverse condizioni economiche tra le due parti dell’Italia che incidono sulla maggiore o minore possibilità di allungare gli anni di vita. La povertà (o l’indigenza) pesa sulla vita o sulla morte quasi quanto la sedentarietà, l’ipertensione, l’obesità, l’alcolismo, l’esposizione strutturale a cause di tumori e di leucemie. Poter acquistare tutti i farmaci necessari, godere delle cure prescritte senza preoccupazioni economiche, alimentarsi in maniera adeguata, seguire uno stile di vita più salutare, sono queste condizioni importanti per allungare la vita, soffrire di minori acciacchi nella vecchiaia e sopravvivere più a lungo a una malattia potenzialmente mortale. E poiché ci sono più poveri e più indigenti al Sud, ciò influenza sicuramente il fatto che la Campania sia il territorio con il più alto tasso di mortalità (seguita dalla Sicilia) secondo le ultime statistiche dell’Osservatorio nazionale della salute nelle regioni italiane.
Incide molto anche il livello di istruzione. Le persone con minori titoli di studio in media muoiono prima. In Italia un laureato ha la speranza di arrivare a 82 anni, mentre chi non lo è arriva appena a 77 anni. Chi svolge lavori fisicamente più pesanti (a cui in genere i laureati sono meno costretti) è esposto di più ad un logoramento del corpo in età matura, e chi ha un più alto livello di istruzione possiede più informazioni sulle migliori cure a disposizione per i suoi mali.
Ma se fossero solo questi tre fattori (il sesso, le condizioni economiche e il livello culturale) le cause delle impressionanti disuguaglianze nelle aspettative di vita tra le due Italie, come spiegarci il fatto che negli anni Ottanta si viveva più a lungo al Sud nonostante le condizioni economiche fossero già allora peggiori che al Nord? Evidentemente ci sono altri fattori che sono diventati decisivi per la longevità della popolazione, cioè le diverse risorse e le diverse strutture sanitarie a disposizione tra le due parti del Paese, il modo diverso di essere curati al Nord e al Sud, di fare prevenzione sul territorio o riabilitazione dopo una malattia invalidante. C’è una nuova geografia della longevità e il Sud è agli ultimi posti anche se ciò avviene all’interno di un aumento nazionale dell’aspettativa di vita.
La regionalizzazione della sanità incide sugli anni di vita
I maggiori poteri in materia sanitaria alle Regioni coincidono temporalmente con la radicale trasformazione della durata media della vita degli italiani. Perché di questo non si vuole prendere atto? La disuguaglianza delle prestazioni sanitarie sembra incidere sulle aspettative di vita almeno (se non più) delle condizioni economiche o di istruzione. La regionalizzazione della sanità ci ha resi e ci rende diversi di fronte alla vita e alla morte. Campiamo di più o moriamo prima non solo per scelte soggettive (mangiare male, fumare, bere alcolici, fare lavori pesanti, possedere meno soldi, andare di meno in vacanza, etc.) ma per condizioni oggettive dei territori in cui risiediamo e in cui sorgono le strutture sanitarie (cure sbagliate o non adeguate, incapacità di diagnosticare rapidamente le patologie mortali o di aggredirle in tempo). La regionalizzazione della sanità ha inciso e sta incidendo sul fatto se sopravviviamo di più o di meno (a seconda di dove viviamo) e se gli ultimi anni li trascorriamo in buona o cattiva salute. È un discorso che non possiamo più sottovalutare. Dove si sommano condizioni economiche difficili a prestazioni sanitarie insufficienti, il destino è abbastanza segnato. Dal 2009 al 2016 le quattro più grandi regioni meridionali hanno pagato oltre 7 miliardi di euro alle regioni del Nord a causa delle migrazioni sanitaria. Quante strutture di eccellenza il ministero poteva costruire nel Sud (e gestire direttamente) con quelle risorse? Se il primo impatto della pandemia da Covid-19 si fosse verificata in Calabria, in Campania o in Sicilia, e non nel Nord, il prezzo di vite umane sarebbe stato enormemente più grave. Questo è certo. La questione era stata posta in maniera forte già nel 2016, in periodo pre-Covid, dall’allora presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi (poi consulente del ministro Speranza): “In Campania e Sicilia si ha una speranza di vita alla nascita di 4 anni inferiore rispetto a Trentino e Marche: nelle prime due regioni siamo cioè a livelli di Bulgaria e Romania, nelle altre della Svezia”. Poi si è visto che neanche al Nord eravamo in presenza di una sanità di livello svedese e meno che mai in Campania, a differenza di quando continua a sostenere con prosopopea il suo presidente. E Ricciardi aveva poi aggiunto: “I fattori di rischio per la salute restano distribuiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, la disponibilità e l’accesso ai servizi, invece, penalizzano i cittadini del Sud. Un esempio tipico dello sbilanciamento dell’assistenza sono gli screening oncologici. Coprono la quasi totalità della popolazione in Lombardia ma appena il 30% dei residenti in Calabria”. Sempre secondo Ricciardi si spiegherebbe così “il capovolgimento dell’aspettativa di vita degli ultimi decenni, dopo che per oltre un quarantennio il Paese ha omogeneamente guadagnato in media 2 mesi di vita l’anno”.
I dati che, però, fanno più impressione e rabbia sono quelli relativi alla mortalità neonatale e alla emigrazione sanitaria dei piccoli malati di tumori o di leucemie. La mortalità neonatale (cioè dei morti appena nati) è maggiore del 40% al Sud e, secondo la Fondazione Gimbe, nelle regioni del Centro-Nord emigra l’85,5 dei pazienti sotto i 14 anni con malattie gravi. Ne ha scritto in un bel reportage Marco Grieco nel numero del 4 dicembre de L’Espresso. Si può immaginare cosa ciò vuol dire per una famiglia meridionale alle prese con un grave problema di salute di un figlio piccolo: oltre al dolore anche il disagio di un trasferimento in posti molto lontani dalla propria casa. Perché mai non si ponga un alt a questa situazione costruendo strutture adeguate nel Sud d’Italia è questione che sfugge ad ogni ragionevole spiegazione.
Il Sud, luogo dell’incertezza
Negli ultimi decenni è saltato un altro radicato luogo comune, che cioè nel Sud si facessero più figli rispetto al Centro-Nord proprio a causa delle minori opportunità di lavoro. La situazione (se non ancora totalmente ribaltata) si è di gran lunga modificata tra le due aree del Paese. Il problema è di duplice natura. Da un lato nel Centro-Nord è aumentato il tasso di natalità, dall’altro nel Sud si è drasticamente ridimensionato, al punto tale da ipotizzare un impressionante calo di popolazione meridionale (la Svimez parla di un pericolo di “desertificazione”) anche perché la maggior parte degli immigrati stabili vive nel Nord e, quindi, contribuisce con i propri nati a incrementare i tassi di natalità della popolazione settentrionale. Secondo i dati del nostro maggiore demografo, Massimo Livi Bacci, alla metà del Novecento il 37% della popolazione italiana viveva nel Mezzogiorno e contribuiva con quasi il 50% alle nascite del Paese. Nel 2070 la popolazione italiana passerà dagli attuali 59 milioni e 200 mila abitanti a 47 milioni e 700 mila, con una perdita di 11 milioni e mezzo di abitanti, di cui ben 6 milioni e 400 mila nel Mezzogiorno, riducendosi ad appena il 28,4 % del totale, perdendo cioè un abitante su tre.
Negli ultimi decenni il contributo delle donne meridionali alle nascite è calato di ben 14 punti! Nel 1951 le donne e meridionali facevano registrare una fecondità del 3,2 figli, mentre nello stesso anno tale tasso era del 1,6 nel Centro- Nord. Cioè il Sud aveva un tasso di natalità doppio di quello centro-settentrionale. La Sardegna nel 1951 era la regione più prolifica d’Italia con una media di quasi quattro figli per donna (3,9) e la Liguria la meno prolifica (1,4). Nel 2020, invece, le donne sarde hanno fatto registrare addirittura una media di procreazione inferiore a uno (0,97) mentre in alcune regioni del Nord si arriva quasi al doppio, come in provincia di Bolzano (1,71), il più alto in Italia grazie alle provvidenze stanziate da quella Regione a statuto speciale. Con questi ritmi differenziati il meridione da area più giovane del Paese si trasformerà nell’area più vecchia, con una età media pari a 51,9 anni rispetto al 49, del Nord. Un cambiamento così radicale non era stato previsto da nessuno studioso della materia.
L’Italia è, dunque, una nazione a continua denatalità (tra le più preoccupanti in Europa) ad altissima longevità e a fortissime disparità territoriali in queste due campi. Il Sud non fa più registrare una natalità elevata, anzi è scesa sotto i tassi di fecondità del Centro-Nord. Se la media nazionale è di 1,24 figli per donna nel 2020, nel Sud stanno sotto la media Abruzzo, Molise, Basilicata, e Sardegna, invece Sicilia e Campania sono al di sopra, mentre oltre la media italiana si collocano Lombardia, Trentino Alto-Adige, Emilia e Veneto. Lo slittamento in avanti dell’età media delle madri supera ormai i trent’anni in tutto il Paese. Il secondo figlio è un’opzione sempre più rara e le famiglie (o le coppie) senza figli aumentano. A cosa è dovuto questo cambio radicale nel costume degli italiani e, ancora di più, dei meridionali? Esso è dovuto in gran parte al cosiddetto “tempo dell’incertezza” che accompagna più a lungo che nel recente passato le nuove generazioni. Ma il luogo dell’incertezza per eccellenza è il Sud, dove fare figli è diventata una difficile scommessa. Si rinvia l’età di vivere in coppia e di conseguenza l’età per fare figli. Molte donne meridionali si spostano fuori dalle loro regioni alla ricerca di lavoro e quando lo trovano temono di perderlo a causa di una maternità non ben vista dal datore di lavoro o perché spaventate dai costi per mantenere figli al Centro- Nord con i nonni (o gli altri parenti in grado di aiutarli) lontani. Se restano al Sud si spaventano per la mancanza di asili pubblici e per i costi di quelli privati. Insomma, nel Sud il cambiamento della condizione della donna, le nuove aspettative lavorative in rapporto agli studi fatti non si è prodotto in sintonia con un cambiamento del mercato del lavoro e dei servizi necessari per sostenerlo. Così abbiamo donne nettamente diverse dal passato, con stili e aspettative di vita simili alle loro coetanee del Centro-Nord ma con una profonda disparità nel realizzarle. Oltre a una nuova geografia della mortalità, in Italia si è formata una nuova geografia della natalità! Le famiglie numerose al Sud si stanno rapidamente riducendo e nei prossimi anni avremo più nel Mezzogiorno che nel Nord famiglie composte da un solo figlio.
La insopportabile disparità di servizi
Strettamente legato al problema della natalità è il problema della disparità dei servizi che, come abbiamo visto, è un fenomeno altamente scoraggiante per le nuove madri. Nel periodo 2019/2020 la quota di bambini da zero a tre anni che ha potuto usufruire dei servizi per l’infanzia offerti dai Comuni è stata del 19, 3% al Centro- Nord e del 6,4% al Sud, una differenza di ben 13 punti percentuali. Ancora maggiore il divario in termini di spesa pro capite: 302 euro per bambino nel Sud a fronte di 1,227 nel Centro-Nord, cioè ben quattro volte in più! A questo dato si deve aggiungere quello relativo al numero di alunni della scuola primaria che fruiscono del tempo pieno: si passa dal 48,5% nell’Italia centro-settentrionale (la metà degli scolari) al 18,6% in quella meridionale (neanche un quinto). Unica eccezione è rappresentata dalla Basilicata che raggiunge il 48%. Impressionante anche il dato degli alunni della scuola primaria senza mensa: nel Mezzogiorno quasi l’80% degli scolari non beneficia di alcun servizio mensa (con punte dell’87% in Campania e dell’88% in Sicilia) mentre nel Centro-Nord solo il 46% (meno della metà) non mangia un pasto a scuola. Da ricordare che nel Sud più che l’orario prolungato si registra un largo uso dell’orario ridotto. Gli allievi della scuola primaria nelle regioni meridionali perdono 4 ore di scuola a settimana rispetto ai loro coetanei che vivono più a Nord. Da questo punto di vista le regioni che perdono più ore di scuola per riduzione di orario sono il Molise e la Sicilia, ben 200 ore su base annua e 1000 in cinque anni che corrispondono al monte ore di un anno di scuola primaria! Non dissimili la situazione nelle altre regioni a Sud dell’Italia, con l’eccezione ancora una volta della Basilicata. Da segnalare anche il dato relativo alle palestre: circa il 66% di tutte le scuole primarie del Mezzogiorno non ne sono dotate, con punte del 73% in Campania, 81% in Sicilia e l’83% in Calabria. Questa grave carenza si ripete anche nelle scuole secondarie di secondo grado, con qualche punto percentuale in meno. Solo la Puglia presenta un discreto standard di palestre utilizzabili. La Svimez, a proposito, nel suo Rapporto del 2022, segnala che un minore meridionale su tre, nella fascia di età tra i 6 e i 17 anni, è in sovrappeso mettendo in relazione questo dato anche con l’assenza di possibilità di fare sport a scuola.
Senza studio e senza lavoro
Dovrebbero preoccupare le percentuali più basse al Sud nel conseguimento del titolo di studio delle scuole frequentate. Il target che l’Europa si prefiggeva di raggiungere con la cosiddetta “Strategia di Lisbona” (avere almeno conseguito un titolo di studio per l’85% dei giovani tra i 20 e i 24 anni) è stato centrato nel Centro-Nord ma non ancora nel Sud. Sul fronte della dispersione scolastica la differenza si fa ancora più allarmante: oltre la metà degli abbandoni degli studi (per ragazzi che hanno conseguito solo la licenza media) riguarda studenti meridionali, il 16,65 rispetto al 12,1% dei coetanei settentrionali. Ma mentre al Nord una parte consistente degli abbandoni è dovuta all’ingresso precoce nel mondo del lavoro, nel Sud l’abbandono non è assolutamente motivato da un lavoro intrapreso o atteso.
Ancora più seria e preoccupante la situazione delle Università. Un numero sempre più crescente degli iscritti ad atenei meridionali si traferisce in quelli del Centro-Nord, anzi vi si iscrive direttamente appena finite le scuole superiori. C’è stata in pochi anni una contrazione del 12% degli iscritti e gli universitari meridionali che studiano altrove sono passati dal 20% del 2010 al 27% del 2021. Il declino delle Università meridionali, con minori iscritti e minori risorse a disposizione, è già scritto nei fatti se non interverranno radicali modifiche di questo stato di cose.
“Digital divide”
Analizziamo ora il “digitale divide”, ossia la disuguaglianza di accesso alla digitalizzazione. Nonostante l’Italia mostri un consistente ritardo rispetto al resto d’Europa (soltanto il 42% degli italiani ha infatti competenze digitali di base, mentre la media europea arriva al 58%) ancora più allarmante è la differenziazione tra Nord e Sud. Tra le regioni che fanno meglio rispetto alla media nazionale otto su undici sono al Nord. Le ultime classificate sono invece tutte regioni del Sud.
Mentre i cittadini lombardi e quelli della provincia autonoma di Trento raggiungono le migliori competenze digitali, le regioni più indietro sono la Sicilia e la Calabria. Sono dati precedenti la pandemia, che ha sicuramente modificato qualche dato per il ricorso massiccio all’uso della digitalizzazione, ma le disparità non sono cambiate di molto.
Nel Sud un Welfare “dimezzato”
Prendiamo la rilevazione dell’Istat sulla “Spesa sociale dei Comuni”, riferita pubblicata nel 2019. Sotto questa voce vanno un numero consistente di servizi offerti ai cittadini, dall’assistenza agli anziani al sostegno alle famiglie e ai minori, dalla sistemazione di immigrati agli aiuti ai disabili, dal sostegno ai senza fissa dimora agli aiuti a tossicodipendenti o alcolisti, etc. etc. Nella rilevazione si certifica che “La spesa per abitante in Italia è pari a 124 euro con differenze territoriali molto ampie: al Sud essa è di 58 euro, cioè meno metà del resto del Paese.” Un cittadino meridionale, quindi, riceve meno della metà dei servizi e delle prestazioni di un italiano residente nel Centro e nel Nord-Ovest e circa un terzo rispetto ad un abitante del Nord-Est.
Lo scarto fra i due poli estremi – la provincia autonoma di Bolzano (540 euro) e la Calabria (22 euro) – porta a una distanza di quasi 25 volte!
E lo chiamano “trasporto pubblico”!
Mentre in alcune parti del Paese si sfreccia con l’Alta velocità per raggiungere luoghi distanti, è più complicato nelle regioni meridionali raggiungere località pur vicine. Sono 7538 i chilometri di binari che attraversano l’Italia settentrionale ma nel Sud i chilometri sono 5714, cioè 1.824 chilometri in meno. Nel meridione, però, il 70% della rete ferroviaria è a binario unico, rispetto al 52% del Nord, e ben il 43% di essa non è neanche elettrificata. Secondo un rapporto di Legambiente sul pendolarismo, i treni al Sud sono vecchi di almeno 20 anni rispetto ai 12 e mezzo di quelli in uso sulle ferrovie settentrionali. In Sicilia ci sono 486 corse al giorno rispetto alla Lombardia che ne ha 2560, cioè 5 volte di più pur essendo la popolazione lombarda solo il doppio di quella sicula. Le corse giornaliere in provincia di Bolzano sono 266 quasi quelle offerte in tutta la Sardegna (297) dove la popolazione è il triplo. In Calabria le corse sono 341 mentre in Liguria sono 355 pur essendo quest’ultima meno popolata e meno estesa del territorio calabro. 4 ore ci vogliono per recarsi da Martinafranca a Otranto in Puglia, 4 ore da Ragusa a Palermo e 3 ore per spostarsi tra Cosenza e Crotone (115 chilometri). Il record lo raggiunge il tratto Siracusa-Trapani: 11 ore per colmare, con tre cambi, la distanza di 388 chilometri.
L’autonomia disuguagliante
Com’è possibile sopportare tutto ciò e ritenerlo semplicemente una conseguenza del diverso sviluppo dell’economia e del reddito delle persone? E se non fosse proprio questo livello di disuguaglianza nei servizi una delle cause frenanti dello sviluppo produttivo di queste aree del Paese? Ci sono tante virtuose eccezioni in questa mappa del malessere civile del Mezzogiorno d’Italia, eccezioni che dimostrano come queste condizioni si possono modificare se solo si vuole farlo. Modificando queste condizioni nei servizi si inciderebbe anche sulla dinamicità dell’economia di questi territori. Invece, il dibattito politico torna a concentrarsi sull’Autonomia differenziata, che dopo la lettura di questi dati andrebbe chiamata con il suo giusto nome: “autonomia disuguagliante”. Perché una nazione degna di questo nome gli svantaggi li cura e li ripara e non li accentua con controriforme.
Questo articolo è stato pubblicato su Repubblica il 18 dicembre 2022