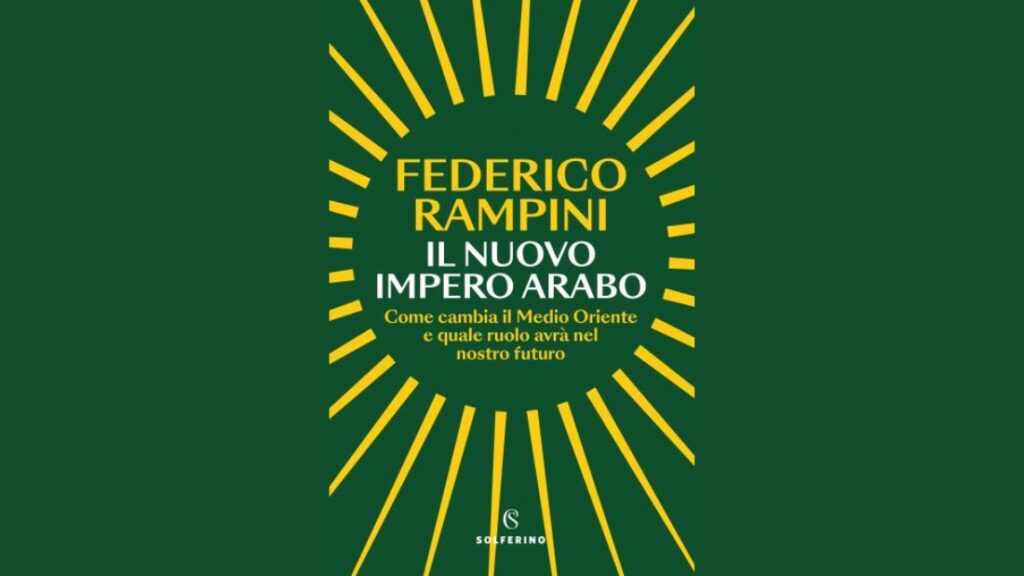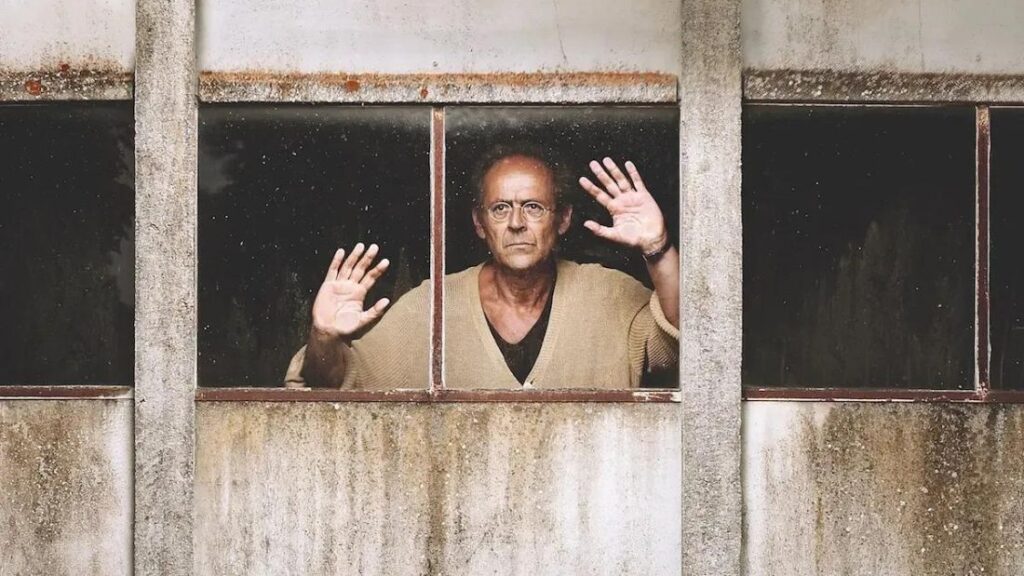In ottemperanza all’adagio inglese save the best for last, la recente traduzione italiana di un saggio del celeberrimo giornalista e scrittore Peter Hopkirk pubblicato originariamente nel 1984 riporta all’attenzione del pubblico un’opera che, quanto e forse più degli iconici Il Grande Gioco e Diavoli stranieri sulla via della seta, restituisce in una prosa allo stesso tempo asciutta e intrisa di sottile ironia il racconto di un trentennio (dall’ottobre in Russia all’indipendenza dell’India), l’importanza della cui eredità sta emergendo in maniera sempre più evidente sulla scorta delle mire espansionistiche cinesi da un capo all’altro dell’Eurasia.
Avanzando nell’Oriente in fiamme può essere descritto come la storia di un’appendice novecentesca della guerra coloniale (per procura) combattuta tra l’Inghilterra e l’impero zarista ora nella sua versione sovietica. Tutto lascerebbe propendere per un simile giudizio. Lo suggerirebbe l’ambientazione, abilmente ricreata dalla maestria narrativa dell’autore, la quale immerge il lettore in un’atmosfera da romanzo di spionaggio accompagnandolo lungo le tracce dei protagonisti tra montagne innevate, deserti dalla sinistra fama, le steppe mongole e i labirintici dedali dei bazar delle splendide – e ormai orientaleggianti – città la cui storia in età moderna è divenuto il campo di elezione della pubblicistica di Hopkirk, da Buxara ad Hamì, da Qo’qon a Kasgar, fino alle stanze del potere delle ambasciate occidentali. Né l’impressione sembrerebbe smentita una volta che si prenda confidenza con alcuni tra gli attori del dramma, dagli amministratori coloniali britannici, alle spie del servizio segreto di Sua Maestà (e russe), dai mullah, agli emiri e agli avventurieri (tra cui spiccano Sven Hedin ed Ella Maillart).
Si tratterebbe, tuttavia, di un giudizio estremamente superficiale. Rispetto al mondo di Conolly, Buxara Burnes, von Kaufmann e persino del capitano Francis Younghusband, nel 1917, «laddove la nostra scena s’apre», tutto infatti era cambiato. Preso il potere in Russia, dichiarata unilateralmente (e a proprie, salatissime spese) la pace con l’Asse, precipitati nella guerra civile e ancora profondamente scossi dal clamoroso fallimento dei moti insurrezionali nel resto d’Europa, a partire dalla Germania, Lenin e i bolscevichi volsero il proprio sguardo a Oriente: essi muovevano infatti dal doppio assunto che se, per sopravvivere in Russia, la rivoluzione sarebbe inevitabilmente dovuta divenire mondiale, le colonie delle potenze imperiali (in primo luogo l’India) avrebbero fornito al movimento rivoluzionario internazionale le armi necessarie per avere la meglio sui propri avversari in una lotta che, appariva evidente, sarebbe stata per la vita e la morte.
Su di uno sfondo di questo genere, persino la surreale apparizione, nel mezzo di una Taškent dilaniata dalla guerra civile, di uno sconosciuto gentiluomo inglese alla guida di un drappello di elefanti circensi, non fa altro che conferire ulteriore pathos a un racconto che segue le vicende di uomini e donne attraverso migliaia di chilometri dalle stamperie illegali di Londra ai più proibitivi passi dell’Hindu Kush nel corso di anni che davvero, come ebbe a scrivere John Reed (lui stesso per altro testimone di alcuni di quegli eventi, come l’indescrivibile congresso dei popoli d’Oriente convocato nel ’20 nella Baku in cui il cronista britannico si ammalò mortalmente di tifo), sconvolsero il mondo.
Certo, le peripezie dell’inafferrabile spia inglese Frederick Bailey, della sua controparte sovietica Mixail Borodin (e della moglie Fanya, miracolosamente scampata alla caccia alle streghe scatenata da Jiǎng Jièshí) ricordano molto da vicino le pagine più felici del Grande Gioco, ma non si deve dimenticare che, per lo meno nella percezione dei protagonisti, la posta andava adesso ben al di là di concessioni territoriali o persino del furto del gioiello della corona imperiale britannica (l’India). Come dalla tribuna di Baku ebbe a proclamare (tra scroscianti applausi) Zinov′ev in una delle sue orazioni più travolgenti, all’orizzonte si poteva intuire – incubo o sogno che fosse, a seconda dei punti di vista ‒ il disfacimento di un modello di civiltà nel fuoco e nel sangue di quella che, agli occhi di Lenin, altro non era se non la guerra che riassumeva in sé, facendole deflagrare, le contraddizioni insanabili del capitalismo al quale avrebbe fatto seguito l’avvento di una nuova era nella storia dell’uomo.
Una simile cornice apocalittica non deve essere persa di vista, perché essa aiuta a spiegare la mentalità, e le azioni, di alcuni dei personaggi che emergono con maggiore prepotenza dalle pagine del volume. Spicca su tutti il barone Roman Nikolaus Fëdorovič von Ungern-Sternberg, al quale sono dedicati due capitoli che per potenza di suggestione e sapienza narrativa non hanno forse pari nell’intera produzione di Hopkirk. Discendente di un’antichissima famiglia di nobili baltici, convertitosi al buddhismo, autoproclamatosi discendente di Gengis Khan e nemico acerrimo dei bolscevichi, il barone sanguinario, come fu ominosamente chiamato, si mise a capo di un effimero impero in Mongolia la cui parabola si concluse con la fucilazione da parte dell’Armata Rossa al termine di mesi di feroci combattimenti che seminarono morte e distruzione attraverso le steppe di tutta l’Asia interna.
Ungern-Khan – per riprendere un altro dei suoi svariati soprannomi – è forse la figura più inquietante di anni, quelli della guerra civile russa, il cui Zeitgeist è stato ben descritto in opere come L’armata a cavallo di Babel′ o l’allucinato L’anno nudo di Pil′njak: ma tanto il sogno panturanico di Enver Pasha quanto il regno del terrore di uno dei più talentuosi (e spietati) geni militari dell’epoca, l’enfant prodige generale Mǎ Zhòngyīng, concorrono a restituire il quadro di una lotta senza quartiere per il cuore dell’Asia dal cui esito, ritenevano gli strateghi di Mosca, Pechino e Londra, sarebbero dipese le sorti della geopolitica mondiale; un giudizio che, in circostanze nuovamente, e in maniera non meno radicale, mutate, sembra tuttavia non aver perso nulla della propria validità.
Il rapporto di Lenin – e alla sua morte Stalin – con le figure di maggior spicco dei movimenti rivoluzionari indiano e cinese (si pensi in particolare a un personaggio Manabendra Roy, tra i protagonisti assoluti dell’opera) si segnala come uno dei filoni narrativi più densi dell’intero saggio, le cui dinamiche meriterebbero di essere studiate e riflettute molto attentamente ancora oggi. Nonostante l’immenso costo in termini di vite umane e di ideali (disillusi e traditi), la Realpolitik perseguita negli anni Trenta da Mosca – memorabilmente ribattezzata dallo stesso Stalin «la Mecca di tutti i popoli oppressi» e ora sempre più isolata sulla scorta della marea montante di repressioni che accompagnarono il consolidamento del socialismo in un solo Paese ‒ finì infatti con il minare quella solidarietà, che pure era esistita, tra la causa sovietica e quella di quanti avrebbero dovuto abbracciare il messaggio di riscatto di cui la rivoluzione si era fatta latrice.
L’Oriente, nonostante tutto, non si incendiò, e quando lo fece (dalla Cina di Mao Zedong al Vietnam di Ho Chi Minh) il fattore scatenante fu una lotta anticoloniale che dell’internazionalismo dell’epoca di Reed non sapeva più che fare. In un’epoca che è ormai divenuto d’uso definire globale, ciò dovrebbe essere di monito a chi ancora progetti, mutatis mutandis, di trasformare l’Occidente giungendo dall’Est.
Peter Hopkirk, Avanzando nell’Oriente in fiamme. Il sogno di Lenin di un impero in Asia, Milano-Udine, Mimesis, 2021, pp. 332
Questo articolo è stato pubblicato su Treccani il 29 ottobre 2021