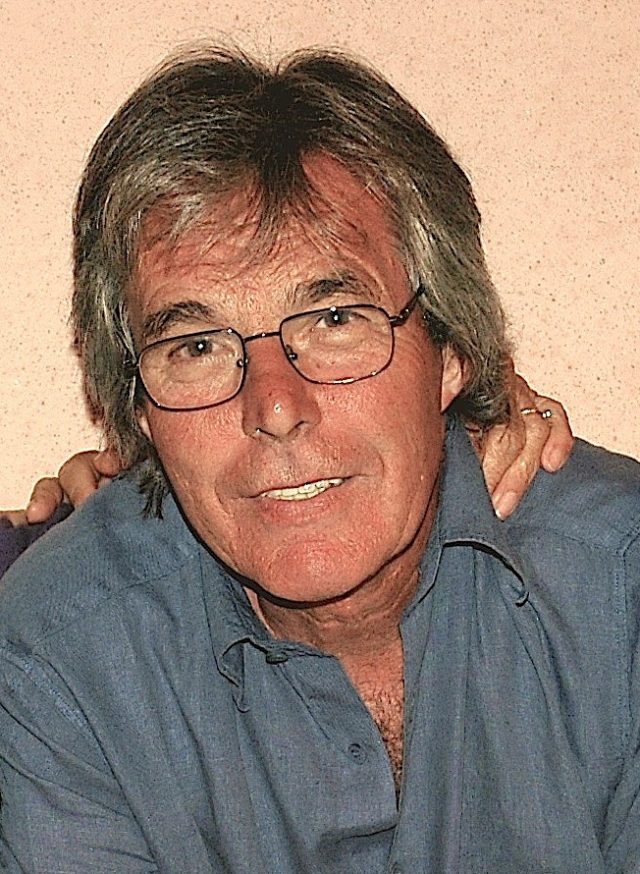di Salvatore Settis
Sono molto contento di essere qui con voi oggi, e vorrei ringraziare Maurizio Landini e la Cgil per avermi onorato con l’invito a parlare a Lecce. Ritengo infatti che i movimenti sindacali, e in particolare in Italia la Cgil, siano sempre più importanti per frenare, e se possibile arginare, la crisi della democrazia rappresentativa a cui il nostro tempo ci costringere ad assistere, quasi sempre da spettatori impotenti. Creare e alimentare occasioni di riflessione, di dialogo, di mutua educazione come questa fu un tempo, e non è più, compito e missione dei partiti; ed è da sperare che almeno nei sindacati essa sia ancora coltivata.
La difficile stagione politica che il nostro Paese sta attraversando, e che l’allontanamento della Lega dal governo mitiga appena, rende questa preoccupazione e questa speranza ancor più intense. E ancor più necessario ricominciare dalla Costituzione repubblicana, e intendendola non come polveroso arnese d’archivio, ma come vivo progetto per il futuro. Il tema che ho concordato con gli organizzatori è: Lavoro, salute, cultura al centro: la Costituzione come progetto.
Prima di entrare nel merito, vorrei tuttavia dichiarare una preoccupazione di fondo. Da troppo tempo i nostri governi vogliono presentare se stessi come un “governo costituente”. Lo ha fatto in particolare il governo Renzi, tentando una riforma costituzionale particolarmente infelice che il voto popolare ha poi sepolto; ma sulla stessa strada si era già messo il governo Letta; e anche l’attuale governo presieduto da Giuseppe Conte, pur con toni per fortuna più misurati e sobrii, ha ripetutamente indicato le riforme costituzionali come una tappa obbligata del proprio percorso.
Nel discorso con il quale il presidente del Consiglio ha chiesto e ottenuto la fiducia, si dice infatti ripetutamente che “il progetto politico di questo governo segna l’inizio di una nuova, risolutiva stagione riformatrice”. Il presidente Conte ha poi specificato che “per il tema delle riforme costituzionali, è nostra volontà inserire in calendario il disegno di legge che promuove la riduzione del numero dei parlamentari”: scelta a mio avviso del tutto corretta, visto che questo ddl costituzionale ha già compiuto i tre quarti del proprio iter parlamentare.
Giustificata è anche l’idea, che non tocca la Costituzione, di modificare la legge elettorale (personalmente sono favorevole a un sistema proporzionale il più possibile “puro”, perché consentirebbe qualche spazio al riformarsi di forze politiche autenticamente di sinistra). Ma che cosa vuol dire di specifico il presidente Conte, quando soggiunge che “è nostro obiettivo procedere a una riforma dei requisiti di elettorato attivo e passivo, nonché avviare una revisione costituzionale per assicurare maggiore equilibrio al sistema e far riavvicinare i cittadini alle istituzioni”? Che cosa intende quando dice che “nel quadro delle riforme costituzionali è intenzione del governo portare a termine il processo che conduca a un’autonomia differenziata giusta e cooperativa, che salvaguardi il principio di coesione e la tutela dell’unità giuridica ed economica”? E quale è precisamente la riforma che ha in mente, quando egli parla di “definire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e anche i fabbisogni standard, perché bisogna dare attuazione completa al 5 comma dell’art 119 della Costituzione che prevede l’istituzione di un fondo perequativo per garantire a tutti la medesima qualità dei servizi”? Per dare esito a quest’ultimo punto, si intende agire mediante legge ordinaria o intervenendo sulla Costituzione?
C’è poi una domanda se possibile ancor più pressante: le varie riforme costituzionali prospettate dal governo vanno intese come interventi “chirurgici”, da discutersi e approvarsi uno per uno, o il governo intende, ripercorrendo la strada di Renzi, arrestare il percorso dell’unica riforma costituzionale già avviata a pronta soluzione (la riduzione del numero dei parlamentari) per immetterla all’interno di un ddl costituzionale che contenga questi e forse anche altri punti? Come tutti sappiamo, i giornali (in particolare Repubblica, in un articolo a firma di Claudio Tito) hanno parlato di un “accordo segreto” M5S-Pd per una “piccola rivoluzione della Costituzione in cinque punti”, che sono in realtà sei. Mi limito qui ad elencarli, senza analizzarli partitamente:
- 1) norma sul taglio del numero dei parlamentari, che come ho detto è già molto avanti nell’iter parlamentare (e, connessa a questa ma con legge ordinaria, una nuova legge elettorale);
- 2) l’introduzione della “sfiducia costruttiva”, secondo cui ogni mozione di sfiducia dovrebbe indicare una possibile maggioranza alternativa;
- 3) la modifica del corpo elettorale che elegge il Capo dello Stato (riducendo il numero dei delegati regionali);
- 4) la partecipazione dei presidenti di Regione alle sedute del Senato ogni volta che si discutano leggi che riguardino le Regioni;
- 5) la parificazione di elettorato attivo e passivo per Camera e Senato (18 anni per votare, 25 anni per essere eletti);
- 6) il voto di fiducia al governo in seduta congiunta Camera-Senato onde evitare risultati difformi.
Non intendo oggi discutere nel merito queste idee, in parte diverse da quello che il presidente Conte ha lasciato intravedere nel suo discorso al parlamento. Ma non posso tacere su tre forti ragioni di preoccupazione. Formulerò la prima di queste con le parole di Piero Calamandrei, uno dei più autorevoli membri della Costituente e dei più autorevoli interpreti della Costituzione. Secondo lui, “quando il Parlamento discuterà pubblicamente la Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti; estraneo del pari deve rimanere il governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell’assemblea sovrana”. L’idea di un “governo costituente” è precisamente l’opposto dell’indirizzo etico-politico raccomandato da Calamandrei (e richiamato da Zagrebelsky nella campagna per il NO al referendum sulla riforma Renzi), anzi somiglia piuttosto a un’incauta dichiarazione dell’allora presidente del Consiglio Mario Monti in un’intervista allo Spiegel del 5 agosto 2012, secondo cui “i governi devono educare i loro Parlamenti”).
La mia seconda preoccupazione è forse precoce, ma è meglio formularla da subito. Nel caso che le varie ipotesi di riforma costituzionale (quelle elencate più altre che fatalmente emergeranno) dovessero essere messe tutte insieme, componendo un ampio disegno di riforma costituzionale, si verrebbe a ricadere nella stessa “sgrammaticatura istituzionale” dei due ultimi tentativi di riforma costituzionale (Berlusconi e Renzi), entrambi bocciati dal voto popolare.
Gravissimo sarebbe l’errore di comporre in unico disegno riformatore materie disparate, senza lasciare all’elettore che fosse d’accordo con una o più di quelle proposte la possibilità di esprimere separati pareri su separate materie. Perciò io credo che su ciascun punto andrebbe avviata, su iniziativa del Parlamento e non del governo, una separata procedura di ddl costituzionale, cominciando dalla riduzione del numero dei parlamentari (a cui, lo ripeto, sono personalmente favorevole), da abbinarsi a una nuova legge elettorale fissata con legge ordinaria, mentre altre possibili riforme costituzionali, ciascuna delle quali andrebbero semmai proposte e discusse (ed eventualmente sottoposte a referendum) una per una, separatamente.
Non sto affatto dicendo che non si può cambiare la Costituzione. Anzi: la Costituzione si può, e qualche volta si deve, modificare in nome della Costituzione, e l’art. 138 dice espressamente come fare, con una procedura volutamente lenta e complessa, deliberata dalla Costituente dopo amplissima discussione per mettere la Carta al riparo dai colpi di maggioranza. Ma la retorica delle riforme e della loro urgenza è tanta e tale, che sin dal governo Letta si tentò di scassinare la procedura dell’art. 138 con improprie scorciatoie.
Non meno sorprendente è che, anziché proporre modifiche puntuali a singoli articoli o segmenti della Costituzione, come è sempre avvenuto fino alle proposte Berlusconi e Renzi, si sia inteso stravolgerla cambiando, né più e né meno, “la forma di Stato e la forma di Governo”. Questi non furono passeggeri errori di grammatica o di galateo istituzionale : fu una svolta epocale nello stile di governo, uno svilimento delle regole del gioco (e della Costituzione) destinato a gettare pesanti ombre sul nostro futuro. Mi auguro che il governo oggi in carica non voglia avviarsi sulla stessa strada che altri hanno sperimentato con loro danno. E con danno del Paese.
E vengo così alla mia terza preoccupazione, che può apparire la più vaga e sottile ma è invece, in certo senso, la più forte. A me pare che questo insistere, che è diventato inevitabile sulla bocca di ogni possibile governo di questi anni, sulla assoluta e imminente necessità di serie riforme costituzionali non sia solo un innocuo o neutro rituale retorico. Al contrario, può avere un effetto di lungo periodo, che considero assai rischioso: quello di diffondere e radicare l’impressione che la Costituzione sia talmente invecchiata che è comunque un merito volerla ringiovanire con radicali “riforme”, poco importa se scritte da giuristi talvolta assai mediocri. Diffondere la sfiducia nella Costituzione, io credo, è atto contrario alla vita della democrazia nel nostro Paese.
Allontana la consapevolezza che la Costituzione così come è può rappresentare il manifesto dei nostri diritti, diritti spesso calpestati o ignorati. Coltiva l’illusione che una Costituzione in qualsiasi modo diversa sarebbe ipso facto migliore. Non è detto che questo progetto riesca: come si è visto con il referendum sulla riforma Renzi, è possibile che anche in futuro un tentativo di riformare la Costituzione non solo fallisca alla prova del voto, ma anche inneschi nuovi meccanismi di consapevolezza nei cittadini. Ma assai meglio sarebbe che questo governo non provasse nemmeno a imboccare la strada, che già si è rivelata fallimentare, di una vasta riforma della Costituzione. Se così non fosse, credo che dovremmo prepararci a innescare un adeguato fuoco di sbarramento.
Dopo questa introduzione, vengo al mio tema, La Costituzione come progetto. Un progetto che vede al suo centro il lavoro, la salute, la cultura. Mi sia consentito, non da giurista che non sono, ma da cittadino, di proporvi ora una lettura della Costituzione in questa prospettiva, partendo dall’affermazione di Calamandrei, che “in una Repubblica fondata sul lavoro è necessario identificare popolo e Stato”, i cittadini con lo Stato-comunità. Lo Stato siamo noi, come lo stesso Calamandrei soleva dire; ma solo se nella Costituzione sapremo riconoscere un manifesto per il bene comune. E se sapremo orientare di conseguenza l’azione e la militanza politica. Specifico, prima di andar oltre, che qui parlo di “bene comune” come valore, mentre dei “beni comuni” come proprietà condivisa dirò qualcosa tra poco.
Nella Costituzione della Repubblica l’espressione “bene comune” non c’è. Eppure suo principio ordinatore è precisamente il bene comune, in continuità con la publica utilitas che innerva la storia della Penisola. Nel linguaggio della Costituzione, questo concetto è espresso con altre formule: “interesse della collettività” (così all’art. 32, che riguarda il diritto alla salute), “interesse generale” (artt. 35, 42, 43 e 118), “utilità sociale” e “fini sociali” (art. 41), “funzione sociale” (artt. 42, 45), “utilità generale” (art. 43), “pubblico interesse” (art. 82).
Queste espressioni non sono coincidenti, ma convergenti; si integrano l’una nell’altra in una coerente architettura di valori. La parola-chiave “utilità” ha una densità speciale: evoca non solo la publica utilitas ma anche le riflessioni del pensiero utilitaristico sul nesso fra utilità e felicità degli individui e delle comunità. Per Stuart Mill, ad esempio, “la felicità va ridefinita non solo come uno stato pertinente all’individuo, ma come un’attività che l’individuo pratica in cooperazione con gli altri”. Ingredienti preziosi di questa utilità generale sono la solidarietà sociale e la forza che deriva dal consapevole perseguimento di fini comuni.
Nella Costituzione i rimandi al bene comune si addensano negli articoli del Titolo III (Rapporti economici e sociali). “Fini di utilità generale” possono determinare, secondo la Costituzione ma non certo secondo la prassi invalsa, l’esproprio di proprietà private (art. 42) o il trasferimento di imprese “di preminente interesse generale” (servizi pubblici, fonti di energia) allo Stato o a comunità di lavoratori (art. 43). L’attività economica dei privati, secondo la Costituzione ma non il costume dominante, dev’essere armonizzata con l'”utilità sociale” e coordinata con l’attività economica pubblica “a fini sociali” (art. 41).
La “funzione sociale” costituisce un limite alla proprietà privata (art. 42) e ispira la “cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata” (art. 45). Formule di questo tipo ricorrono, fuori del Titolo III, a proposito delle commissioni d’inchiesta delle Camere “su materie di pubblico interesse” (art. 82) o delle “attività di interesse generale” promosse dall'”autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati” (art. 118). Infine, l’art. 32 garantisce la tutela della salute non solo come “fondamentale diritto dell’individuo”, ma anche come “interesse della collettività”. Questa esplicita sutura fra diritti individuali e interessi collettivi risponde all’altissimo principio dell’art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Popolo è la parola più pregnante per designare il soggetto collettivo che è il protagonista della Costituzione. Al popolo appartiene la sovranità (art. 1), perciò in suo nome viene amministrata la giustizia (art. 101). Ad esso compete l’iniziativa nella formazione delle leggi (art. 71), il potere di abrogarle mediante referendum (art. 75) e la facoltà di rivolgere petizioni alle Camere (art. 50): un potere, quest’ultimo, troppo raramente usato. L’insieme dei cittadini può anche essere designato come società, al cui “progresso materiale o spirituale” ognuno deve concorrere “secondo le proprie possibilità e la propria scelta” (art. 4); o come collettività (come nell’art. 32 sul diritto alla salute). Densa di significati è un’altra parola-chiave, Nazione, che ricorre nella Costituzione pochissime volte, a cominciare dall’art. 9 secondo cui la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Questa e le altre occorrenze (artt. 67 e 98) corrispondono all'”unità nazionale” rappresentata dal Capo dello Stato (art. 87), nonché alla “Repubblica una e indivisibile” dell’art. 5; perciò ministri e sottosegretari giurano di esercitare la loro funzione “nell’interesse supremo della Nazione” (che poi se ne ricordino, è altro discorso). Il termine Nazione ha forte valenza etico-politica, ma anche una robusta consistenza fisico-geografica. Corrisponde infatti all’intero “territorio nazionale”, evocato come lo scenario dei diritti: libertà di circolazione (art. 16), diritti civili e sociali (art. 117 m), diritto al lavoro (art. 120). Popolo, Nazione, Patria (artt. 52, 59) sono nozioni convergenti, pervase da una stessa istanza di democrazia e di eguaglianza. Designano la comunità dei cittadini nel suo insieme, con uno sguardo inclusivo che abbraccia le generazioni future, le differenze di genere, di cultura, di reddito e di classe, e che trova nel lavoro un’istanza unificante entro la quale si fondono diritti, doveri e solidarietà sociale.
E vengo ora a un’altra parola-chiave, cittadino. Frequentissima nella Costituzione, non per questo la parola “cittadino” è meno intensa. Risuona in essa la forza e la dignità del citoyen francese, che la Rivoluzione proiettò sulla scena d’Europa scardinando l’antico status di suddito e affidando ai cittadini la custodia di valori eterni: libertà, eguaglianza, fraternità. Il cittadino è per definizione membro del popolo, e dunque titolare della sovranità, partecipe di un progetto di società che comporta una trama di diritti e di doveri. Perciò “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”, ed “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3). Ai cittadini spettano diritti inviolabili come la libertà (artt. 13, 15, 16), e in particolare la libertà di riunione (art. 17), di associazione (artt. 18 e 49), di culto (art. 19), di parola, di pensiero e di stampa (art. 21). A questi diritti corrispondono i doveri dei cittadini, come quello “di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi”, adempiendo “con disciplina ed onore” le funzioni pubbliche (art. 54).
Un altro grande, centralissimo tema al cuore della Costituzione è il lavoro, che nella tessitura costituzionale è fortemente connesso con la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. Il lavoro ricorre sin dall’incisiva definizione dell’art. 1: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Perciò “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto” (art. 4) “in qualsiasi parte del territorio nazionale” (art.120): fra gli articoli della nostra Costituzione, questo è uno dei più inosservati, e non vorrei dire dimenticati. Lavoro non è solo prestazione d’opera ma condivisione di responsabilità politica e sociale: perciò la Repubblica non solo “tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” ma cura anche “la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori” (art. 35).
Promuove “l’elevazione economica e sociale del lavoro” (art. 46) e assegna ai lavoratori un ruolo centrale nella gestione delle aziende, “ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione” (art. 46); perciò è possibile affidare “a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese (…) di preminente interesse generale” (art. 43). Giudicate voi se questi articoli della Costituzione abbiano mai trovato degna e sufficiente applicazione. Il lavoro infine, secondo la Costituzione, struttura altri diritti, come quelli delle donne e dei minori (art. 37); ed è al cittadino-lavoratore che l’art. 36 assicura una “esistenza libera e dignitosa”. Veri protagonisti della Costituzione sono dunque da un lato un soggetto collettivo, il popolo, dall’altro una folla di soggetti individuali, i cittadini-lavoratori, uniti fra loro da un vincolo di solidarietà che abbraccia diritti e doveri reciproci.
Ed è proprio alla nozione etico-giuridica di solidarietà che sono dedicati alcuni cruciali articoli della Costituzione. I valori del bene comune e l’etica del lavoro e della cittadinanza determinano, infatti, i “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” richiesti ai cittadini (art. 2). Simmetricamente, nell’art. 3 la stessa sequenza di aggettivi qualifica “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Libertà, eguaglianza, solidarietà, sviluppo della personalità, “equi rapporti sociali” anche nel “razionale sfruttamento del suolo” (art. 44) sono i pilastri che sorreggono “lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale”, finalizzati anche a “rimuovere gli squilibri economici e sociali” (art. 119). Virtù della cittadinanza, etica del lavoro e valori economici e sociali della produzione si saldano in un unico progetto.
Mirata al bene comune è la centralità della cultura scolpita nell’art. 9, “il piú originale della nostra Costituzione” (Ciampi): “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Cultura, ricerca, tutela contribuiscono al “progresso spirituale della società” (art. 4) e allo sviluppo della personalità individuale (art. 3), legandosi strettamente alla libertà di pensiero (art. 21) e di insegnamento ed esercizio delle arti (art. 33), all’autonomia delle università, alla centralità della scuola pubblica statale, al diritto allo studio (art. 34). Inoltre la Corte costituzionale, ragionando sulla convergenza fra tutela del paesaggio (art. 9) e diritto alla salute (art. 32) ha stabilito che anche la tutela dell’ambiente è un “valore costituzionale primario e assoluto” in quanto espressione di un interesse diffuso dei cittadini, che esige un identico livello di tutela in tutta Italia, come mostra nell’art. 9 il cruciale termine Nazione.
Vi invito a riflettere su questo punto: nella Costituzione del 1948 la nozione di ambiente non c’è, perché la cultura ambientalistica si sarebbe diffusa, in Italia come nel resto del mondo, solo qualche decennio dopo; ma quando fu necessario introdurre una nozione giuridica di ambiente non fu nemmeno tentata una riforma costituzionale: la Corte Costituzionale, con alcune memorabili sentenze, creò la nozione giuridica di “ambiente”, in via interpretativa, sommando il “paesaggio” dell’art. 9 al diritto alla salute dell’art. 32: prova, se mai ve ne fosse bisogno, che la Costituzione ha una ricchezza di contenuti che va esplorata e utilizzata a fondo prima di dover decidere se, su punti singoli com’era l’ambiente, sia veramente necessario modificarla.
Ambiente, paesaggio, beni culturali formano un insieme unitario e inscindibile la cui estensione corrisponde al territorio nazionale; fanno tutt’uno con la cultura, l’arte, la scuola, l’università e la ricerca. Con esse, concorrono in misura determinante al principio di uguaglianza fra i cittadini, alla loro “pari dignità sociale” (art. 3), alla libertà e alla democrazia: perciò la loro funzione è costituzionalmente garantita. Il noto adagio di Calamandrei (“La scuola, come la vedo io, è un organo “costituzionale”) può perciò applicarsi anche alle altre istituzioni culturali, dalle scuole alle accademie ai musei ai teatri. Sottolineo che la centralità della cultura (in tutte le sue accezioni) nel dettato costituzionale comporta una gerarchia di valori, costantemente calpestata da governi di ogni segno che, ogni qual volta occorra effettuare tagli di bilancio, cominciano proprio dalla ricerca, dalla tutela, dall’università, dalla scuola.
Lo statuto costituzionale della proprietà, definito dall’art. 42, antepone la proprietà pubblica alla proprietà privata, e stabilisce per quest’ultima un forte limite assegnandole una funzione sociale. La Costituzione non menziona espressamente la proprietà collettiva (i “beni comuni”). Quello dei beni comuni è un tema che ha oggi una crescente risonanza, e pertanto è bene chiedersi come mai nella Costituzione non se ne parli espressamente. Per intendere la formulazione dell’art. 42 secondo l’intenzione di chi lo scrisse, occorre richiamare il dibattito in Costituente su questo punto. Il relatore Taviani (Dc) lo introdusse ragionando sul “bene comune”, inteso come valore:
Quando lo impongano le esigenze del bene comune […] la legge può riservare alla proprietà collettiva – dello Stato, delle regioni, dei comuni o di altri enti di diritto pubblico – le imprese e i beni di determinati e delimitati settori dell’attività economica (III sottocommissione, 25 settembre 1946).
Per definire il “bene comune”, Taviani citò la Costituzione della Repubblica di Weimar (1919): “La proprietà comporta obblighi. Il suo uso dev’essere al tempo stesso un servizio reso nell’interesse generale” (art. 154). Secondo Taviani, “la destinazione dei beni della terra all’uso comune è primaria rispetto al diritto di proprietà privata”, anzi “alla base dell’ordine naturale dell’economia sta il diritto di tutti all’uso comune dei beni” e la Costituzione deve sancire “la razionale valorizzazione del territorio nazionale nell’interesse di tutto il popolo” “al fine di stabilire più equi rapporti sociali”. Nessuno mise in dubbio questo principio, e per sottoporre anche la proprietà privata all’interesse generale si proposero formule come vantaggio della collettività (Fanfani), interessi della collettività (il comunista Assennato), interesse collettivo (Aldo Moro), finché prevalse la dizione poi rimasta nell’art. 42, funzione sociale.
In quel contesto furono chiamati in causa gli “usi civici” (indubbiamente una forma di beni comuni) ma su questo punto le opinioni furano divise. Il Dc Mannironi voleva attribuirne la disciplina alle Regioni; Ambrosini (anch’egli Dc, più tardi presidente della Corte costituzionale) raccomandò “la liquidazione definitiva degli usi civici”; Terracini (Pci, presidente dell’Assemblea) difese gli usi civici come “un grande vantaggio per le popolazioni povere”), Conti (Pri) voleva anzi “affermare il diritto delle popolazioni a essere reintegrate di quanto è stato loro rapinato”. Per Calamandrei e Terracini gli usi civici dovevano essere disciplinati non dalle Regioni ma dallo Stato, onde evitare “ai ceti degli espropriatori di ancor maggiormente consolidare gli atti arbitrari che hanno fin qui compiuto”, appropriandosi di suoli prima destinati all’uso civico. Per far posto nella Carta agli usi civici, si tentarono formule come “proprietà delle comunità di lavoro” o “proprietà cooperativa”, ma senza trovare un accordo. La Costituzione finí dunque con l’eludere il nodo di questo “altro modo di possedere” (distinto sia dai beni pubblici che dalla proprietà privata), conservandone tuttavia qualche traccia, come le “comunità di lavoratori o di utenti” che possono essere titolari di imprese per “fini di utilità generale” (art. 43); la “ricostituzione delle unità produttive”, con riferimento alla piccola e media proprietà (art. 44); la “funzione sociale della cooperazione” (art. 45) e l’incoraggiamento della “proprietà diretta coltivatrice” (art. 47).
Al centro dell’attenzione dei Costituenti non erano gli usi civici ma un tema di ben più ampia portata: come definire i regimi di proprietà in armonia con il disegno generale della Costituzione, e come assegnare alla proprietà privata un ruolo coerente con l'”interesse generale del popolo”. Con ampia intesa sui principi di fondo, i Costituenti cercarono una formulazione che garantisse la proprietà privata, ma finalizzando anch’essa al bene comune. Il socialista Giovanni Lombardi propose di non menzionare affatto la proprietà privata, garantendo nella Carta “la sola proprietà gestita da conduttori e lavoratori diretti o da cooperative”; ma subito vi si oppose Togliatti, con l’argomento che
si sta scrivendo una Costituzione che non è la Costituzione socialista, ma corrisponde ad un periodo transitorio di lotta per un regime economico di coesistenza di differenti forze economiche che tendono a soverchiarsi le une con le altre [I sottocommissione, 16 ottobre 1946].
Perché la proprietà privata fosse riconosciuta dalla Costituzione, ma anche indirizzata al bene comune, era importante metterla in gerarchia con altre forme di proprietà che al bene comune fossero primariamente orientate. In questo senso Taviani richiamò la proprietà collettiva, che per lui era equivalente a proprietà pubblica o demanio; ma su questo punto non c’era consenso. Per altri, “proprietà collettiva” si riferiva agli usi civici ed era sinonimo di proprietà cooperativa; per altri ancora evocava il temuto spettro delle collettivizzazioni sovietiche. Si decise allora di puntare tutte le carte sul lemma più forte, quello della proprietà pubblica, e si giunse alla secca formulazione finale dell’art. 42: “La proprietà è pubblica o privata”. In essa, osservò polemicamente Lombardi, non resta “alcuno spiraglio per una proprietà collettiva”, ma Dossetti gli rispose osservando che “lo Stato rappresenta la forma suprema di attività collettiva”; perciò la proprietà collettiva poteva essere tacitamente assorbita nella proprietà pubblica. L’art. 42 stabiliva così una forte gerarchia fra proprietà pubblica e privata. La proprietà pubblica serve, senza che vi sia bisogno di dirlo, l’interesse generale, mentre alla proprietà privata si pongono precisi limiti “allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”. Risolutiva per giungere a questa formulazione finale fu la categoria giuridica della sovranità (altro tema tornato di attualità, e che bisogna provare a leggere secondo Costituzione).
Secondo una concezione ricca di precedenti ma sviluppata fra le due guerre dal grande giurista Donato Donati, il titolare della sovranità (il re o il popolo) ha il dominio eminente sull’intero territorio, e la proprietà fondiaria individuale va intesa come una sorta di concessione, che riduce ma non cancella la pienezza del suo dominio. Nella nuova Repubblica, il territorio nel suo insieme andava dunque inteso come res communis la cui appartenenza originaria spetta al popolo, titolare unico della sovranità. Fu alla luce di questa dottrina che i Costituenti individuarono la “funzione sociale” come principio organizzatore dei regimi di proprietà, fissando una conseguente gerarchia di valori: la proprietà pubblica, per definizione in usu populi secondo le categorie del diritto romano, è di per sé indirizzata alla “funzione sociale” ma deve esserlo, per quanto in subordine, anche la proprietà privata.
In un arco politico amplissimo, dai democristiani ai comunisti, si convenne in Costituente su una concezione dei beni economici come garanzia dei diritti dei cittadini e della libertà dello Stato. Lo statuto costituzionale della proprietà, disse Togliatti, deve assicurare “le uguali condizioni di esistenza dei cittadini, la libertà dei cittadini e quella dello Stato stesso”. Ancor più forti le affermazioni di parte cattolica: “un controllo sociale della vita economica è una necessità assoluta imposta dalla vita, al fine di temperare e ridurre gli egoismi dei detentori dei mezzi di produzione” (Dossetti); solo la funzione sociale della proprietà assicura “un ordinamento economico e sociale il quale garantisca il diritto al lavoro, il diritto alla vita” e “una dignità effettiva e non astratta della persona umana” (La Pira); “non è possibile permettere che gli egoismi si affermino, ma è necessario porre la barriera dell’interesse collettivo come un orientamento e un controllo di carattere giuridico”, perciò il diritto di proprietà dev’essere “finalizzato costituzionalmente, nel senso di permettere un coordinamento della vita economica per il benessere di tutti” (Moro). Sovranità popolare, dominio eminente del territorio e “funzione sociale” a garanzia dei diritti sono i presupposti costituzionali del regime di proprietà fissato dall’art. 42.
Il sistema fissato dagli articoli “economici” della Costituzione comporta e stabilisce una chiara gerarchia di valori costituzionalmente garantiti: la proprietà privata e la libertà delle imprese, certo, ma la dignità dei lavoratori-cittadini e la difesa della loro salute in primissimo luogo. Perciò, ove sorgano conflitti fra questi due ordini di valore, l’interesse generale come fissato dalla Costituzione impone di dare la priorità alla salute e dignità dei cittadini-lavoratori. E questo, lo sappiamo benissimo, non è un tema astratto: Taranto insegni.
Secondo voci interessate o servili, i Trattati europei hanno stravolto questo orizzonte dei diritti. Non è vero. Anzi, dice lo stesso Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, “i Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri”. In altri termini, secondo i Trattati, il regime di proprietà vigente in ciascuno Stato non può essere modificato da norme europee; e le norme europee sono applicabili in ogni singolo Stato solo se compatibili con la sua Costituzione. Ha torto chi ritiene che le norme europee siano sovraordinate non solo alle leggi ordinarie dei singoli Stati, ma alle stesse loro Costituzioni e che, chissà perché, l’art. 345 del Trattato debba restare lettera morta. Al contrario, la sovranità nazionale con le sue caratteristiche (quanto meno quelle di rango costituzionale) dev’essere pienamente esercitata anche nel quadro europeo. L’Europa non è un impero esterno che, dopo aver conquistato gli Stati membri, possa imporre manu militari un proprio sistema di regole difformi dall’ordinamento di ciascun Paese. Dev’essere un concerto di voci, anche dissimili, in cui ogni Paese possa portare la propria tradizione culturale, civile, giuridica. Anche l’Italia.
Mi avvio a concludere. Come ho detto al principio, c’è una luce che illumina la Costituzione: il bene comune come valore, definito come “interesse generale” o “utilità sociale” e strutturato secondo quattro punti cardinali: popolo, lavoro, sovranità, diritti. Il popolo è (in quanto sovrano) la fonte dell’ordinamento, ma anche il titolare dei diritti. In una “Repubblica democratica fondata sul lavoro”, il cittadino-tipo a cui pensava il Costituente fissandone il perimetro dei diritti è il cittadino-lavoratore. La sovranità popolare è determinante nella mappa costituzionale del bene comune perché comporta il dominio del territorio, in particolare dei beni pubblici e dei beni comuni, e il controllo della funzione sociale della proprietà privata. La proprietà (in particolare quella pubblica) deve essere indirizzata ai fini costituzionali supremi, e dunque a garantire i diritti dei cittadini, titolari della sovranità. E fra questi diritti hanno un posto centrale il diritto al lavoro, il diritto alla cultura, che assicura la mobilità sociale, e il diritto alla salute finalizzato anche alla “pari dignità sociale” dell’art. 3.
La domanda che dobbiamo dunque porci, di fronte a qualsiasi tentativo di svilire la Costituzione o di metterla in soffitta, è se la promessa di futuro che essa contiene si stata adeguatamente soddisfatta (e certo non lo è stata), o se sia da considerarsi tramontata per sempre. Il 2 gennaio 2010, Renato Brunetta, allora ministro per la Funzione Pubblica. dell’ultimo governo Berlusconi, dichiarò a Libero che “Stabilire che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro non significa assolutamente nulla”. Per lui, la riforma della Costituzione (allora ritenuta imminente) dovrà riguardare anche la prima parte, “a partire dall’articolo 1”. Per il ministro “la parte valoriale della Costituzione ignora temi e concetti fondamentali, come quelli del mercato, della concorrenza e del merito”. Nei ricorrenti attacchi alla Costituzione, credo che sia questo il punto più basso mai raggiunto negli scorsi decenni. Chiediamoci dunque: è questa la strada da percorrere o, all’opposto, dovremmo ricordarci che nella Costituzione i cittadini-lavoratori italiani trovano un lungimirante manifesto dei propri diritti? Perché questo è la nostra Costituzione: un manifesto già pronto, una promessa di futuro, un progetto di società.
Se vi stiamo ricorrendo così poco è perché ne stiamo dimenticando le origini, la forza e lo statuto supremo, al vertice dell’ordinamento. Perché ci siamo rassegnati a pratiche di governo che ignorano i diritti costituzionali dei cittadini, sottoponendoli al dispotismo dei mercati; usano i beni comuni e la proprietà pubblica asservendoli al profitto privato a scapito del bene pubblico; giustificano questa abdicazione con la pretesa priorità delle norme europee. Davanti a tanto stravolgimento dei principi, dobbiamo fare della Costituzione il manifesto dei nostri diritti. Anziché puntare su un’Europa fondata solo sulla contabilità dei mercati, dobbiamo portarvi la ricchissima dote ideale, giuridica e culturale di un alto sistema di principi e di diritti, quello della nostra Costituzione. Dobbiamo chiederci con urgenza quali mezzi abbiamo noi, i cittadini, di richiamare chi ci governa al rispetto della Costituzione e del bene comune. Dobbiamo esplorare se e come sia praticabile un diritto di resistenza attiva, un’azione collettiva per la Costituzione e per il bene comune.
Il più genuino spirito della tessitura di norme della Costituzione è infatti distillato in un articolo sul diritto di resistenza, che fu proposto in Costituente ma non entrò nel testo finale. È un paradosso solo apparente: l’articolo che vi leggerò infatti, non fu incluso nella Carta non perché fosse estraneo al suo spirito, ma perché si ritenne che quegli stessi principi fossero già stati enunciati a sufficienza nella tessitura generale del testo, e non occorresse ripeterli. Perciò questo articolo, allora proposto da Giuseppe Dossetti, può restituirci, nel suo dettato carico di energia morale, una sorta di interpretazione autentica che può ancora essere di ispirazione a chi ha a cuore il bene comune. Eccolo:
La resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino.
Ecco: a me pare che sia oggi più necessaria che mai una profonda consapevolezza dell’orizzonte dei diritti garantiti dalla Costituzione. Se avessimo questa consapevolezza, dovremmo rispettare questo articolo “assente” come se fosse anch’esso inciso tra i principi della nostra Carta Costituzionale. In nome di un’Italia migliore: quella dei Costituenti, certo, ma anche quella di un possibile, auspicabile traguardo futuro.
Questo articolo, pubblicato da Rassegna.it il 22 settembre 2019, è il testo integrale della lectio magistralis tenuta da Salvatore Settis nel corso delle Giornate del lavoro della Cgil che si sono svolte a Lecce