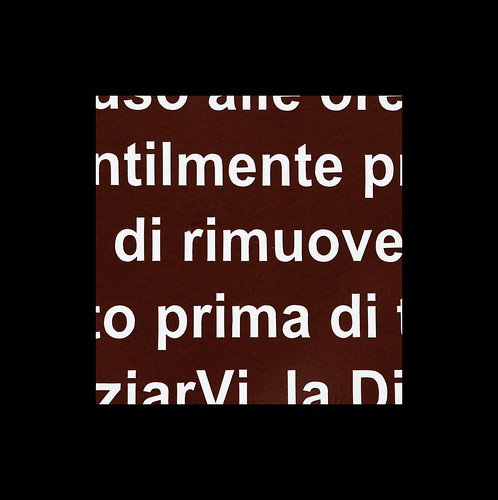 di Maurizio Matteuzzi
di Maurizio Matteuzzi
Se la meritocrazia vuole essere il governo dei migliori, si impone poi un’altra problematica estremamente scabrosa. Migliori rispetto a quali proprietà? E, ammesso che si possa rispondere con coerenza e in modo adeguato a questa difficilissima questione, dovremo poi chiederci quali siano i mezzi per individuare tali pretesi migliori, e, infine, se tali mezzi siano a nostra disposizione. Banalmente, si seleziona meglio con un tema, o con i quiz a domanda multipla?
Meglio una monografia o cinque articoli? È più importante dimostrare un teorema di matematica o scoprire la volatilità di un composto chimico? E di Leopardi, poi, che ne facciamo? Meglio uno che sappia il greco, o magari invece ci confonde le idee? Il tema, proposto volutamente in termini paradossali, è tuttavia estremamente cogente; e può essere affrontato razionalmente, se si vogliono perseguire risultati effettivi e in tempi ragionevoli, solo pagando un tributo al pragmatismo (in senso filosofico): un’idea è tanto migliore quanto migliori sono le conseguenze che determina.
Così, nello spirito di “How to make our ideas clear”, proviamo a pensare, comparativamente, al processo di reclutamento che si avrebbe ad Harvard e alla Sapienza, a fronte del bisogno di un nuovo insegnante, per una materia fondamentale e imprescindibile, per esempio per l’improvvisa dipartita del precedente titolare (non necessariamente nefasta; poniamo sia scappato con una ballerina russa). Amor di patria mi impone di non sviluppare il narrato nei dettagli. Da un lato l’agile e immediata analisi delle “teste” migliori sulla piazza, la trattativa, l’accordo; due tre mesi e il processo è concluso, gli studenti avranno un buon corso, e un docente, forse non il migliore in assoluto, ma un buon docente.
Vogliamo fare una simulazione del processo italiano? Blocco del turn-over, settori disciplinari, superamento delle mediane, abilitazione, chiamata locale, punti-organico… Ammesso (e tutt’altro che concesso) che si possa prima o poi uscire dall’attuale stato di coma profondo in cui è ora incagliata la procedura, poniamoci alcune semplici domande: a) quanto tempo è durato il processo? b) gli studenti avranno nel frattempo avuto un “buon corso”? c) avremo selezionato il migliore, o, quanto meno, un “buon” insegnante?
Poi c’è il fattore del periodo: dal 2008 al 2012, ciccia, nessun reclutamento. E allora come si fa? Prendiamo Tizio, che fa solo 60 ore, e quindi possiamo costringerlo a farne altre 60. Manca analisi I per ingegneri? La affidiamo a lui, tanto un po’ di matematica la sa. Magari studia e insegna altro, ma è dello stesso settore disciplinare, si arrangerà. E il povero Tizio, se non riesce a rifiutare, come farà? Ma ci sono migliaia di precari alle porte che hanno una borsa di studio, o stanno facendo il dottorato, Tizio farà fare metà delle lezioni a uno di loro, e studierà un po’ per fare lui le prime lezioni, giusto per salvare la faccia… E che ingegnere verrà fuori? Meglio non ne parliamo.
a è tempo di recuperare un po’ di allegria, giusto per non cadere in quella che Kierkegaard chiamava la malattia mortale, la disperazione. Proviamo a immaginarci di raccontare il processo suddetto a un collega di Harvard, e immaginiamoci la sua faccia. C’è Caio, che è un genio in analisi I, ed è anche libero. Perché non lo potete assumere? Ma perché non supera le mediane! Le mediane… spiega. Ecco, vedi, in Italia il calcio è lo sport nazionale, e così abbiamo anche il calcio femminile, con il suo campionato. Così le mediane sono quelle che giocano a centrocampo, vuoi opporti allo sport nazionale? Socmel: pardon, soccer. ! E cosa vuol dire che non è dello stesso SSD? Se tutti sanno che è un genio in matematica… Sì ma vedi, vuoi mettere l’importanza dell’SSD?
Noi non siamo mica dei selvaggi come voi, noi abbiamo la tavola sistematica dello scibile, la tavola di Mendeleev della conoscenza. Che poi manchino completamente intere aree oggi all’avanguardia, come le scienze cognitive, o che nel file di tutte le declaratorie delle discipline (allegato B per gli addetti ai lavori) manchi la parola “mente”, e quindi non si possa dare, ad esempio, un insegnamento di “filosofia della mente”, è un mero accidente storico, una banale distrazione. Così come manca “Mind” nell’elenco delle riviste di filosofia di fascia A. Distrazione che verrà sanata quanto prima, come spiegano dotti colleghi nelle loro “considerazioni filosofiche”(cfr. http://rstampa.pubblica.istruzione.it/utility/imgrs.asp?numart=1MGXB7&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1).
In compenso abbiamo assimilato, e dunque, concorsualmente uguagliato, discipline come estetica, semiologia, filosofia del linguaggio, linguistica… Un bel frullato di cavoli, merende e cocomeri. Oppure logica e storia della scienza, che c’entrano come il diavolo, l’acqua santa e le angurie, tanto per schierarci per la variatio rispetto alla concinnitas. Il tema della gerarchia delle scienze è un classico della storia del pensiero, e ci si sono cimentate le menti più eccelse, a partire dai Secondi analitici di Aristotele. E che dire di Leibniz? E degli enciclopedisti del ‘700? Enormi sforzi profuse poi su questo il positivismo, a cominciare da Comte, padre fondatore modernamente.
Ogni teoria, pur con tutta la sua forza esplicativa, le preziose analisi e i suggestivi suggerimenti, è passibile di critiche radicali, ha forti componenti ideologiche (si confrontino la gerarchia delle scienze del positivismo e quella contemporaneamente esposta da Benedetto Croce); nessun pensatore, per quanto geniale, ha raggiunto compiutamente il suo scopo, e la materia è oggetto del dibattito ora più che mai. Mentre invece il MIUR l’ha risolta, e, forse per evitare le strida dei beoti, o per tema dell’accusa di millanteria, o forse anche per perfidia, non lo notifica al mondo.
(Segue)








