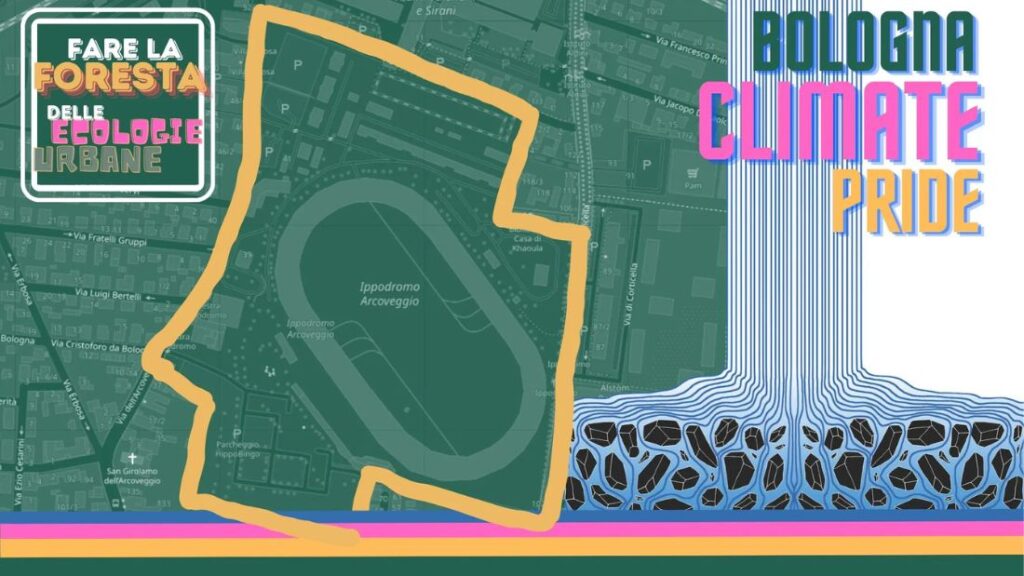Nonostante la ormai palese crisi in atto del servizio sanitario e più in generale di quel complesso di misure di assistenza, previdenza, riparo sociale che siamo soliti definire welfare, non pare emergere nella società nel suo insieme, oltre il rivendicazionismo categoriale, un movimento coerente, partecipato e coeso, in grado di incidere in maniera significativa sulla tendenza dissolutoria in atto. Piuttosto, varie forme di movimento sono impegnate talvolta a moltiplicare la frammentazione, il mondo dell* professionist* si divide tra esprimere istanze di blando riformismo compatibile o intimorite sensibilità di difesa conservativa nei fatti – perchè sganciata da una critica dei vari poteri sedimentati – che nell’attuale sistema sanitario troppo spesso suona come “un tenersi quel che c’è, pur di non perdere troppo”.
Il “coraggio di cambiare”
In questa fase storica vediamo delinearsi a livello nazionale varie traiettorie di arretramento sociale e politico (attacco al reddito di cittadinanza, irrigidimento delle disuguaglianze di genere e redistribuzione “verso il basso” dei costi della riproduzione sociale, processi di razzializzazione violenta – per esempio nei discorsi e nelle politiche sull’accoglienza) che coesistono con isolati e frammentari processi “progressisti” o vagamente neo laburisti a bassa intensità, destinati perciò stesso a sfociare in un generico riformismo – spesso solo di natura tecnicistica. Sul piano dei movimenti la questione di genere e quella ecosistemico-ambientale sembrano oggi le uniche capaci di produrre vitalità, riflessione in direzione unitaria, ma senza che questo abbia prodotto finora significativi agganci a linee strategiche e mobilitazioni generalizzate, forse a causa di un dibattito interno ancora arretrato sulla coesistenza o priorità di alcune pratiche su altre. A questo si accompagna una lettura in affanno sui temi del welfare e della sanità, vale a dire i più importanti ambiti di “messa a terra” delle questioni relative alla cura e alla riproduzione sociale.
La città di Bologna offre un osservatorio particolare sul rapporto tra welfare, movimenti, politica e sopratutto gestione dei livelli amministrativi intrecciati con quelli di natura aziendalistica, privata o semipubblica che sia. La dimensione di questi fenomeni appare particolarmente rilevante se prendiamo questi temi in una evoluzione storica, osservabile dagli archivi e dalla sedimentazione delle lotte e delle riforme. In un contesto relativamente piccolo si possono inoltre osservare potenzialità e rischi legati allo spazio politico inedito che contraddittoriamente caratterizza la città. Bologna, eletta a spazio privilegiato di esercizio di governance partecipativa, gestita, mediata, filtrata da vari organismi ed entità di supporto, si pone come la più progressista d’Italia, in un quadro però di compatibilità con una giunta regionale subalterna in gran parte alle logiche dello sviluppo a tutti i costi e neppure troppo ostile in certi settori alla famigerata autonomia differenziata (nonostante il voto finale contrario – maliziosamente potremmo dire, tanto l’esito complessivo opposto a questo voto è ormai scontato), caldeggiata come elisir di Dulcamara contro i deprecati deficit di bilancio nel settore sanitario. Come ha raccontato la mostra documentaria “Il coraggio di cambiare: il welfare a Bologna negli anni Settanta” sul piano delle politiche di sostegno e supporto alle vulnerabilità la città ha una storia importante, in cui si somma l’effetto di almeno tre vettori: 1) la presenza di una forte tendenza alla mobilitazione sociale e alla partecipazione che negli anni ’60 e ’70 ha prodotto grande coinvolgimento popolare sulle questioni della deistituzionalizzazione, della socializzazione del lavoro riproduttivo, della mobilità e dell’urbanistica sostenibile. 2) Una tendenza delle classi dirigenti alla programmazione che, incontrando la partecipazione popolare, ha dato luogo a innovazioni amministrative spesso coincidenti con le proposte più avanzate dei movimenti. 3) La presenza di una forma capillare di partecipazione sociale che si esprime attraverso il volontariato e il terzo settore, le cui radici si collocano in storie di militanza per i diritti civili, di protagonismo e di emancipazione di soggettività marginalizzate, in forme estremamente attive di cristianesimo di base legato ai problemi della comunità. Questi ingredienti, che sospinti e amalgamati in una fase di grande tensione sociale e politica hanno dato luogo al più avanzato sistema di welfare urbano che si sia avuto in Italia, sono gli stessi elementi che in una fase di inerzia e depoliticizzazione dei saperi portano i segni di una complessiva destrutturazione e spesso si muovono facendo girare a vuoto le loro pratiche fondamentali, in una complessiva perdita di senso e di visione.
Movimenti e politica
Bologna è la città in cui un pezzo di movimento collabora con la giunta cittadina all’interno di una aggregazione civica e contemporaneamente un altro pezzo di movimento contesta attivamente questa strategia. Anche in altre città pezzi di movimento hanno aderito o promosso processi di formalizzazione e costruzione di “liste” (Roma, Padova, Trieste, Napoli), in differenti rapporti con le amministrazioni comunali o municipali; non è chiaro oggi fino in fondo quali siano i possibili ambiti di confronto a livello nazionale sull’andamento di questi percorsi, nei quali si possa sviluppare una verifica pubblica di queste strategie. L’esistenza di un spazio di dibattito siffatto – venuto meno anche per la destrutturazione delle “aree di movimento” con i loro organismi sovra-locali, costituirebbe una prima urgenza da affrontare: a un vecchio contenitore identitario correttamente superato non si è sostituito un nuovo che sarebbe invece auspicabile. O meglio, si assiste ad un rapido logoramento con conseguente senescenza di slogans quali “agisci localmente e pensa globalmente”, per la difficoltà di attivare forme di osservatorio permanente inerenti l’incidenza più ampia di processi incontrollabili anche nelle prassi locali più virtuose.
L’amministrazione di Bologna, a questo proposito, intrattiene rapporti stabili con le altre città europee guidate da giunte di sinistra come Barcellona e Berlino; bisogna già qui osservare però che se si paragonano le azioni intraprese in altre città dai gruppi dirigenti per sottoporre al controllo pubblico alcune dinamiche urbane (tassazione degli affitti brevi turistici, tassazione delle consegne ai danni delle grandi piattaforme di distribuzione, ultra tassazione a chi lascia gli immobili vuoti, trasporto pubblico gratuito, ecc) si vede come la giunta locale abbia utilizzato ben poche delle leve che potrebbero essere a sua disposizione per invertire le tendenze nel rapporto tra politica ed economia, forse perchè la caratteristica stessa della città non sembra essere quella di un governement progressista, ma di una governance che come tale ingloba già pezzi di economia entro il processo selettivo delle priorità e delle decisioni.
Questa governance che strutturalmente non può per ora essere del tutto attenta alla mobilità sostenibile, pur mettendo in campo lodevoli progettualità quali la bicipolitana, il tram e la “Città Trenta”, ha creato il “caso” del Passante di Mezzo, osteggiato sia dalla destra per motivi reazionari sia dai movimenti ambientalisti per l’assenza di una visione complessiva in cui il progetto possa risultare credibilmente compatibile con un’idea di città ecologista e sociale. Su questi temi, la grande manifestazione del 22 ottobre seguita alla chiamata “Convergiamo per insorgere” lanciata dal Collettivo di Fabbrica GKN di Firenze ha mostrato quanto fosse alta la disponibilità popolare ad essere present* in una piazza conflittuale, anche (e soprattutto) oltre le identità di movimento preesistenti e oltre la questione in sè – su cui invece la convergenza delle “strutture di movimento” a livello locale non è affatto scontata. Nei mesi seguenti, se si esclude la mobilitazione transfemminista dell’8 marzo, nessuna altra iniziativa pubblica di movimento è riuscita a raggiungere una tale estensione nella partecipazione, o ad aggregare un “target” che travalicasse i confini delle singole strutture e delle loro pur esigue giustapposizioni. Dobbiamo anche escludere il tema della guerra, che ha visto negli ultimi mesi assestarsi una geometria “pacifista” (capace di smarcarsi sia dall’identificazione dell’aggressione Russa come un giustificato atto di resistenza contro la Nato, sia dall’acritica adesione alla richiesta di armamenti che viene dal nazionalismo di stato Ucraino) solo grazie a una forte presenza del mondo cattolico e provocando anche una certa divaricazione nel Partito Democratico locale (quantomeno rispetto alle piazze in cui si sceglieva di fare presenza). Fatti salvi questi interessanti fenomeni, i mesi successivi hanno comunque mostrato episodi di mobilitazioni sui temi legati al welfare e alla riproduzione sociale su cui può essere interessante riflettere.
A partire dall’autunno del 2022 Bologna è stata investita da una riattivazione delle lotte sugli spazi sociali e la casa. La situazione drammatica in termini di rincaro degli affitti e di generale erosione delle disponibilità economiche della cittadinanza è stata interpretata dai movimenti attraverso una serie di occupazioni a fini sociali e abitativi. Una osservazione sulle diverse tattiche e strategie di movimento in questo ambito può dare una rappresentazioni delle tensioni che attraversano in questa fase le diverse linee politiche nel loro complesso. Tre delle occupazioni che hanno avuto luogo negli ultimi mesi del 2022 sono state sgomberate con ingenti interventi delle forze dell’ordine e non sono esitate in alcun tavolo di trattativa con le istituzioni comunali, che invece si sono poste in modo interlocutorio con l’occupazione di Luna e Labas Casa Vacante, svolta a fini abitativi in un edificio di proprietà della Azienda pubblica di servizi alla persona Città di Bologna. Negli stessi giorni il collettivo autonomo Cua ha invece occupato due complessi abitativi para-privati (una di un’immobiliare che offre servizi alberghieri all’Ateneo, da cui il collettivo è uscito dopo due giorni in vista di un possibile tavolo di trattative; l’altra una comproprietà università-privato da cui il collettivo è stato sgomberato con la forza pubblica) affermando in pratica che il conflitto dovesse superare il ruolo di mediazione dell’ente pubblico (letto come ruolo limitato e “di facciata”, incapace cioè di gestire vere leve di comando sui processi economici che incidono sull’esigibilità del diritto alla casa) e solo questo potesse spostare i rapporti di forza; in un’ottica vicina a quest’ultima il collettivo anarchico Infestazioni ha svolto due occupazioni di stabili industriali da lungo tempo dismessi, di proprietà di privati e un’ultima occupazione di un locale di proprietà di Acer, murato da circa nove anni e – incredibile in un periodo in molti inquilini Acer hanno difficoltà a pagare le bollette – con il riscaldamento acceso. L’uscita volontaria dal luogo occupato e l’apertura di una trattativa con le istituzioni da parte dei collettivi legati a Municipio 0 si può leggere come un tentativo da parte del movimento di riconfigurarsi come corpo intermedio nella governance cittadina, in funzione competitiva con quelli esistenti. Questa tendenza a ricostituirsi come corpo intermedio si può leggere anche nella mobilitazione sindacale delle operatrici e degli operatori sociali legati a Adl Cobas che, oltre a seguire singole vertenze, ha promosso una “carta dei diritti” con l’obiettivo di influenzare le modalità di definizione degli appalti dei servizi, limitatamente al comune di Bologna.
Questa strategia apre a due domande: la costituzione di questo pezzo di movimento come “corpo intermedio” si ridurrà all’esito di “rimpiazzare” una casella della governance locale, lasciandone immutata la direzione, oppure riuscirà ad incidere sui suoi orientamenti complessivi in termini di produzione di servizi e opportunità, di creazione di nuovi strumenti emancipatori per le fasce più fragili e meno riconosciute della popolazione? In altri termini, se un pezzo di movimento punta a giocare la sua agency politica anche attraverso il riconoscimento di un ruolo sociale di 1) organizzazione e indirizzamento del conflitto, 2) capacità di gestione dei bisogni e delle istanze sociali in modo direttamente competitivo con il mondo storico della cooperazione e con le parapubbliche a cui è stata delegata la gestione del welfare in termini aziendalistici, quali nuove leve di controllo e sopratutto coordinamento questa azione può produrre ai fini di una auspicabile innovazione di governance territoriale nel suo insieme? Detto ancora diversamente, si scioglierà in forme evolutive la dialettica per ora ingessata tra Reti e Sistema? E ancora, quali strumenti di controllo polare, di partecipazione allargata, di destrutturazione delle modalità attuali di processo che ci hanno portati fino alla situazione attuale – ci assicurano per esempio che lo studentato promesso da Comune e Asp una volta ottenuta la liberazione dell’occupazione di Casa Vacante sarà gestito con ottiche più vicine ai bisogni sociali e meno alla speculazione? Seconda domanda: tale commistione con la governance locale si declinerà in una mera differenziazione tra “occupazioni buone” e “occupazioni cattive” – o tra “centro” e “periferia” della Città Metropolitana nel caso della Carta dei Diritti, essendo essa relativa al solo Comune di Bologna – indebolendo complessivamente la capacità di incidere del movimento e l’ambito geografico della sua azione? Se la tattica nel campo dell’abitare fosse stata quella di puntare ad una possibile forma riconoscimento pubblico della pratica dell’occupazione in sé, da valutare nei casi e nelle forme che si presentano, diverso sarebbe il senso ultimo del contribuire all’elaborazione di una delibera sull’uso pubblico degli spazi, lottare collettivamente per la riscrittura di un piano urbanistico. Parimenti, se le vertenze sul lavoro sociale fossero state seguite congiuntamente ad altre realtà sindacali di base la cui azione si concentra maggiormente sul resto della Città Metropolitana, non si sarebbe potuta configurare una strategia di più ampia rivolta a ricostruire l’ampiezza del movimento esistente per una messa in discussione più generale dei risvolti economicistico produttivi che inerisce anche i servizi stessi, pur definiti a bassa soglia?
Su questo piano si gioca una partita delicata e complessa che riguarda i temi di uno spostamento di rapporti di forza, di riconoscimento dei medesimi, di presa d’atto di mutamenti d’equilibrio, venendo meno a orgogli identitari da cortile e alla pretesa che una sostituzione quasi intercambiabile di ceti politici sia panacea di tutte le forme di disaffezione politica e sociale. L’ipotesi strategica sul rapporto tra movimenti e configurazioni urbane si gioca su una pratica efficace di ascolto e ricognizione di bisogni, sogni e desideri dei corpi sociali in movimento, che non sia pilotata o addomesticata La possibilità di rispondere ad una implicita domanda di partecipazione qualitativamente diversa in termini di strategia di lungo periodo riguarda il tema della vivibilità e sostenibilità stessa del modello città Città di Bologna. Una strategia “di sinistra” che si limiti a preservare la competitività sul piano dei flussi di capitali della “città delle opportunità” (certo, anche della fragilità, chiariscono gli amministratori) rischia di essere uno spazio in cui la principale occupazione è quella di concentrarsi sulla propria fitness individuale per essere pronti a cogliere le suddette opportunità senza gettare mai uno sguardo al fatto che quella stessa produzione di opportunità si fonda in parte considerevole su dinamiche e processi di sfruttamento, marginalizzazione che alla fine producono non solo omologazione culturale e straniamento sociale, proprio l’opposto di quanto ci si prefigge con le strategie del cosiddetto welfare culturale, ma anche un riscontro economico e ambientale a effetto boomerang che finisce per svilire, impoverire i territori e far smarrire loro quelle radici identitarie storiche cui ci si riferiva in incipit. È un problema ampio che riguarda la governance cittadina in molte città “di sinistra”: l’illusione che “attirare più soldi significa vivere meglio” sta condizionando le governance urbane e, come ha scritto recentemente Emanuele Braga in vista del seminario di Effimera “Milano capitale del XXI secolo o metropoli che si avvia al tramonto?”, il caso di Milano ha mostrato che invece “attirare più soldi sta significando vivere peggio. La sinistra al potere da Pisapia a Sala ha pensato di poter chiedere al privato di disegnare una città più bella e più giusta. Ma questo non è possibile. Chi ci ha creduto si è scottato, chi lo ha fatto in mala fede si è semplicemente arricchito. Una sorta di speculazione finanziaria dal volto umano… non ha retto e non reggerà”. Non abbiamo trovato nessun modo credibile per fare in modo che coesistano sensatamente speculazione immobiliare e redistribuzione della ricchezza, magari attraverso movimenti che si candidano a fare i corpi intermedi impegnati nella gestione “socializzata” delle plusvalenze. Dobbiamo farci i conti. Stare dentro la governance non è sbagliato in generale e forse è l’unico modo per intercettare dei processi reali, ma bisogna avere chiaro starci dentro a fare che cosa.
La sanità più di sinistra d’Italia
Un banco di prova delle contraddizioni e dei limiti di queste tattiche e strategie sarà costituito a Bologna nei prossimi mesi dalla situazione sanitaria. Nella città più progressista di Italia avvertiamo in questi mesi una notevole “mobilitazione dall’alto” ovvero sul piano di un dibattito non ancora sentito dal basso, ma tutto agito nelle stanze dei bottoni, nei convegni tecnici, nei think tanks di settore e sulle pagine dei giornali a proposito dei rimborsi pubblici da garantire alla sanità ospedaliera privata, la cui funzione centrel – ormai non tanto sussidiaria ma primaria – viene a più riprese riconfermata come essenziale da pezzi di politica importanti. Questo battage mediatico sembra volerci abituare all’idea che dovremo condividere il piano di rientro economico-sanitario anche se esso produrrà scelte impopolari, perchè sarà importante mantenere i livelli occupazionali delal sanità privata e garantire il suo ruolo centrale nel complesso del servizio sanitario, pena il crollo di un modello di armonica mediaizone pubblico-privato e la crescita esponenziale delel liste d’attesa per tutte le prestazioni specialistiche. Nel frattempo le pubbliche istituzioni sono impegnate a promuovere case della comunità, psicologi, cure intermedie, con un processo che però interessa pochissimo il dibattito pubblico nel merito. Non emerge mai, per esempio, l’idea che un piano di rientro economico possa essere l’occasione per modificare l’equilibrio esistente tra prestazioni ospedaliere e prestazioni territoriali; il riordino aziendale da più parti paventato (cioè l’unificazione tra azienda ospedaliera e azienda territoriale) si sta sviluppando fuori dai contesti di discussione pubblica, con l’unica conseguenza di lasciar intendere che il nuovo aggregato aziendale non sarà uno spazio in cui possa essere rimessa in discussione la relazione tra ospedale e territorio. In poche parole gli attori della società civile sono chiamati a collaborare con un discorso che difende lo status quo dietro una serie di dichiarazioni dalla natura impalpabile sulla territorialità, le comunità e la partecipazione. Ad avere la più precisa rappresentazione mediatica è invece la battaglia che il privato sanitario convenzionato sta intrattenendo per ottenere mantenimento della spesa ospedaliera ad esso destinata (superiore a quanto definito dalle indicazioni nazionali) e magari anche ad allargare il suo bacino di investimento, approfittando del sostegno pubblico ai nuovi muri della sanità territoriale.
In una fase così complessa le mobilitazioni sul piano sanitario richiedono che si vada oltre strategie limitate al protagonismo o all’egemonia di un singolo ceto politico per elaborare delle prassi e delle forme di azione pubblica che travalichino gli ambiti e i silos di competenze, permettendo la costruzione di poteri diffusi, saperi e pratiche alternative in un’ottica di con-ricerca e ricerca-azione dal basso. Nei servizi e nei luoghi di formazione, pur se frammentati da un trentennio di aziendalizzazione spinta che ha ridotto l’organizzazione quasi a mero conteggio delle prestazioni, esistono soggettività impegnate nel mantenimento di un orizzonte pubblico delle epistemologie e delle prassi, che faticano a trovare interlocutori fuori dall’ambito sanitario.
Nei campi delle cure primarie, nel tentativo di rafforzare la capacità di governo e di lettura dei bisogni dei distretti, nella possibilità di una programmazione sociosanitaria integrata, in salute mentale come negli altri campi di intersezione tra sanitario e sociale, si agitano proposte minoritarie ma interessanti, su cui si fa fatica però a salvare l’attenzione pubblica in modo che da questi ambiti possa emergere la forza per proposte alternative sulla riorganizzazione del sistema. Queste soggettività riusciranno a costruire dialogo con i movimenti e con il mutualismo? riusciranno a cogliere il senso di quelle 230 persone ca. intercettate in un anno dal Laboratorio di Salute Popolare? e d’altra parte riusciranno i processi istituzionali di monitoraggio a incontrare forme nuove di azione pubblica? Un percorso come quello di ricerca – azione su “L’equità nel diritto alla salute” riuscirà a legare le energie positive presenti nel servizio sanitario locale con le azioni dal basso rivolte al contrasto alle disuguaglianze di salute nella città di Bologna? è evidente che la possibilità di risposta affermativa a queste domanda passa dall’oltrepassare dei rigidi steccati identitari proponendo una forma di dibattito pubblico allargato. Solo così sarà possibile immaginare di competere con il privilegio di chi detiene il potere economico, organizzativo e scientifico nel campo di prestazioni specialistiche e posti letto rimborsati da ogni Regione d’Italia (si sa, il sistema emiliano romagnolo gode di un certo “turismo sanitario” a suo vantaggio negli ospedali “di eccellenza”) e che oggi è pronto a una battaglia a tutto campo per prendere
pienamente possesso di un servizio pubblico storicamente connivente e mai come ora priva di una visione politica alternativa.
Che qui si giocherà la battaglia politica locale sulla sanità, è stato riconosciuto tra gli altri anche dall* compagnə di Municipio Zero. Ma se sarà impossibile incidere su queste lotte politiche locali “limitandoci a denunciare dall’esterno la strisciante privatizzazione degli ultimi trent’anni, l’inaccettabile blocco delle assunzioni, le condizioni deleterie di lavoro dei servizi appaltati al privato e al privato sociale” (come dicono giustamente da Municipio Zero) e ci sarà bisogno “di alleanze ibride, di nuove forme di dibattito pubblico, di coinvolgimento attivo delle cittadinə e delle lavoratorə”, sarà tuttavia necessario trovare forme di azione pubblica e con-ricerca in cui gruppi di soggetti già attivi nei servizi, già politicizzati nel campo della formazione e della ricerca, con le loro specifiche identità, possano riconoscersi nell’apertura di un processo aperto di co-costruzione, senza lanciare opa egemoniche di sorta, perchè la posta di qualità democratica in gioco attraverso le politiche della Cura è davvero troppo alta. Sarà necessario a questo punto anche incontrare le riflessioni critiche emerse sulla governance partecipativa cittadina e stirare i possibili campi d’azione nell’ambito delle
politiche coprogettate. Un altro campo che oggi langue rispetto alla produzione critica incisiva per via degli steccati identitari tra tattiche che si presentano come inconciliabili.
Anche se il maggiore fermento è quello ai piani alti d’apparato, a caccia della parità di bilancio perduta, esistono processi assembleari diffusi su temi di Salute e Sanità quantomeno nell’Italia del centro Nord e nella grande metropoli partenopea. Tuttavia, nonostante la vasta letteratura sociologica e di antropologia medica in merito, questo assemblearismo diffuso stenta a costruire una ridefinizione aggiornata di questi due ambiti, stenta a dare una lettura complessiva dell’era Covid che tenga debitamente in conto del dispositivo combinato di Antropocene, grandi interessi farmaceutici, divisione internazionale del lavoro, squilibrio ecosistemico, pratiche di controllo sociale e politiche securitarie in grado di accelerare processi di aggressione e ulteriore speculazione sulle fonti energetiche. Difficile oggi affrontare la difesa del servizio sanitario nazionale senza arrivare ad una critica di saperi, poteri e visioni ancorati ad una Medicina più attenta alle patologie piuttosto che alle persone. Una medicina dominante in un servizio sanitario nazionale pronto a trascurare gli esiti negativi e collaterali di prestazioni di cura standardizzate e metodologicamente poco aggiornate. Ricerca, Formazione, Investimenti, Accesso e Accoglienza basati sull’individuo e non sul cittadino, (che potrebbe oggi essere termine fuorviante altrimenti), revisione critica dello status della classe medica, multidisciplinarietà, sembrano trovare posto fino a un certo punto nelle speculazioni e riflessioni di queste assemblee strette tra il rincorrersi di eventi, celebrazioni, occasioni di presidio e di lotta e un aggancio ancora troppo labile con l’utenza.
Neppure l’introduzione nel dibattito medico dei famosi determinanti sociali sembra far effettuare un salto di qualità effettivo al discorso pubblico più diffuso, questo perchè al di là di una sentita esigenza di orizzontalità e maggior collegialità e superamento della separazione tra ambiti, permane tuttavia un nodo irrisolto di rapporto tra medicina ospedaliera e medicina territoriale. Una dialettica che dovrebbe diventare feconda sembra invece avvitarsi su se stessa. Una contrapposizione perniciosa proprio per la spinta alla trasformazione: i luoghi chiusi di cura permangono istituzioni totali, fortemente gerarchizzate, impermeabili ai mutamenti del fuori e la Medicina di prossimità senza gambe efficaci su cui reggersi di fatto non è né efficace, né efficiente ed in più proprio per la sua natura organizzativa difficilmente coagula le famose lotte per lo meno nei modi tradizionali in cui le abbiamo conosciute.
Bisognerà a questo proposito impegnarsi maggiormente in una riflessione molto seria e senza pregiudizi sulle esperienze ulteriori, dal terzo settore e dal privato sociale fino agli ambulatori di Salute Popolare, insieme ai centri studi e alle facoltà umanistiche: in essi si trovano varie forme di reazione a questo vuoto di progettualità e visione, trasversali a molti gruppi. In questa situazione contraddittoria la critica ai saperi si rappresenta in un meccanismo di autocostruzione alternativa – che è già molto importante coinvolga giovani medici, operatori, ricercatori addetti ai lavori, anche se non si esplicita ancora in una presa di parola realmente popolare sui temi del bios di ciascuno e della collettività. A questo proposito da ultimo ci preme sottolineare come i numerosi questionari che si van producendo a livello ufficiale e non, se rappresentano comunque una utile e lodevole messa a valore statistica, tuttavia risultano poco parlanti su questo aspetto di reale autogestione partecipativa dal basso. Come si diceva, una tipologia di inchiesta differente probabilmente condotta con altre figure e soggettività di intermediazione, una presenza maggiore nei luoghi di cura pubblici, privati, popolari che dir si voglia – di competenze diverse che instaurino pratiche narrative, di ascolto, di mutuo auto aiuto, di ricerca esperienziale, costituiscono una nuova possibile frontiera di lotta a meccanismi di esclusione, di stigma che tendono a ripresentarsi sempre non solo nella forma di determinanti sociali ma anche di approcci culturali diffusi: la situazione della salute mentale, le nuove frontiere di ricerca in merito, la deistituzionalizzazione che non è mai finita e in certo senso non può mai finire, sono ancora oggi uno specchio di una situazione sociosanitaria complessiva e forse un volano di cambiamento possibile.
Questo articolo è stato pubblicato su Zic il 21 marzo 2023