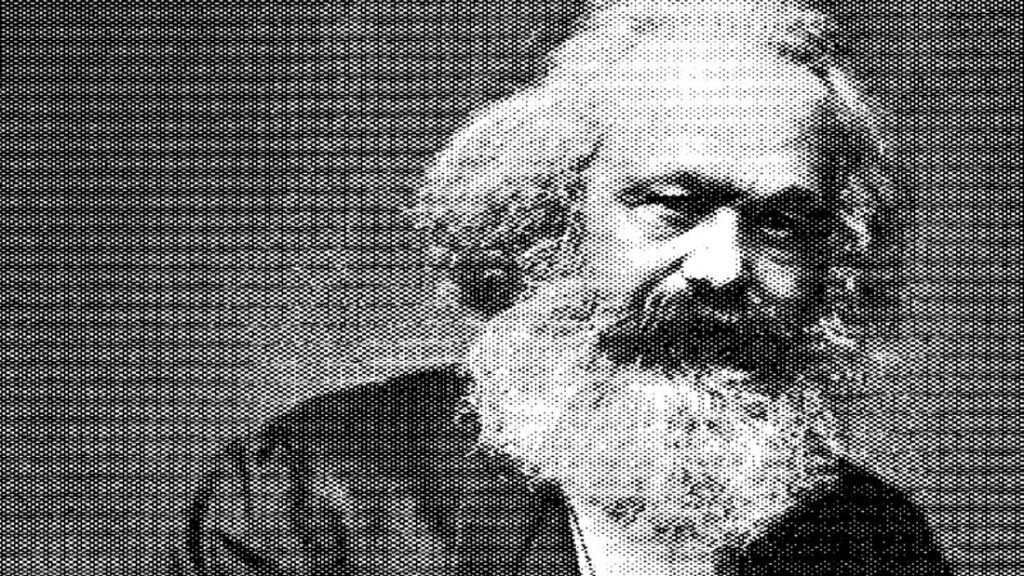Come rapportarsi al sentimento dell’odio generato dalle crudeltà che ci circondano? Bisogna negarlo o provare a governarlo? Una riflessione, Marx alla mano, dello scrittore di fantascienza radicale China Miéville.
Non c’è ragione di soccombere al conforto complesso della disperazione, un rifugio nel lugubre che ci consegna alla sconfitta. Ma sottolineare i ripetuti fallimenti della sinistra è un rimedio inevitabile, data la sua storia di esaltazioni e cazzate, ed evidenziare quanto siano spaventosi e terribili questi giorni, anche se vi possiamo anche scorgere una speranza. Adottare l’approccio liberale e vedere come deviazioni Boris Johnson, Jair Bolsonaro, Narendra Modi, Rodrigo Duterte, Donald Trump, Silvio Berlusconi e i loro epigoni, il violento e intricato «cospirazionismo», l’ascesa dell’alt right, la crescente volubilità del razzismo e del fascismo, significa estrapolarli dal sistema di cui sono espressione. Trump se n’è andato, ma il trumpismo è ancora forte.
Nonostante tutto ciò, vista la recente sconfitta e lo smacco dei movimenti di sinistra nel Regno Unito e negli Stati uniti, causa di profonda depressione e demoralizzazione, questa è stata anche una fase di insurrezioni senza precedenti nelle città americane (e altrove). La storia e il presente sono oggetto di contesa.
Il capitalismo non può esistere senza una punizione implacabile nei confronti di coloro che trasgrediscono i suoi divieti spesso meschini e spietati, e di coloro la cui punizione è funzionale alla sua sopravvivenza, indipendentemente dalla «trasgressione» immaginaria. Dispiega sempre più la repressione burocratica, ma anche un sadismo appositamente congegnato, sfacciato, sopra le righe. Ci sono innumerevoli orribili esempi di riabilitazione e celebrazione della crudeltà, nella sfera carceraria, nella politica e nella cultura. Spettacoli come questo non sono nuovi, ma non sempre sono stati così «sfacciati», come dice Philip Mirowski, «fatti sembrare non eccezionali» – non sono solo una distrazione ma fanno parte di «tecniche di disciplinamento ottimizzate proprio per rafforzare il neoliberismo».
Questo genere di sadismi sociali è sempre stato contrastato e combattuto, e ufficialmente sconfessato – in particolare «in casa», meno dove sono stati ptaticati contro soggetti del dominio coloniale – da strutture che si descrivono come razionali e giuste, persino misericordiose. Ma tutto ciò sta cambiando.
Questo sistema prospera incoraggiando forme di sadismo, disperazione e impotenza. In più, vengono insufflate forme di «felicità» fittizia e autoritaria, di «godimento» grigio e obbligatorio della vita, di spietata insistenza sull’allegria, come scrive Barbara Ehrenreich nel suo libro Smile or Die. Tale positività obbligatoria non è l’opposto di quelle miserie, ne è elemento co-costitutivo. Questo bullismo è una versione di quello che Lauren Berlant chiama «ottimismo crudele», anche a sinistra: nessuna ragionevole speranza guadagnata, ma un’insistenza intimidatoria sulla necessità del pensiero positivo, a costo non solo dell’autonomia emotiva ma dell’inevitabile crollo quando il mondo non è all’altezza di tali vincoli.
In un sistema sociale di crudeltà di massa, che celebra solo i «piaceri» miserabili, mercificati e, in ultima analisi, impoverenti, è perfettamente comprensibile che la sinistra sia ansiosa di sottolineare un diverso tipo e profondità di emozione positiva, di trovare una potenziale opposizione radicale in esplosioni di gioia socialmente destabilizzanti, come versione opposta al sadismo. Per vedere nell’amore un evento sconvolgente e riconfigurante, una motivazione rivoluzionaria chiave.
Dopo tutto, l’etica alla base del socialismo, dice Terry Eagleton nel suo meraviglioso Perché Marx aveva ragione, risolve una contraddizione del liberalismo «in cui la tua libertà può fiorire solo a spese della mia», poiché «[solo] attraverso gli altri possiamo finalmente entrare dentro noi stessi», che «significa un arricchimento della libertà individuale, non una sua diminuzione. È difficile pensare a un’etica migliore. A livello personale, è nota come amore».
In questo senso, l’amare, con uno specifico indirizzo politico, ha ispirato i radicali per un secolo. Nel seminale Largo all’Eros alato!, la grande rivoluzionaria Alexandra Kollontai ha descritto l’amore come «un’emozione profondamente sociale», ha insistito sul fatto che «per un sistema sociale da costruire sulla solidarietà e sulla cooperazione è essenziale che le persone siano capaci di amare», e ha incoraggiato l’educazione a tal fine. Come non considerare, per citare il titolo di un affascinante e provocatorio libro recente, «il comunismo dell’amore?». Attratti dal suo claim secondo cui «ciò che viene chiamato ‘amore’ dai migliori pensatori che si sono avvicinati all’argomento è il cuore pulsante del comunismo?».
Prendiamo l’amore sul serio, con ogni mezzo. Ma dobbiamo prendere sul serio anche i nostri nemici e imparare da loro. In quella che è un’epoca di grande odio. Quali elementi del Manifesto del Partito comunista mettono a fuoco questa barbarie?
Nel 1989, Donald Trump ha suggerito che «forse l’odio è ciò di cui abbiamo bisogno se vogliamo fare qualcosa». Il suo odio era allora, e rimane, un feroce dispiegamento di rancore razzista di classe: una richiesta per l’omicidio giudiziario dei Central Park Five, adolescenti neri falsamente accusati di stupro.
Il contenuto concreto di questo odio è tutto ciò contro cui dovremmo opporci. Ma qual è il modo migliore per contrastare l’odio? Un odio del genere non è forse degno di odio?
Trump è scaltro. Il suo odio ha sicuramente ottenuto qualcosa, anche se non fosse il suo obiettivo iniziale. Forse, ispirato negativamente, il nostro stesso odio dovrebbe fare qualcos’altro, e con urgenza. Qualcosa di molto diverso. L’odio nei confronti di questo odio sistemico.
L’odio nei confronti del potere è giusto
Il filosofo e sacerdote anglicano Steven Shakespeare avverte che concentrarsi sull’odio come qualcosa di diverso da una forza da respingere è «territorio irto» e «pericoloso». Come potrebbe essere altrimenti? L’odio, dopo tutto, è un’emozione che può mandare in cortocircuito il pensiero e l’analisi, può sfociare nella violenza, e non necessariamente con forme di discernimento.
Ma, debitamente attento, Shakespeare punta esattamente l’obiettivo da cui ci mette in guardia, precisamente per «discernere maggiormente l’odio, da dove viene, dove dovrebbe essere diretto e come viene catturato per gli scopi degli altri». Sottolinea in un punto chiave che quell’odio «non presuppone alcuna verità o armonia fondante, ma… sa di essere contro l’altro dominante» è «parte costitutiva della singolarità di ogni essere creato». Il concetto, quindi, di fronte alla storia umana, è che l’odio, in particolare da parte degli oppressi, è inevitabile.
Questo non vuol dire che sia inevitabile che tutte le persone, anche tutte le persone oppresse, sperimentino l’odio. È per affermare che l’odio, non essendo né contingente né estraneo all’anima umana, sarà provato da alcuni, probabilmente da molti. Che, in particolare nei contesti di società che mettono le persone l’una contro l’altra individualmente e in massa, l’odio esisterà certamente. La gente odierà. Come molti di noi hanno sperimentato di persona.
L’odio fa parte dell’umanità. Non c’è alcuna garanzia della direzione di tale inevitabile odio, ovviamente. Può essere interiorizzato, nel mortale odio per noi stessi che, sotto il capitalismo, è così diffuso. Così spesso sostenuto dal sistema stesso. Chi, schiacciato dal capitalismo, non sente, nelle parole conclusive della poesia di Rae Armantrout Hate, che «il mercato ti odia/ anche più/ di quanto tu odi te stesso»?
L’odio può essere esternalizzato, senza alcuna giustizia: spesso è stato rivolto contro chi meno lo meritava. Ma, sebbene sia diventato un cliché, la massima preferita di Marx è molto pertinente qui: Nihil humani a me alienum puto, niente di umano mi è estraneo. Non è produttivo patologizzare l’odio di per sé, non da ultimo quando è naturale che sorga, figuriamoci renderlo motivo di vergogna.
Sophie Lewis pone il punto con la consueta chiarezza tagliente. «L’odio non è quasi mai considerato appropriato, sano o necessario nella società liberal-democratica. Per conservatori, liberali e socialisti allo stesso modo, l’odio in quanto tale è la cosa da rifiutare, sradicare, sconfiggere e scacciare dall’anima. Eppure l’ideologia anti-odio non sembra implicare l’individuazione delle sue cause profonde e dei punti di produzione, né affronta l’inevitabilità o la richiesta – la necessità – dell’odio in una società di classe». Sollevare questo problema, non solo dell’esistenza dell’odio ma, almeno per alcuni, della sua potenziale stretta necessità è, per dirla con Kenneth Surin, ciò che sta alla base de «l’utilizzo di un odio deliberato come categoria razionale».
Non ci si dovrebbe mai fidare dell’odio, né trattarlo come sicuro, né celebrarlo fine a sé stesso. Ma, inevitabilmente, non va ignorato. Né è automaticamente immeritato. Né, forse, possiamo farne a meno, non se vogliamo rimanere umani, in un’epoca odiosa che patologizza l’odio radicale e incoraggia la fatica dell’indignazione. E nemmeno l’odio consapevole è necessariamente un nemico della liberazione. Potrebbe essere il suo alleato.
Nel 1837, l’appartenenza al gruppo di sinistra radicale del grande socialista pre-marxista Auguste Blanqui, noto come Stagioni, assunse come centrale tale odio socialmente informato. Contro il degrado della tradizione rivoluzionaria, per la libertà, gli accoliti giuravano: «In nome della Repubblica, giuro odio eterno a tutti i re, agli aristocratici e a tutti gli oppressori dell’umanità».
Nel 1889, il poeta radicale australiano Francis Adams scrisse di aver distrutto la sua salute nel perseguimento della lotta della classe operaia a Londra. «Sembrava un fallimento – scriveva – Ma non ho mai disperato, né ho visto motivo di disperare. C’era una splendida base di odio lì. Con l’odio, tutto è possibile».
Nel 1957 Dorothy Counts pose fine alla segregazione in una scuola nella Carolina del Nord. A proposito della fotografia che la ritrae mentre passa davanti alla feroce folla beffarda di manifestanti, James Baldwin ha scritto che «[mi] ha reso furioso. Mi ha riempito sia di odio che di pietà». Quest’ultima era riferita a Counts; la prima per quello che vedeva nei volti dei suoi aggressori. Sarebbe una devozione stupefacente e presuntuosa suggerire che un odio come questo fosse sconveniente o che non fosse funzionale all’emancipazione.
Fondamentalmente, come ha scritto Francis Adams, ogni cosa è possibile con l’odio, non solo le cose buone. Ecco dove sta il pericolo. Ma alcune cose sono sicuramente positive, in termini, ad esempio, di vigore attivista. Anche infuriarsi, certo, ma infuriarsi contro qualcosa, volendo che sia sradicato. Era in parte in questo odio che pensava potesse esserci forza. L’assenza di una massa critica di odio può ostacolare la resistenza: Walter Benjamin, nel suo straordinario, profetico, controverso saggio del 1940, Tesi di filosofia della storia, ha preso in considerazione la socialdemocrazia in opposizione al socialismo militante, per il suo focus sul futuro e sulla classe operaia come «redentrice», indebolendo attivamente quella classe e distogliendo i suoi occhi dalle iniquità del passato e del presente, per «dimenticare sia il suo odio che il suo spirito di sacrificio».
Inoltre, l’odio può aiutare non solo con la forza, ma anche con il rigore intellettuale e di analisi. Le astrazioni del capitale possono generare la loro logica apparentemente implacabile, contro la quale uno sguardo opposto coinvolto emotivamente, un odioso sguardo contrario, potrebbe rivelarsi necessario non solo eticamente ma epistemologicamente.
«Ciò che non funzionerà mai è la fredda logica della ragione – scrive Mario Tronti in Operai e capitale – Quando non è mossa dall’odio di classe». Perché «la conoscenza è connessa alla lotta. Chi ha vero odio ha veramente compreso». Tronti si spinge fino a descrivere un antinomismo radicale, cioè l’opposizione a «l’intero mondo della società borghese, così come il mortale odio di classe contro di essa» come «la forma più semplice della scienza operaia di Marx». Anche nei primi scritti politici di Marx, dal 1848 al 1849, per quanto sbagliati in vari particolari, Tronti trova «una lucidità nel prevedere lo sviluppo futuro quale solo l’odio di classe potrebbe fornire».
Odio di classe. Odio da parte di una forza sociale, di una forza sociale opposta, di quell’«altro dominante» individuato da Steven Shakespeare. Quest’odio è giusto, indicato e necessario: «non un odio personale, psicologico o patologico, ma un odio strutturale radicale per ciò che il mondo è diventato».
L’odio e il Manifesto
Tale odio strutturale radicale, schierato con cura, potrebbe persino dare una forma produttiva alle modalità più proteiformi di odio che sono anche inevitabili e pericolose. «La fusione proposta qui dell’odio con una logica strategica è essenziale se l’odio non deve trasformarsi in rabbia o in un apocalisse senza cervello». L’odio sorgerà e, sebbene la vergogna non debba attaccarsi a esso, deve essere diretto con urgenza. «L’odio radicale – nella descrizione di Mike Neary – è il concetto critico su cui si basa la negatività assoluta», ciò su cui quella rottura antinomica «si basa».
Cosa c’entra tutto questo con il Manifesto? Anche un marxologo così sottile e alla ricerca dell’odio come Tronti si concentra e trova il suo materiale in altri scritti di Marx. Ma quei testi vengono proprio dopo il Manifesto, e possono essere visti in parte come risposte a esso e ai suoi fallimenti, fallimenti delle sue profezie, delle sue speranze. L’odio di classe espresso da quegli scritti successivi non emerge dal nulla.
Nella retorica del Manifesto, Haig Bosmajian vede «non solo tentativi di suscitare rabbia […] ma di […] suscitare odio rivolto non solo contro un individuo, ma anche contro una classe». Citando Aristotele per il quale la rabbia provoca un desiderio di vendetta, «l’odio desidera che il suo oggetto non esista», per Bosmajian in Marx «l’obiettivo era quello di condurre i suoi ascoltatori in quella condizione in cui avrebbero desiderato che la borghesia fosse sradicata».
Questo è ambiguo: il punto per Marx ed Engels non è lo «sradicamento» degli individui, ma della borghesia come classe, vale a dire del capitalismo. Suggerire che il testo evochi «odio» per gli individui borghesi significa travisarne l’ambivalenza, così come la sua attenzione al sistema di classe del capitalismo. Andare oltre e affermare, come fa Leo Kuper, che la «completa disumanizzazione della borghesia» ha «rilevanza» per il problema del genocidio, implicando una teleologia dell’«inevitabile estinzione violenta di una classe di persone disumanizzate» è assurdo.
Da un lato, questo serve semplicemente a dispiegare la panacea liberale secondo cui Stalin è l’esito inevitabile e l’approdo del marxismo, e quindi non è particolarmente interessante o sorprendente. Si dovrebbe, ovviamente, riconoscere che ci sono coloro che hanno usato argomenti come quelli del Manifesto per commettere atti spaventosi. Tuttavia, descrivere questo terrore immaginario come inflitto sulla base della colpa attribuita alle persone «per quello che sono, piuttosto che per quello che fanno» è precisamente sbagliato. Nel Manifesto, nel marxismo in generale, la relazione tra le classi non è per definizione sulla base di identità statiche, date, ma di relazioni, che includono cose fatte. E lo «sradicamento» necessario è di quelle relazioni, non di persone specifiche.
Il Manifesto è chiaro: «Essere un capitalista significa avere non solo una posizione puramente personale, ma anche sociale nella produzione». E non per essenza di sé, come attesta la descrizione del Manifesto a proposito del rinnegamento di classe tra alcuni borghesi, ma in virtù dell’assunzione di «posizioni che riflettono tendenze, una tendenza alla concentrazione del capitale e una tendenza alla dipendenza e all’immiserimento», nelle glosse di Jodi Dean – vale a dire, perpetuando attivamente queste strutture e dinamiche. È proprio l’urgente necessità di rottura nel Manifesto che esprime quale odio radicale contenga.
Ma in ogni caso, infatti, nonostante tutto il loro magnifico sproloquio contro il sistema, Marx ed Engels furono troppo generosi nel loro elogio alla sua trasformazione e alle sue proprietà energetiche, e alla stessa borghesia, oltre che circa le probabilità del suo crollo. Il Manifesto è una chiamata alle armi, ma contiene anche tracce reali di un senso di inevitabile collasso che spingono contro quella spinta a sradicare il sistema. Il Manifesto vuole essere un «canto del cigno» del sistema, ma è anche un «inno alla gloria della modernità capitalista». «Mai, ripeto, e in particolare da nessun difensore moderno della civiltà borghese è stato scritto nulla di simile, mai è stato scritto un resoconto a nome della classe imprenditoriale da una comprensione così profonda e così ampia di ciò che è il suo raggiungimento e di ciò che significa per l’umanità». Se questa, dell’economista conservatore Joseph Schumpeter, è un’esagerazione, non lo è di molto. Il Manifesto, nonostante tutto il suo fuoco, la sua rabbia e la sua indignazione, ammira il capitalismo, la società borghese e la borghesia. Ammira troppo la classe borghese.
È significativo che Gareth Stedman Jones, biografo di Marx implacabilmente disilluso, descriva il tono del passaggio più noto del Manifesto come «sadismo giocoso». Si potrebbe contestare il sostantivo, ma non l’aggettivo. Ed essere giocoso, giocare, implica un compagno di giochi. La stessa scintillante e spavalda provocazione che rende il Manifesto così brillante implica, nonostante tutto il suo antagonismo, qualcosa di ludico, che spinge il testo contro ogni forma di odio.
Ciò non significa che il Manifesto sia privo di odio. Ammira la borghesia, gioca rudemente con lei e senza dubbio la odia. Naturalmente, l’odio per il sistema è evidente dappertutto. Ma nella sua forma più combattiva, quanto odia la borghesia in quanto classe? La sezione più antagonista è quella dei paragrafi da 2.15 a 2.67, in cui si rivolge direttamente alla borghesia. Quel passaggio alla seconda persona individua quale odio c’è, almeno inestricabile, nell’ammirazione. Il paragrafo 2.34 fa intendere che sono pigri; per il 2.38 sono egoisti; dal 2.45 al 2.51 li accusa di ipocrisia. Questo è tutto, per quanto riguarda gli attacchi diretti. La sincera furia in questi passaggi prevale sulla messa in scena, sul piacere di vincere una discussione, sulle cazzate retoriche.
Ma il disprezzo diretto è maggiore che nei feroci attacchi a vari oppositori di sinistra? Semmai, il vitupero palpabile contro, diciamo, i veri socialisti, è maggiore, proprio perché non ha quell’ambivalenza di atteggiamento che il Manifesto nutre nei confronti della borghesia.
Per prendere in prestito una frase di Neary, in un altro contesto, nel Manifesto del Partito Comunista la «negatività non è abbastanza negativa». Non odia abbastanza. Contro gli occhi roteanti del cinico saccente, dovremmo ribadire il nostro fastidio per quelle litanie di iniquità che il capitalismo lancia. Che provochino in noi una risposta adeguata, umana, il furore della solidarietà, il disgusto di una sofferenza così inutile.
Chi saremmo per non odiare questo sistema e i suoi partigiani? Se non lo facciamo, l’odio di coloro che odiano per conto suo non diminuirà. «C’è una splendida base di odio – e se non ne costruiamo qualcosa di positivo, gli edifici che inevitabilmente emergeranno saranno davvero molto brutti». Dovremmo provare odio oltre le parole e portarlo a sopportare. Questo è un sistema che, più di qualunque altra cosa, merita un odio implacabile per le sue innumerevoli e crescenti crudeltà.
La classe dirigente ha bisogno della classe operaia. Le sue fantasie di liberarsene possono essere solo fantasie, perché come classe non ha potere senza coloro che le stanno sotto. Ecco il più ampio disprezzo della classe dirigente per la classe operaia (chavs), il disgusto di classe, il sadismo sociale, il costante diritto della classe dominante, quel senso di essere speciali dunque le regole non gli si applicano, lo squilibrato elogio della crudeltà e della disuguaglianza. Per quanto tutto ciò sia vile, ciò non è odio, certamente non odio aristotelico, perché il suo oggetto non può assolutamente essere sradicato.
Per la classe operaia la situazione è diversa. L’eliminazione della borghesia come classe è l’eliminazione del dominio borghese, del capitalismo, dello sfruttamento, dello stivale sul collo dell’umanità. Ecco perché la classe operaia non ha bisogno del sadismo, e nemmeno della vendetta, e perché non solo può, ma deve, odiare. Deve odiare il suo nemico di classe e il capitalismo stesso.
L’odio per le forze che opprimono l’umanità
C’è un modello per un odio migliore in uno dei testi chiave da cui è nato il Manifesto: si tratta de La situazione della classe operaia in Inghilterra di Engels. L’odio, del tipo più rigoroso di classe, ricorre e ricorre ripetutamente, attraversa quell’opera sconvolgente e bruciante. Riconosce nella borghesia, da parte sua, «l’odio verso le associazioni» della classe operaia, naturalmente: quelle associazioni che la borghesia potrebbe certamente eliminare. Engels non solo non si sottrae all’odio della classe operaia per i suoi oppressori, lo invoca a sua volta ripetutamente.
Lo vede come necessario e centrale per la politica della classe operaia. I lavoratori, per Engels, «vivranno come esseri umani, penseranno e sentiranno come uomini [sic]» «solo sotto l’odio ardente verso i loro oppressori, e verso quell’ordine di cose che li mette in questa posizione, che li degrada a macchine». L’odio è necessario per la dignità, dunque per l’agire politico. Non celebra l’odio tout court, fin troppo consapevole dei pericoli dell’«odio portato al limite della disperazione» e che si manifesta in attacchi individuali dei lavoratori contro i capitalisti. «L’odio di classe», al contrario, è «l’unico incentivo morale mediante il quale il lavoratore può essere avvicinato alla meta». Ciò è in diretta opposizione all’odio individualizzato: «nella misura in cui il proletario assorbe elementi socialisti e comunisti, la rivoluzione diminuirà il suo spargimento di sangue, la vendetta e la ferocia. . . [Non] a nessun comunista viene in mente di volersi vendicare degli individui».
Sarebbe certamente un socialismo primitivo e pio se non riuscisse almeno a entrare in empatia con l’odio individualizzato, o semplicemente lo denunciasse all’ingrosso come un fallimento etico. Ciò è particolarmente vero nella nostra epoca moderna, dove il sadismo e «la pesca a strascico» sono diventati centrali per il metodo politico, specialmente tra la classe dirigente. Ci vorrebbe una quantità irragionevole di santità perché nessuno a sinistra provi odio per, ad esempio, il fondatore degli hedge fund, l’amministratore delegato di prodotti farmaceutici e il truffatore condannato Martin Shkreli, non solo a causa dell’ostentato profitto che trae dalla miseria umana, ma dati i suoi sforzi ripetuti, performativi e rigorosi proprio per essere odiato. E, naturalmente, c’è Trump che inneggia alla razza, deride la disabilità e celebra le aggressioni sessuali.
Il punto, tuttavia, è che arrendersi completamente e acriticamente a questo tipo di sentimento contro gli individui significa incoraggiare la propria degenerazione etica; dare implicitamente un lasciapassare a quelli della classe dirigente più inclini a velare decorosamente la miseria di cui beneficiano; e perdere la concentrazione sul sistema di cui queste figure controverse sono sintomi. Il che significa rischiare di scagionarlo.
La storia del movimento rivoluzionario è, tra le altre cose, una storia di radicali organizzati che tentano di frenare l’odio di classe individualizzato. L’odio deve essere odio di classe, con «idee comuniste», proprio per ovviare «all’amarezza del presente». Ma quell’odio di classe è incandescente e deve risplendere, e solo «amando l’odio più ardente», nella vivida formulazione di Engels, coloro che si trovano all’estremità della storia possono mantenere vivo il rispetto di sé stessi. Qui sta la «purezza» di cui si è interrogato il giornalista radicale Alexander Cockburn quando ha notoriamente chiesto ai suoi stagisti: «Il tuo odio è puro?». Si tratta della declinazione politica dell’תַּכְלִ֣ית שִׂנְאָ֣הַ, il taklit sinah, l’«odio estremo» o «perfetto» dei Salmi per coloro che insorgono contro il Signore. Vale a dire traducendo in escatologia politica, i nemici della giustizia. Salmo 139:22: «Li odio di un odio perfetto».
Dobbiamo odiare più duramente del Manifesto, per il bene dell’umanità. Tale odio di classe è costitutivo e inestricabile dalla solidarietà, l’impulso per la libertà umana, per il pieno sviluppo dell’umano, l’etica dell’emancipazione implicita in tutto il Manifesto e oltre. Dovremmo odiare questo mondo, con e attraverso e oltre e anche più del Manifesto. Dovremmo odiare questo sistema di crudeltà odioso, di odio e di odio, che ci esaurisce, appassisce e ci uccide, che ostacola le nostre cure, lo rende così combattuto, limitato e locale nella sua portata e nei suoi effetti, dove avremmo la capacità di essere più grandi.
L’odio non è e non può essere l’unica o la principale spinta al rinnovamento. Sarebbe profondamente pericoloso. Non dovremmo né celebrare né fidarci del nostro odio. Ma non dobbiamo neppure negarlo. Non è nostro nemico e non possiamo farne a meno. «A rischio di sembrare ridicolo – disse Che Guevara – lasciatemi dire che il vero rivoluzionario è guidato da un grande sentimento d’amore». È per amore che, leggendolo oggi, dobbiamo odiare di più e meglio di quanto sapesse fare il Manifesto del Partito comunista.
*China Miéville vive a New York ed è uno scrittore, attivista, fumettista, saggista e critico letterario britannico, noto per i suoi romanzi urban fantasy e fantascientifici, in Italia pubblicati da Fanucci. Questo testo, pubblicato su JacobinMag, è una versione rivista di quello comparso su A Spectre, Haunting: On the Communist Manifesto (Head of Zeus, 2022). La traduzione è a cura della redazione.
Questo articolo è stata pubblicato su Jacobin il 1 dicembre 2022