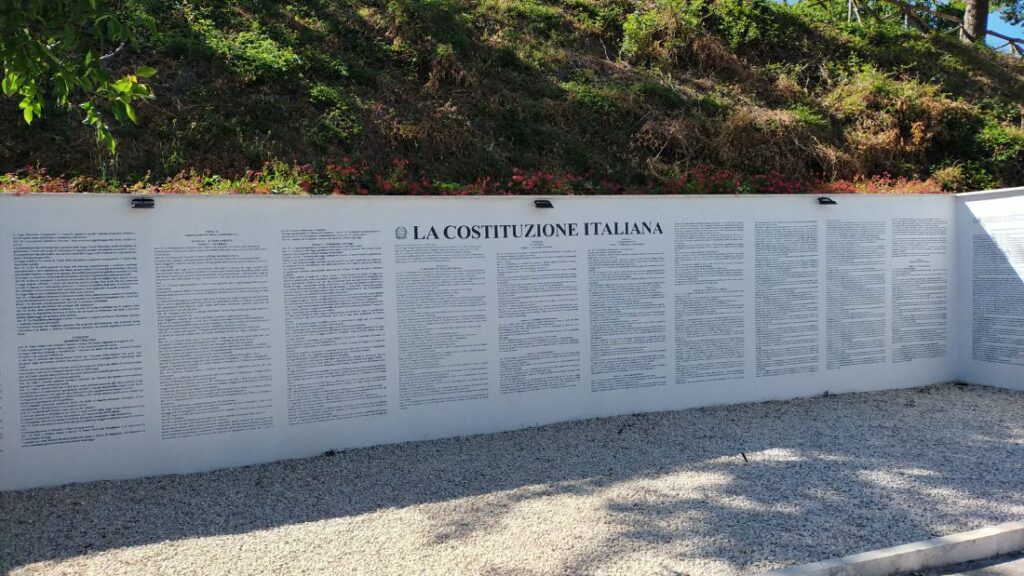Maglia e pantaloncini bianchi non sono pratici, soprattutto durante i giorni delle mestruazioni. A dire no alle candide divise sono state le calciatrici della Nazionale di calcio inglese. Il caso è scoppiato dopo la gara inaugurale dell’Europeo femminile, vinto poi proprio dalle inglesi, ma la Federazione ha per ora rinviato la soluzione alla richiesta di cui si è fatta portavoce l’attaccante Beth Mead. Negli stessi giorni, a Wimbledon, alcune tenniste hanno posto lo stesso problema, ma il regolamento del torneo inglese prevede il bianco sia per gli uomini che per le donne (il decalogo del torneo indica che persino la biancheria sia completamente bianca «ad eccezione di un unico bordo di colore non più largo di un centimetro»).
Che oggi parlare di mestruazioni, anche nel mondo dello sport, non sia più un tabù lo dimostrano anche le dichiarazioni della nuotatrice Benedetta Pilato, che ha sottolineato come la sua prestazione ai recenti Mondiali di Budapest sia stata influenzata dal ciclo. Prima di lei, era stata la collega Federica Pellegrini a parlarne.
Sono le divise, e talvolta i divieti ad alcuni capi di abbigliamento, a fare anche la storia dello sport. Soprattutto quella delle atlete. Ad esempio, lo scorso anno in occasione dei Giochi olimpici di Tokyo furono le ginnaste tedesche a schierarsi contro il classico body tanto che scelsero di scendere in pedana con quello lungo per dire basta alla sessualizzazione della ginnastica. Solo poche settimane prima in Bulgaria la squadra femminile norvegese di beach handball, ovvero la pallamano da spiaggia, si era rifiutata di gareggiare in bikini diventando così protagonista di quella che è stata subito ribattezzata dai media come “la guerra degli shorts”. Alle norvegesi è stata comminata una multa di 150 euro a testa per aver violato le regole sulle divise ufficiali.
Spesso le divise sono state strumento per osteggiare la partecipazione delle donne alla pratica sportiva. Durante il periodo fascista, come ricorda la storica Victoria de Grazia nel suo Le donne nel regime fascista, le federazioni sportive impartiscono regole ben precise sull’abbigliamento: «I calzoni di gara non dovranno mai essere eccessivamente corti e le maglie dovranno essere a mezze maniche». Ne sanno qualcosa le giovani calciatrici del Gruppo femminile calcistico di Milano, la cui storia è stata riscoperta grazie al lavoro dello storico Marco Giani, che proprio in quegli anni furono ostacolate dal regime e fu vietato loro di scendere in campo con i calzoncini corti. Dovettero optare per le “sottanine”, ovvero gonne al ginocchio. «Gareggiavano in pantaloncini corti, in Italia, ‒ spiega Giani in un altro suo lavoro [1] ‒ Ondina Valla e Claudia Testoni, le due promettenti promesse dell’atletica leggera azzurra, scandalizzando tuttavia molti benpensanti, i quali non avevano niente di meglio da fare che scrivere lettere infuocate ai giornali che ‘osavano’ pubblicare foto delle due immortalate in pose ‘immorali’ quali quelle dei salti». «Fu così che ‒ aggiunge ancora lo storico ‒ le calciatrici ebbero la prudente idea di indossare da subito la sottanina, presto per tutte nera (all’inizio c’era stato spazio per qualche colorata variante personale): la stessa, peraltro, adottata dalle Giovani Italiane per le manifestazioni atletiche. Qualche giocatrice, per farla meglio aderire al corpo, indossava una piccola cintura sopra la maglietta. Per il resto, tuttavia, l’abbigliamento era in tutto e per tutto quello del calciatore provetto».
Oppure le divise hanno superato i confini di palazzetti dello sport e campi da gioco e sono entrate di diritto nella storia del costume. Come i completi indossati dalla tennista Lea Pericoli, che sulla sua strada incontra Ted Tinling, ex giocatore, scrittore e creatore di moda, che hanno conquistato un posto nelle sale del Victoria Albert Museum di Londra. «Mi chiese ‒ ricorda in un’intervista al Corriere della Sera in occasione dei suoi 80 anni nel 2015 ‒ se volevo mettermi i suoi vestiti. Come dirgli di no? Giocai con culotte e sottoveste rosa. Fotografi da tutte le parti. Apriti cielo». A Wimbledon Pericoli ha gareggiato indossando il pigiama di pizzo, le piume di struzzo, il gonnellino di visone, la sottanina di diamanti, il gigantesco nodo di Chanel. Le celebri culotte di pizzo fecero scrivere ai cronisti dell’epoca “Lea’s kick is chic!”. «Ho cambiato l’immagine delle tenniste con grazia», ha detto la tennista in un’altra intervista nel 2019. Wimbledon è il torneo per eccellenza e il Daily News nel 2015 ha pubblicato persino una fotogallery storica sulle tenniste che hanno gareggiato: un curioso viaggio nella moda e nel costume da Dorothea Lambert Chambers, autrice della guida Tennis for ladies, a Serena Williams.
L’abbigliamento sportivo, soprattutto se innovativo, può essere un’arma a doppio taglio al punto da mettere in secondo piano le prestazioni. È capitato a Florence Griffith, la velocista statunitense che incantò negli anni Ottanta l’atletica mondiale. Delle sue mise ricercate e nuove per quella disciplina fu scritto molto quasi quanto la sua bravura in pista tanto che nel 1998 in occasione dei suoi funerali la Gazzetta dello Sport non esitò a ricordare che «L’America si era innamorata di lei per la sua velocità pazzesca, ma anche per quella sua personalità da prima donna, che le faceva indossare in pista costumi attillatissimi (famosa rimane la sua tutina porpora e azzurro, che copriva una gamba e lasciava scoperta l’altra conosciuta come the “one – legger”) e unghie lunghe come artigli che si dipingeva nei colori più strambi. Sì, era veloce, ma in pista si faceva soprattutto notare per il suo look, il tentativo di far capire che l’atletica non era fatta solo per donne sudate e trasandate che in pista si vestivano come gli uomini. Non disdegnava truccarsi prima di una gara, teneva unghie curate, i capelli pettinati».
Le divise, però, possono diventare anche simbolo di lotta. Come quella ingaggiata dalla sollevatrice di pesi Amna Al Haddad. È stata la prima donna degli Emirati Arabi a gareggiare nel Reebok CrossFit Asia Regionals nel 2012. Al Haddad ha gareggiato indossando l’hijab rispettando così la tradizione della religione musulmana. Questa sua battaglia l’ha portata a collaborare nel 2016 con la Nike per il progetto Nike Pro Hijab. «Lo sport ‒ ha spiegato in un’intervista alla BBC nel 2018 ‒ dovrebbe essere inclusivo per tutti e non si dovrebbe sentire il bisogno di decidere tra cosa indossare e praticare uno sport a causa della mancanza di un prodotto o di una soluzione». E dire che lo scorso gennaio il Senato francese ha approvato una norma che vieta alle donne islamiche di indossare l’hijab nelle competizioni sportive perché, essendo un simbolo religioso, violerebbe la laicità anche in campo.
Mentre in Italia è accaduto, a febbraio, che a Maroua Morchid, calciatrice della Pro Vercelli, l’arbitro le abbia chiesto di togliere il velo durante la gara contro l’Accademia Torino del Campionato femminile Under 19. Gara sospesa e poi botta e risposta tra la sezione Aia di Casale Monferrato, che ha difeso l’operato del direttore di gara sostenendo che non aveva alcune intenzione di offendere la giocatrice, e Anita Angiolini, vicepresidente della Pro Vercelli, secondo la quale ‒ come ha riportato il quotidiano La Stampa ‒ «il rispetto del prossimo passa da piccoli gesti e sicuramente permettere ad una ragazza di giocare con il velo, come prescritto dalla propria religione, non deve essere fonte di discriminazione».
[1] Giocare a calcio, da italiana (anche in gonna!). La lotta contro i pregiudizi delle pioniere del calcio femminile nel nostro paese, in Notiziario del Settore Tecnico, n. 3 (2020), pp. 18-29
Questo articolo è stato pubblicato su Atlante Treccani il 5 agosto2022