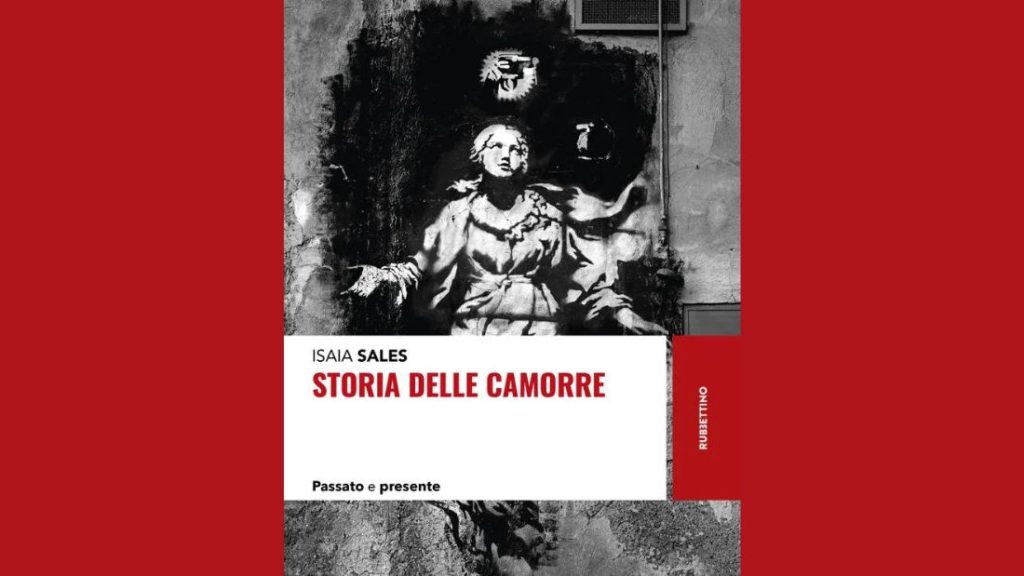Cosa rimane dello studio antropologico di Thomas Belmonte sui quartieri poveri di Napoli negli anni Settanta.
Come saggio di antropologia è forse obsoleto, come libro di viaggio è incompleto, come memoir è lacunoso: eppure, La fontana rotta di Thomas Belmonte è un grande libro. Uscito negli Stati Uniti per la prima volta nel 1979 e ora tornato in libreria in Italia per Einaudi nella bella traduzione di Daniele Petruccioli, La fontana rotta è il resoconto della ricerca che l’antropologo Thomas Belmonte, la cui famiglia aveva origini pugliesi, condusse a metà anni Settanta sulla “vita collettiva nei quartieri poveri di Napoli”. Abitò per circa due anni dalle parti del seicentesco e degradato Palazzo Amendola, zona popolare che nel libro diventa “Fontana del re”, chiamata così “per via dei resti malconci di un’antica fontana scolpita in un angolo del cortile”.
Belmonte partì con “l’ambizione di indagare un luogo etnografico limite”: tale doveva sembrare all’epoca Napoli a un giovane dottorando in antropologia della Columbia University. La sua fu però un’immersione dall’intensità che mai avrebbe potuto immaginare, nonostante la preparazione in materia di metodologia etnografica (o forse, paradossalmente, proprio in contrasto con quella). Le classiche forme di estraneità provate da antropologi e antropologhe sul campo divennero fin dal primo giorno forme specifiche di destabilizzazione, e non rimaneva che seguire il fil rouge di quello scombussolamento come ipotesi di ricerca. Belmonte arrivò a Napoli per raccontare una “fenomenologia della miseria”, la vita degli “strati profondi dell’esistenza dei quartieri poveri” e delle sue famiglie. Un approccio che, al di là di qualunque banale idea di “licenza letteraria”, avvicina antropologia e letteratura, tanto che nell’introduzione del libro decise di citare D. H. Lawrence: “il romanzo è la più alta espressione della creatività umana, perché assolutamente incapace di assoluto. Etnografi e romanzieri farebbero bene a seguire questo appello a evitare con forza la tentazione della teoria pura”.
Un momento di svolta nel rapporto di Belmonte con la comunità locale è quando viene quasi adottato da una famiglia, quella di Elena e Stefano, con i loro figli. Lo porteranno perfino con loro nelle gite domenicali.
Nella prima parte de La fontana rotta, Belmonte racconta dei suoi tentativi, talvolta goffi e altre volte invece strategicamente accorti, di farsi accettare nella comunità locale. Con quei primi approcci – durante i quali qualcuno sospetterà l’antropologo di essere una spia o un poliziotto infiltrato, un’accusa che nella storia dell’antropologia ricorre spesso – si arriva subito al cuore sia della relazione che Belmonte riuscirà a instaurare con gli abitanti del posto, sia di alcune dinamiche profonde delle loro stesse vite. “Confesso di essere rimasto sconcertato dagli abitanti di Napoli insieme ai quali ho vissuto. Non appena riuscivo a distinguere un disegno tra le figure caotiche che avevo di fronte, subito lo schema si ricollocava sotto diversa forma”. È così che l’ingenuità di Belmonte si fa strumento euristico in sé: diventa cioè lo scarto attraverso cui l’antropologo riesce sia a cogliere le logiche e i sentimenti dei suoi interlocutori, sia a farli propri attraverso una capacità di coinvolgimento umano che, ben al di là della retorica dell’empatia, Belmonte riesce a restituire nelle sue sottigliezze attraverso il rigore evocativo e la precisione poetica della sua scrittura:
Viene il venditore di scope. Sembra un goffo uccello tropicale, con il suo carico di plastica brillante fatto di secchi azzurri e scope gialle e rosa. Il tramonto è annunciato dall’insistente fischio del lattaio e dalle sirene delle voci materne che richiamano i bambini a casa.
Poco a poco Belmonte riesce a entrare in rispettosa confidenza con alcuni abitanti, la cui fiducia e amicizia diventerà una garanzia anche per gli altri. “In quei giorni coglievo le cose soltanto in superficie, ma dalle superfici c’è molto da imparare”. Thomas (per gli amici napoletani Tommaso) conosce allora Giorgio, “che si era presentato come un intellettuale comunista disilluso”, e poi Carlo, che si appassiona alla sua ricerca quanto lui e che fa di tutto per aiutarlo, e così via. E non ci vuole molto prima che Belmonte si ritrovi immerso fino al collo nella vita locale, in tutti i suoi aspetti, incluso il rapporto di amicizia con alcuni “ladri” locali, come Lorenzo, celebre per la sua “astuzia mista a generosità”: avrebbe presto cominciato a chiedergli di scrivere delle lettere per conto suo, ma anche, nell’ennesima significativa duplicità di quel mondo, di nascondere in casa sua della merce rubata.
Un momento di svolta nel rapporto di Belmonte con la comunità locale è quando viene quasi adottato da una famiglia, quella di Elena e Stefano, con i loro figli. Lo porteranno perfino con loro nelle gite domenicali. Toccare con mano la vita di quella famiglia permetterà a Belmonte di lanciarsi in analisi delle dinamiche familiari e domestiche – incluso quella che lui definisce “centralità della madre e matriarcato” – non sempre convincenti, ma costantemente attraversate dall’ansia di stare al passo con gli eventi e le dinamiche generali di quei contesti. Per sua stessa ammissione, ne veniva sopraffatto:
Ho preso l’abitudine di barrare interi brani del taccuino con la scarna interiezione “macello!”, a significare che la situazione sfuggiva alla mia capacità di osservazione e non ero più in grado di seguire il diluvio di pugni e manate, le espressioni contratte e di dolore, le bestemmie, le urla, i mugugni.
Belmonte viveva con partecipazione e attenzione acuta la vita dei suoi interlocutori, ed era proprio tale coinvolgimento a portarlo verso quel certo malessere e malinconia che attraversano tutto il testo. La sera, prima di dormire faticosamente, ripensava alla vita delle persone che aveva incontrato, donne, uomini, bambine e bambini le cui tribolazioni parevano affliggerlo come fossero le proprie: “Si può passare la vita solo a guardare, a contemplare lo spettacolo; e morire di questa contemplazione”. L’ipotesi di ricerca stava diventando ipotesi di vita. Eppure, è proprio attraverso il disagio provato da Belmonte che noi lettori e lettrici riusciamo a entrare nel mondo che stava tentando di evocare e restituire. È, per esempio, proprio quando Belmonte ammette i malintesi, i depistaggi, o le frodi e gli scherzi di cui è stato vittima che allora ci sembra capire eccome – come se di quelle incomprensioni ne fossimo vittime noi lettori – perché non c’è mai un mondo da indagare nella sua verità, ma sempre un mondo da capire anche attraverso le sue bugie, evidenze e false verità: “Si rifugiano nella violenza delle emozioni sfrenate, oppure diventano ipocriti. In quel teatro della crudeltà che sono i bassifondi, ciascuno recita il suo piccolo ruolo di canaglia”. È la capacità evocativa di Belmonte a permetterci di cogliere ciò che resta quando da un mondo sociale sottraiamo la descrizione di quello stesso mondo.
L’Italia ha una certa tradizione di antropologia accademica, ma anche di Paese dove molti antropologi stranieri hanno condotto le loro ricerche, non senza malumori e sarcasmo da parte dei colleghi italiani.
L’attitudine con cui Belmonte sbarcò a Napoli trova le sue radici in una certa tendenza di cui l’Italia fu al centro. Si trattava della posizione, a suo modo paradossale, di un Paese che, all’incirca negli stessi anni, da una parte stava diventando sede di antropologi e antropologhe che, al pari dei colleghi francesi o statunitensi, producevano studi su popolazioni “lontane”, e che nel frattempo, però, era ancora un paese che, soprattutto nel suo meridione, esercitava su certi studiosi stranieri (soprattutto americani) un’attrattiva simile a quella di paesi non-occidentali al centro dell’attenzione dell’antropologia classica. Ne risultava una sorta di esotizzazione dell’Italia e di essenzializzazione di alcune sue espressioni popolari. Insomma, l’Italia ha una certa tradizione di antropologia accademica, ma anche di Paese dove molti antropologi stranieri hanno condotto le loro ricerche, non senza malumori e sarcasmo da parte dei colleghi italiani.
La possibilità d’inserire La fontana rotta nella categoria di saggio di antropologia (così come si presenta) oppure reportage, memoir o altro ancora, non ha nulla a che vedere con la solita retorica del libro “che sfugge a ogni classificazione”. È piuttosto uno spunto per riflettere sui modi in cui certi grandi libri tentano a volte di camuffarsi, di travestirsi, di presentarsi sotto mentite spoglie, di nascondersi dietro qualcosa che non sono, e di farlo proprio per darsi così l’unica possibilità di essere loro stessi. Vincent Debaene nel suo L’adieu au voyage (Gallimard, 2010) e nella bella analisi che vi sviluppa riguardo i rapporti fra antropologia (per lo più francese) e letteratura, identifica la figura del “secondo libro” degli antropologi, ovvero di opere che sembrano abbandonare il rigore scientifico alla base del “primo” libro tratto dalla stessa ricerca. Il dato di base è che quasi tutti gli antropologi francesi che hanno svolto ricerca sul campo prima del 1939, al loro ritorno hanno scritto e pubblicato non soltanto uno studio scientificamente rigoroso sulle popolazioni e fenomeni sociali su cui si erano concentrati, ma spesso anche un secondo libro, un’opera più “letteraria”, un testo che si allontanava dai canoni della monografia antropologica, con il suo resoconto etnografico, sistema di analisi, proposta teorica e così via. Pensiamo per esempio a Michel Leiris, che pubblica La possessione e i suoi aspetti teatrali fra gli Etiopi di Gondar, ma anche L’Africa fantasma; oppure a Claude Lévi-Strauss, che dà alle stampe La vita familiare e sociale degli Indiani nambikwara, ma poi anche Tristi tropici; o Marcel Griaule, o Alfred Métraux con il suo L’isola di Pasqua, e così via.
È il lato letterario di un’opera di scienze sociali a salvarne non tanto la dimensione estetica, quanto proprio il rigore scientifico.
È qualcosa che mette in discussione contrapposizioni riduttive e fuorvianti, ma ancora dominanti, quali quella fra oggettività e soggettività, fra spiegazione e interpretazione, fra rigore e impressionismo. Ecco, a tenere in mente tale categorizzazione, La fontana rotta sembra volersi presentare da “primo” libro come mantello per avvolgere e nascondere un “secondo libro”. Da una parte, quel primo libro è tutto sommato poco convincente e oggi obsoleto nelle sue generalizzazioni teoriche (inserite verosimilmente per rispondere al bisogno di rispettare certi vecchi canoni delle monografie antropologiche): dalla “ricerca di stampo psicoanalitico di Anne Parsons sulle famiglie disagiate di Napoli” fino all’ingombrante paradigma della “cultura della povertà” di Oscar Lewis, per esempio. Dall’altra parte, invece, quel secondo libro appare ancora oggi un piccolo gioiello. Succede allora che è il lato letterario di un’opera di scienze sociali a salvarne non tanto la dimensione estetica, quanto proprio il rigore scientifico.
Nel caso de La fontana rotta, tutto questo diventa particolarmente evidente – se non sconcertante – nell’Epilogo che Thomas Belmonte decise di aggiungere al volume nella riedizione statunitense del 1989, dieci anni dopo la prima edizione. Sono trentacinque pagine magistrali, mozzafiato. “A Napoli sono ritornato tante volte. E ogni mio ritorno era pieno di speranza e di paura. Ognuno è stato un tentativo di espiazione, di ritrovamento e di perdono”. Durante quel ritorno, Belmonte incontra per esempio Peppe, Giuseppe, uno dei figli di Elena e Stefano, la famiglia da cui era stato quasi adottato. Era caduto nella tossicodipendenza e campava di espedienti. “Ma perché sono nato, Tommaso?”. Altri ragazzi che Belmonte aveva conosciuto durante il suo periodo di etnografia intanto erano morti. Altri ancora si erano perduti nelle loro vite difficili. “Esiste la giustizia, da qualche parte, Tommaso?”. E poi altri incontri con chi sopravviveva da quel passato. Per esempio Leah, improbabile prostituta svedese nei bassifondi Napoli: “Non c’è più niente, Tommaso. E non tornerà mai. La mia Napoli… C’era una cultura qui, no? Una cultura popolare? L’antropologo sei tu!”.
Le pagine finali di Belmonte sono attraversate da una malinconia che sembra essere sempre sul punto di arrendersi all’irrappresentabilità della condizione umana. O quantomeno della condizione di chi, fra quegli umani, rientra nella fluttuante categoria dei “poveri”. Aleggia anche il tentativo di resa di fronte alla presunta vacuità degli sforzi di qualunque scienza, di fronte a tale esperienza umana, e al fallimento strutturale – ma apparente e ingannevole – di qualunque impresa conoscitiva come quella tentata da La fontana rotta. Nonostante le premesse e l’approccio dichiaratamente “incapace di assoluto”, all’intero dell’incedere del suo racconto, Belmonte apre lungo il libro varie pause teoriche, ma sempre stagliate su un felice registro lirico:
Ecco la triste realtà che soggiace allo scintillante brulichio di superficie delle città mediterranee. Se i rapporti di produzione non suscitavano la solidarietà fra poveri, ci riuscivano la miseria e l’odio che la miseria produce. Ma l’odio non basta per organizzarsi, e le lezioni imparate dalla fame di rado allargano l’orizzonte di un uomo.
Nell’Epilogo del libro, invece, tutto è incarnato e vivente, lì Belmonte si libera dell’obbligo a incasellare quel che osservava e viveva in gabbie teoriche inadatte a contenere tutto quello straripare di vita e tutta quell’insensata sofferenza: “All’epoca avevo ammantato il mio dolore di ‘filosofia critica’, adesso invece riempivo il tavolo di pugni, in stolida furia impotente”. Quella fontana pareva a Belmonte sempre più irrimediabilmente rotta, e sempre più impossibile da restaurare: “Passando davanti a quel luogo devastato, ho sempre cercato di immaginare come doveva essere quella fontana, rimuginando il mio dolore incredulo a mano a mano che capivo il perché della sua distruzione”. E tutto questo fino a un episodio minore ma rivelatore. A un certo punto, nel 1984, il più importante quotidiano cittadino intervistò Belmonte riguardo La fontana rotta. Accanto all’intervista, uscita in seconda pagina, il giornale pubblicò una grande foto dell’antropologo. Quando gli abitanti di Fontana del re videro la foto, la reazione fu: “Hanno arrestato Tommaso! È sempre stato uno di noi…”.
Thomas Belmonte è morto a New York il 22 giugno del 1995. Non aveva neanche cinquant’anni. Ho ritrovato il necrologio del New York Times, dal titolo: Thomas Belmonte, 48, is Dead. Wrote of Lives of Naples’s Poor. In quel trafiletto si viene a scoprire che è di Aids che l’antropologo morì. È nel mare di fronte a Napoli che Belmonte volle che le sue ceneri venissero disperse, assieme ai destini delle donne e degli uomini ritratti ne La fontana rotta.
Questo articolo è stato pubblicato su Il Tascabile il 25 febbraio 2022