Il 26 giugno, nell’aula dell’università di Roma 3 adeguata per l’occasione a sala del Senato, è stata presentata la Relazione al Parlamento 2020 del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, presieduto da Mauro Palma e composto da Daniela de Robert e da Emilia Rossi. Al netto del necessario stile formalmente pacato e istituzionale, la relazione offre numerosi spunti di riflessione e propone un’analisi così matura che è davvero un peccato rimanga solo un documento per addetti ai lavori; contiene, infatti, elementi di critica radicale che vanno raccolti ed elaborati, dal momento che non parlano solo del “carcere” ma di ciò che è accaduto, sta accadendo e con ogni probabilità accadrà ancora.
I dati raccontano di un carcere che negli ultimi cinque anni vede crescere i presenti sino ad arrivare ai 60.791 detenuti a fine 2019, a cui vanno sommati 29.566 detenuti in misura alternativa. Si confermano i numeri bassi di sempre per le donne (2.663 in tutto le detenute), circa un terzo delle presenze è straniero (19.888), un altro terzo circa è in carcere in attesa di almeno una sentenza di primo grado. Un carcere in affanno, con spazi insufficienti, assenza di politiche di recupero, prevalenza delle logiche securitarie, i cui fragili equilibri sono stati messi in crisi senza possibilità di fraintendimenti durante la prima fase dell’emergenza Covid-19. Sono state quarantuno le manifestazioni di protesta nei mesi di marzo e aprile, con oltre cinquemila detenuti coinvolti, che hanno fatto registrare trenta feriti tra la popolazione detenuta e ventinove tra gli agenti, e circa due milioni e mezzo di danni. Ancora più grave il dato sulle rivolte, ventitré, con un bilancio impressionante e su cui ancora non si è fatta luce, tredici detenuti morti, nove dei quali nel solo carcere di Modena. Rivolte scoppiate – è bene ricordarlo – durante la fase più acuta dell’emergenza, senza che nessuno si preoccupasse di garantire e rassicurare quella parte di mondo sommerso dai rischi del contagio. A oggi si contano 161 positivi tra i detenuti, con almeno quattro decessi, e 211 positivi tra gli agenti di polizia, segno evidente che i timori alla base di quelle proteste non erano poi infondati. Se la crisi non è proseguita è perché, sia pure tra le polemiche strumentali e demagogiche che ne sono scaturite, una parte dei detenuti ha usufruito della detenzione domiciliare, e perché sono state adottate, sia pure con ritardo, misure di screening e di test alla popolazione. Ma il segno lasciato da queste proteste è tutta nelle ferite del carcere di Santa Maria Capua Vetere.
Ciò detto, per disegnare un rapido quadro del nostro sistema penitenziario, raccogliamo qui due spunti tra i tanti che la lettura del rapporto offre. Il primo è relativo a un passaggio della lunga relazione, richiamato da Mauro Palma nella presentazione: “La mancanza di una riflessione organica sul disagio psichico in carcere determina, peraltro, anche l’atteggiamento diffuso, privo di un effettivo fondamento, e in progressiva crescita, di ascrivere ogni forma di disagio di natura emotiva o comportamentale o anche di semplice reazione a condizioni di vita non tollerabili alla sfera della malattia psichica”. Questa sorta di “psichiatrizzazione generale”, riduce “le responsabilità di tutti gli attori che l’autore di reato incontra nel suo percorso di giudizio e di esecuzione della pena, e soprattutto di chi ha il compito di assicurare il ‘ben-essere’ di ogni persona nell’ambiente in cui questa è ristretta. […] Determina inoltre risposte non sempre adeguate al problema, e l’ingolfamento delle strutture dedicate alle patologie psichiatriche vere e proprie”. Quali sono le cause di questa dinamica? “Vuoti, inerzie, carenze, bisogno: la situazione della tutela della salute mentale negli istituti penitenziari italiani, maturata nel corso dell’ultimo anno, si può sintetizzare in questi parametri che toccano, implacabilmente, i campi di possibile azione legislativa, culturale, sanitaria”.
L’assenza di una cultura di intervento che porta a considerare la patologia psichica “come la figlia di un Dio minore nel campo della malattia: una sofferenza considerata a tratti inconsistente, a tratti ‘colpevole’ e in, ogni caso, non meritevole di una soluzione”. Una sofferenza che sconta carenze strutturali che portano a privilegiare un approccio segregazionista, spesso concretizzatosi nell’isolare le persone con disagio psichico in sezioni sotto “il controllo diretto del personale di polizia, con il rischio di una impropria assegnazione di responsabilità rispetto a comportamenti e a questioni che non sono di competenza del personale di sicurezza”. Così, in parte, si spiegano i cinquantacinque suicidi e, soprattutto, le migliaia di episodi di autolesionismo che non possono essere separati dal contesto in cui maturano. In carcere (e di carcere) ci si ammala e non c’è cura, perché questo carcere, così come concepito, non può dare risposte che non siano di contenimento a quei comportamenti che si pongono come “problematici”.
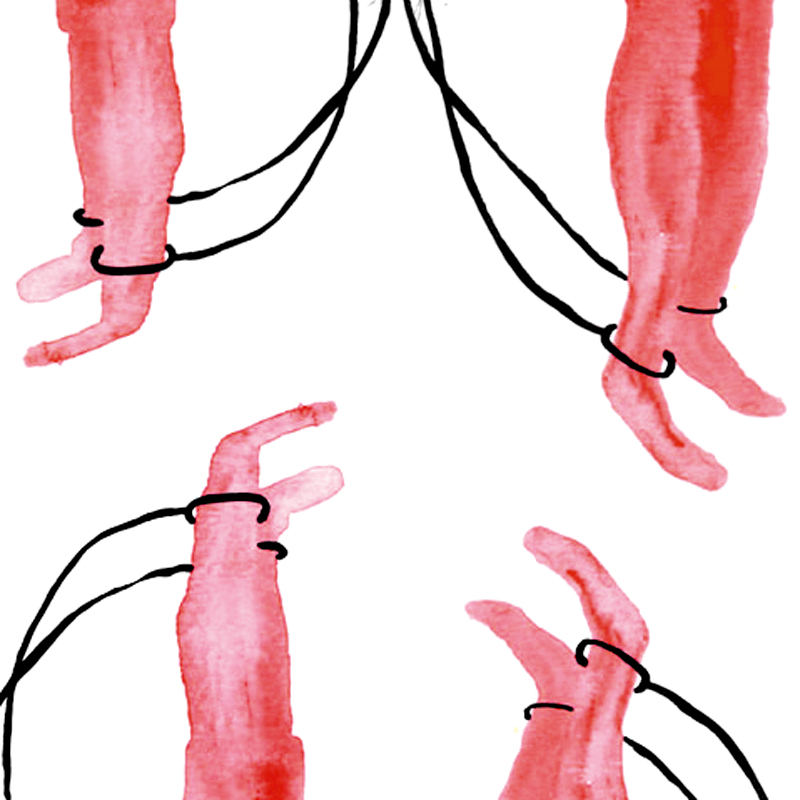
disegno di cyop&kaf
Però, attenzione, ci viene da aggiungere, queste stesse risposte di cura che i servizi di salute mentale non riescono a fornire nel carcere, in modi diversi non vengono date nemmeno in molti dipartimenti di salute mentale. Il carcere non è una linea di frontiera che i servizi non riescono a raggiungere, ma uno dei tanti luoghi di questo paese in cui le persone, che siano libere o ristrette, devono rassegnarsi all’assenza di una cura che sia anche “presa in carico” e non mera prescrizione di qualche farmaco. E il carcere non è necessariamente il luogo più violento o pericoloso per chi soffre di una patologia, basti pensare al caso estremo di Elena Casetto, morta in un incendio a soli diciannove anni nel letto di contenzione del dipartimento di salute mentale dell’Asl di Bergamo.
E qui veniamo al secondo punto. Commetteremmo un grave errore se pensassimo che il problema della privazione della libertà riguarda solo le persone che sono in carcere (circa sessantamila), anzi su questo la relazione ci aiuta a mettere a fuoco un concetto importante. Sono prive della libertà (sia pure in modo parziale) anche le persone anziane, disabili e non autosufficienti che sono ristrette in strutture pseudo-sanitarie (circa 340 mila), i migranti che transitano nei centri di espulsione (circa tremila), le persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio (circa ottomila), quelle che passano per le camere di sicurezza delle stazioni delle forze dell’ordine (circa 24 mila). Se sommiamo questi numeri, viene fuori innanzitutto che il tema della libertà e della tutela delle persone che ne sono private per una qualunque ragione, riguarda circa 500 mila persone l’anno; osserviamo poi che si moltiplicano per forma e tipologia i “contenitori” nei quali trascorrono le loro vite da reclusi, a diverso titolo, anziani, disabili, sofferenti psichici, migranti, e che si fa sempre più spazio un approccio psichiatrico-istituzionale che in questi luoghi non si sottrae all’ingrato compito di medicalizzare tutto senza offrire la cura per nulla. Torna, sullo sfondo, ma già vicina all’orizzonte, la logica del manicomio che si moltiplica in mille spore dalla forma diversa, ma che gemmano sempre la stessa pianta che ha per radice l’esclusione e che non offre mai lo sguardo al sole.
A questo proposito si legge nel rapporto una bella citazione di Albert Camus: “Quando si comincia a nominare bene le cose, diminuisce il disordine e la sofferenza che c’è nel mondo”. Se chiamiamo libertà il bene più importante della nostra vita, quella di ciascuno di noi, forse possiamo cominciare a chiederci di quanta e di quale prigione abbiamo davvero bisogno.
Questo articolo è stato pubblicato su Napoli Monitor il 7 luglio 2020










