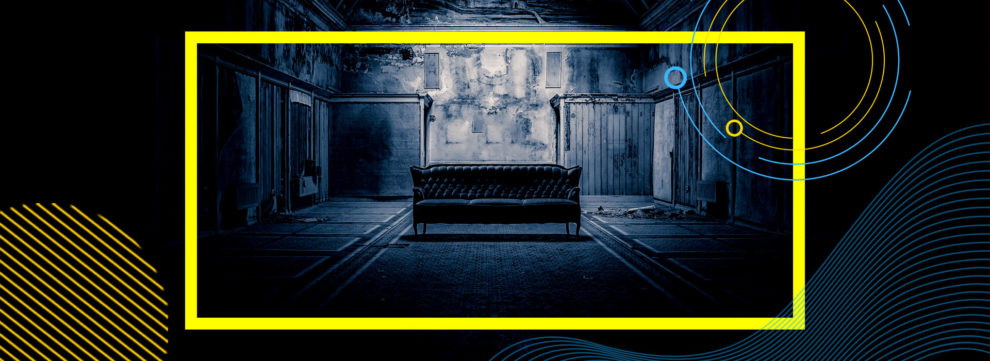di Carlotta Caciagli
Lo scenario è apocalittico: strade deserte e silenziose, mezzi pubblici vuoti o quasi, serrande abbassate. Chi cammina ha uno scopo: fare acquisti di prima necessità, portare a passeggio il cane, andare e tornare da lavoro (perché la produzione, come la speculazione finanziaria, non si ferma), fare un po’ di sport. Autocertificazioni alla mano, pronti a dimostrare dove, come e quando si è usciti di casa. Strade e piazze non servono ad altro che a connettere le case e i luoghi di lavoro o, al massimo, servono per le consegne a domicilio (i lavoratori e le lavoratrici delle piattaforme di food delivery, come gli operai, di stare a casa il diritto-dovere non ce l’hanno). Le città come le vedevamo prima dell’emergenza pandemia non ci sono più. Gli spazi collettivi urbani si sono dissolti, in poco più di una settimana.
L’emergenza Covid-19 ci mette davanti a una serie di contraddizioni che in molti hanno sottolineato. La contraddizione di una sanità pubblica che si è andata progressivamente privatizzando con il consenso più o meno tacito delle varie classi dirigenti, di uno stato sociale ridotto all’osso che oggi si dimostra non in grado di sostenere chi paga lo scotto con la perdita o la riduzione drastica del reddito da lavoro salariato. Ma c’è un’altra contraddizione che questa emergenza rende plastica: quella insita nel modello di sviluppo urbano che viene messo in pratica da oltre un trentennio, difeso da politiche securitarie e nel quale lo spazio pubblico viene svuotato dall’interno, fino a implodere su sé stesso.
Lo spazio urbano che si rende necessario al tempo del Coronavirus è solo la somma di tanti luoghi privati – le case – a cui si deve andare e tornare nel minor tempo possibile. Quando lo attraversiamo ci sentiamo in colpa, illegittimi. Il mondo esterno che inizia al di fuori delle mura domestiche ci mette a disagio, non ci appartiene più, sembra non essere di nessuno anziché di tutte e tutti. Ci sentiamo controllati, e in effetti lo siamo. Controllati da polizia e carabinieri, certo, ma anche da chi ci cammina accanto. Ci guardiamo male, siamo sospettosi per decreto. Assumiamo che l’altro se ne stia approfittando, che non abbia un vero motivo per uscire di casa (a differenza nostra, s’intende). E così tutti pronti a denunciarci a vicenda, magari non alle autorità, ma a una comunità virtuale attraverso piattaforme ancora più spaventose – i social networks – dove dilaga il sentimento più forte di tutti: la vergogna.
Senza spazio pubblico ieri e oggi
Questo scenario orwelliano di controllo capillare ci angoscia. Sentiamo forte e chiaro il peso della libertà che viene meno, ci sentiamo prigionieri nei luoghi della nostra quotidianità. Ma l’architettura urbana dell’emergenza è davvero così diversa dall’architettura neoliberista che conosciamo dalla fine degli anni Ottanta a oggi? La città che Minniti e Orlando prima e Salvini poi hanno in mente e che i loro decreti hanno cercato di realizzare è uno scenario totalmente altro da quello nel quale ci muovevamo fino a pochi giorni fa?
No, il modello urbano pre-Corona non è poi così diverso da quello di queste ore. L’arena politica e sociale è ridotta all’osso ora come allora, lo spazio pubblico marginale. La differenza è che oggi non ci sono happy hours e movida a mascherare questo dato di fatto. I numerosi eventi, i centri commerciali aperti nei fine settimana, le zone pedonalizzate e i tavolini dei bar ci hanno distolto dal riconoscere un dato cruciale: l’unica posizione che possiamo assumere nello spazio urbano è quella del consumatore o del produttore. Ogni altra attività che non fosse immediatamente riconducibile all’una o all’altra condizione è stata vista con sospetto prima e con timore poi. Non stiamo qui a ripercorrere le varie ordinanze comunali contro tutte quelle attività che non erano finalizzate a niente se non all’attraversare lo spazio pubblico. Sedersi su un marciapiede o mangiare un panino sono stati raccontati come attentati al decoro e alla sicurezza, atti di bivacco da condannare senza sé e senza ma. Non si è esitato a chiedere misure punitive per chi stava in quegli spazi contravvenendo all’imperativo del consumo e della produzione. Per loro si sono applicati stigmi come la pericolosità sociale e imposti gli obblighi o i divieti di dimora, il carcere. Adesso però che l’imperativo del consumo non può concretizzarsi ci immaginiamo altri modi di stare negli spazi. Ora che in galera ci sentiamo un po’ tutti e tutte qualche considerazione in più sullo spazio pubblico e sulla sua importanza dovremmo essere in grado di farla.
Il protagonismo della sfera privata
E c’è un’altra contraddizione che si interconnette a quella relativa allo spazio pubblico e che nelle ore dell’emergenza si palesa: quella relativa alla centralità dello spazio privato per eccellenza, ovvero la casa. Gli appelli a starci tutti e tutte arrivano da ogni pulpito: istituzioni, personaggi famosi, amici e conoscenti, residenti in Italia o all’estero. Casa è bene, fuori è male. Quest’associazione viene proposta con un meccanicismo talmente semplice da essere disarmante, inoppugnabile. Eppure è strano, perché le politiche messe in atto fino a oggi sono andate nella direzione opposta: la casa – e quindi starci dentro nei momenti di pericolo – non è un diritto di tutti, ma solo di chi se la può permettere. Fino a poche settimane fa chi voleva a tutti i costi una casa, chi la rivendicava come un diritto è stato punito, multato, umiliato con strumenti legislativi, prima ancora che repressivi, come con l’articolo 5 del Piano Casa Renzi-Lupi. Sono curiose quelle politiche che prima la casa te la tolgono e poi ti invitano a rinchiudertici.
In questa associazione meccanica, in base alla quale casa sta al bene come uscire sta al male, ci dimentichiamo di un’altra cosa importante e delicata: la casa e la famiglia non sono solo focolai caldi e accoglienti ai quali tornare, ma anche luoghi di conflitto. Può essere senz’altro piacevole stare a casa quando quest’ultima è una villa con piscina, un attico vista mare. Ma come può essere un luogo accogliente un appartamento di poche decine di metri quadri (perché queste solo le case che nel libero mercato molti e molte si possono permettere), senza spazi esterni, balconi, senza affacci ameni? Come si può vivere tranquillamente lo spazio domestico quando ci siamo costretti dentro e corriamo il rischio, per starci, di perdere il posto di lavoro? In che misura è accogliente un luogo così? Anche durante il Coronavirus le differenze sociali contano.
Senza uno spazio pubblico al quale quello personale e privato si interconnette, le case fanno presto a diventare prigioni. Adesso che la scuola non c’è e i bambini sono presi in carico ventiquattro ore al giorno dalle famiglie, ci rendiamo forse meglio conto di cosa diventerebbero le nostre case se ci fossero solo le nostre case. Quando invochiamo la proprietà privata come valore da mettere sopra tutto e tutti poi dobbiamo essere pronti anche a questo: a un mondo di sole proprietà private.
L’ambiente domestico ci rende individui, ma è quello pubblico che ci rende soggetti. Senza uno spazio collettivo siamo solo corpi contenuti e contenibili. Nel 1923 ne Il saggio sul dono Marcell Mauss analizzava come l’attraversare uno spazio per portare un dono e il tempo trascorso fra il donare e il ricevere fosse alla base della costruzione delle società. È dalla tensione verso il fuori – e tutti i rischi che questa comporta – che si strutturano i desideri, le passioni e tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere più dei nostri corpi, per non essere prigionieri delle nostre contingenze.
Non bastano le isole felici
L’emergenza pandemia ci sta facendo assaporare gli effetti e le implicazioni sulla nostra vita di un modello di sviluppo urbano che mette lo spazio privato al di sopra di tutto, un dominio totale e indiscusso contro cui molti e molte si sono battuti sul piano collettivo. Oggi però tutto ciò è evidente anche sul piano personale. Dovremmo non dimenticarcene più. Fra tutte le cose da rimettere in discussione nel post Coronavirus c’è anche questo: il modello di città che abbiamo in mente, il modo in cui gli spazi si articolano in modo complesso, il tipo di convivenza al quale ci siamo arresi. Lo scenario urbano che conosciamo e a cui siamo stati assuefatti per ora non c’è più, ma un’altra città non c’è ancora. Non basta praticarne forme alternative, non ci può più essere sufficiente la militanza in isole felici. Il momento per un altro modello è ora, quando quando il velo di Maya cade e il noumeno, la realtà, si mostra in modo disarmante. Anche se solo per un attimo, anche se solo per il tempo di una pandemia.
Questo articolo è stato pubblicato da Jacobin Italia il 17 marzo 2020