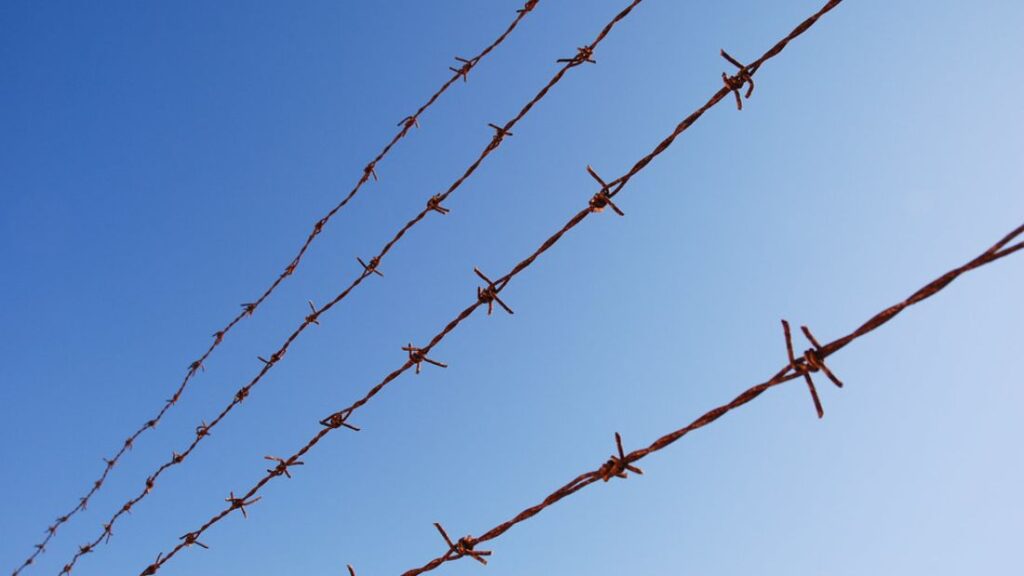di Thomas Piketty, traduzione di Fabio Galimberti
E così, alla fine, il Regno Unito ha lasciato ufficialmente l’Unione Europea. Non è un evento da sottovalutare: con l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca nel 2016, si tratta di uno sconvolgimento di primo piano nella storia della globalizzazione. I due Paesi che negli anni 80 avevano optato per l’ultraliberismo, con Reagan e Thatcher, e che da allora avevano registrato la più forte avanzata della disuguaglianza, tre decenni dopo decidono di puntare sul nazionalismo e su una sorta di ritorno alle frontiere e all’identità nazionale.
È un momento di svolta che può essere visto in diversi modi. In un certo senso, esprime il fallimento del reaganismo e del thatcherismo. Le classi medie e popolari americane e britanniche non hanno sperimentato la prosperità promessa dal liberismo integrale. Col passare del tempo, si sono sentite sempre più maltrattate dalla concorrenza internazionale e dal sistema economico mondiale.
Bisognava quindi trovare dei colpevoli: per Trump, erano i lavoratori messicani, la Cina e tutti gli infingardi del pianeta che si portano via, a detta sua, il duro lavoro dell’America bianca. Per i brexiter, erano i polacchi, l’Unione Europea e tutti quelli che se la prendono con la grandeur britannica.
La tentazione identitario e xenofoba
In prospettiva, la politica di ripiegamento nazionalista e identitario non risolverà nessuna delle grandi sfide del nostro tempo, la disuguaglianza e il clima, tanto più considerando che i trumpiani e i brexiter aggiungono un nuovo strato di dumping fiscale e sociale in favore dei più ricchi e dei più mobili, cosa che non farà altro che accrescere le disuguaglianze e le frustrazioni. Ma nell’immediato, il discorso nazional-liberista, per gli elettori che ancora votano, appare spesso l’unica riposta nuova e credibile al loro malessere, in mancanza di discorsi alternativi più convincenti.
Questo rischio di deriva ideologica oltrepassa di gran lunga i confini del mondo anglosassone. La tentazione identitaria e xenofoba esiste un po’ ovunque, in Italia o in Europa orientale, in Brasile o in India. In Germania, il centrodestra in Turingia ha appena eletto un Governo regionale con i voti dell’estrema destra, per la prima volta dalla fine della guerra.
In Francia, l’isteria arabofoba raggiunge nuove vette. Una parte crescente della stampa sembra pensare che la sinistra sia responsabile dell’ascesa dell’islamismo mondiale, a causa della sua permissività, del suo terzomondismo e dei suoi calcoli elettorali. In realtà, se gli elettori di origine nordafricana o subsahariana votano per i partiti di sinistra è innanzitutto a causa della violenta ostilità che la destra e l’estrema destra manifestano nei loro confronti, esattamente come succede nel caso degli elettori neri negli Stati Uniti o di quelli musulmani in India.
Fallimento collettivo
Al di là delle specificità nazionali, bisogna innanzitutto analizzare la Brexit per quello che è: la conseguenza di un fallimento collettivo del modo in cui è stata organizzata la globalizzazione economica dagli anni ’80 in poi, soprattutto all’interno dell’Unione Europea. Tutti i dirigenti europei che si sono susseguiti, in particolare quelli francesi e tedeschi, portano la loro parte di responsabilità. La libera circolazione dei capitali, dei beni e dei servizi senza una regolamentazione collettiva, senza una politica fiscale o sociale comune, funziona innanzitutto a beneficio dei più ricchi e dei più mobili, e fa a pezzi i più svantaggiati e i più fragili.
Non si può definire un progetto politico e un modello di sviluppo facendo leva semplicemente sul libero scambio, la concorrenza di tutti contro tutti e la disciplina di mercato. Certo, l’Unione Europea ha aggiunto due cose a questo schema generale di organizzazione dell’economia mondiale: la libera circolazione delle persone e un piccolo bilancio comune (1% del Pil europeo), alimentato dai contributi degli Stati e che finanzia trasferimenti di piccola entità dai Paesi più ricchi (circa lo 0,5% del loro Pil) a quelli più poveri.
Insieme alla moneta comune (che si trova anche nell’Africa occidentale), è l’elemento che più distingue l’Unione Europea dalle altre zone di libero scambio nel mondo, come per esempio quella nordamericana fra Messico, Stati Uniti e Canada, dove non esiste né libera circolazione delle persone né bilancio comune né fondi strutturali regionali.
Il problema è che questi due elementi sono insufficienti per ancorare i Paesi all’insieme. La scommessa dei brexiter è semplice: l’andamento attuale della globalizzazione consente di avere accesso al libero scambio di beni, servizi e capitali conservando il controllo sui flussi di persone, e senza l’obbligo di contribuire a un bilancio comune.
Una trappola mortale
Questa trappola mortale per l’Unione Europea può essere evitata solo ridefinendo radicalmente le regole della globalizzazione, con un approccio di tipo “social-federalista”. Per dirla in altro modo, il libero scambio dev’essere condizionato all’adozione di obbiettivi sociali vincolanti, che consentano di mettere gli operatori economici più ricchi e più mobili al servizio di un modello di sviluppo duraturo ed equo. Riassumendo: i nazionalisti se la prendono con la circolazione delle persone; il social-federalismo deve prendersela con la circolazione dei capitali e l’impunità fiscale dei più ricchi.
Karl Polanyi e Hannah Arendt, nel 1944 e nel 1951, denunciavano già l’ingenuità dei socialdemocratici di fronte ai flussi dei capitali e la timidezza del loro federalismo: la lezione è valida ancora oggi. Per andare in questa direzione, bisogna necessariamente rifondare i trattati europei e internazionali, cominciando da alcuni Paesi.
Nell’attesa, ognuno può e deve prendere misure e iniziative unilaterali, per esempio tassando le importazioni da Paesi e imprese che praticano un dumping fiscale. Se non riusciremo a opporgli un’alternativa risoluta, il nazional-liberismo travolgerà tutto sul suo passaggio.
L’autore è direttore degli studi presso la Scuola di studi superiori in scienze sociali / Scuola d’economia di Parigi
Questo articolo è stato pubblicato dal quotidiano La Repubblica il 16 febbraio 2020