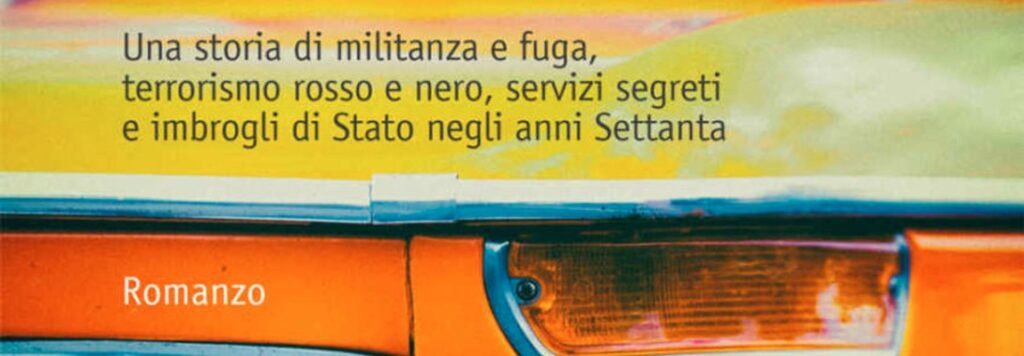di Adriano Prosperi
«Durante il caso Moro ho avuto la certezza di essere dentro un complotto di cui era impossibile arrivare a capo, di cui non sarei mai riuscito a capire nulla»: con queste parole Cesare Garboli spiegò quale fosse lo stato d’animo che lo aveva spinto a lasciare per sempre Roma e a rifugiarsi nella solitudine di Vado di Camaiore. Allora, fummo in molti a pensarla così. E se ci vollero ancora tante altre convulsioni e tanti altri rivolgimenti non solo italiani – a partire dal crollo del muro di Berlino – non c’è dubbio che cominciò proprio allora a muoversi la grande slavina che doveva seppellire la «prima Repubblica».
La metafora della slavina ci viene riproposta da Miguel Gotor nel volume “L’Italia del Novecento – Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon” (Einaudi, pp. XVIII – 590, € 22,00) per connotare la scomparsa totale di Pci (1991), Dc e Psi (1994) insieme a tutto l’assetto del sistema dei partiti. E tuttavia anche quella morte dei partiti era cominciata nel ’78, col caso Moro. Era stato l’episodio terminale della guerra a colpi di bombe e di terrorismo cominciata nel 1969 con la strage della Banca dell’Agricoltura. Fu quello il «momento umano» in cui, secondo la definizione di Marc Bloch, tanti processi e avvenimenti giunsero a stringersi «nel nodo possente delle coscienze». Nessuna occasione recente si presta come altrettanto ideale a verificare la celebre tesi del grande storico francese circa la natura psicologica dei fatti storici.
Oggi, il tentativo di gettare lo sguardo al di là di quella frontiera sembra quasi una forma di archeologia, un campo ancora aperto alla curiosità ma a una curiosità fredda, senza passione. È il segno del tempo che passa e ci costringe a vederci – noi vecchi – per quello che siamo: dei sopravvissuti. Di fatto, solo Enrico Deaglio, in La bomba Cinquant’anni di Piazza Fontana (Feltrinelli) fra i tanti che ne hanno parlato in questa fase di bilanci e ricorrenze, ha scritto pagine veramente appassionate, traboccanti d’ira e di dolore: forse perché ormai guarda all’Italia da una distanza non solo temporale ma anche geografica, che riaccende il fuoco di un amore deluso.
Verità figlia del tempo
Oggi, anche i preparativi della ricorrenza cinquantenaria della strage del 12 dicembre 1969 hanno avuto la compostezza e l’ufficialità riservate alle ricorrenze storiche di eventi vetusti. Sappiamo da tempo, ormai, che quella fu una dichiarazione di guerra alla Repubblica nata dalle Resistenza. Da allora, il nostro paese non è più tornato a una normale temperatura di convivenza civile. Tuttavia è un fatto che la nebbia di allora si è in gran parte dissolta. Verità, figlia del tempo, così dicevano gli antichi. Del nostro tempo, comunque, non dei secoli che ci sono voluti per leggere i documenti del caso Galileo.
Tornando all’ampia sintesi storica di Miguel Gotor in L’Italia del Novecento, questo libro rovescia il paradigma del mai citato «secolo breve» di Eric Hobsbawm. Il secolo scorso, che appare qui lunghissimo, resiste ancora al tentativo di essere consegnato a una storia finalmente e definitivamente chiusa, per non parlare delle eterne risse di cui ogni testimone di quegli anni – e Gotor era fra questi – porta ancora l’eco. La materia italiana è come un magma sotterraneo ancora ribollente. Ci sono protagonisti vivi e attivi: quanti dei lettori capiranno che Franco Freda, colpevole acclarato, impunito e impenitente di quell’attentato, resta tale insieme al defunto Giovanni Ventura per un balletto di vicende giudiziarie che definire vergognoso è insufficiente. E vive e scrive Adriano Sofri, colui che condannato sulla base di un processo che seppe di vendetta, come dimostrò uno storico dell’acume di Carlo Ginzburg, si rifiutò di fuggire davanti alla dura pena carceraria.
A una volontà di conoscenza particolare risponde la monumentale, accuratissima edizione critica del cosiddetto Memoriale di Aldo Moro 1978 (a cura di Francesco M. Biscione, Michele Di Sivo, Sergio Flamigni, Miguel Gotor, Ilaria Moroni, Antonella Padova, Stefano Twardzik, De Luca editori d’arte) coordinato da Michele Di Sivo, che riconosce come «dei precedenti inquisitori di antico regime quel processo aveva le caratteristiche essenziali», essendo il documento prodotto di un autore inquisito, capace di redigere un «raffinato e ponderato ragionamento» destinato a essere gestito da parte dei suoi carcerieri in un tempo più lungo di quello del gioco politico immediato a cui furono destinate le sue lettere. Edizioni di processi celebri della stessa dimensione e curati con lo stesso ricorso a filologia e ricerca storica furono quelli dell’Inquisizione a imputati eccellenti: a Galileo Galilei, per esempio, o a Giordano Bruno, che col caso Moro hanno in comune qualcosa che va al di là delle moltissime differenze, per riguardare piuttosto il sentimento di vergogna di chi ha voluto i processi: da un lato l’Inquisizione cattolica, dall’altro le Brigate rosse.
Nessuna scoperta
L’ombra di Giordano Bruno e quella di Galileo hanno certamente occupato le menti di chi, a distanza di tempo, si è trovato davanti all’errore compiuto e ha lottato in tutti i modi contro la sopravvivenza della memoria e la conoscenza di quelle carte. Con tutte le differenze del caso, forse qualcosa di simile ha riguardato anche la vicenda delle carte di questo processo. Il sedicente «tribunale del popolo» nel celebrarlo annunciò solennemente che vi si sarebbe accertata la verità su errori e delitti come la bomba di Piazza Fontana e che quella verità sarebbe stata annunciata. Ma non ci fu nessuna verità da comunicare: l’imputato fu ucciso e le carte del processo restarono invisibili.
Quando apparve alla luce, nel 1978, abbandonato nel «covo» milanese di via Montenevoso, il Memoriale aveva la forma di un dattiloscritto: del quale, va ricordato, si sono perdute le tracce. Passarono non pochi anni. Ma fu ancora in quel «covo» che nel 1990 una ispezione fortemente richiesta e voluta da Sergio Flamigni fece scoprire dietro una intercapedine la fotocopia di un originale manoscritto. All’inizio preso in carico dal generale Alberto Dalla Chiesa, questo documento è stato oggetto di un versamento anticipato da parte della Procura di Roma all’Archivio di Stato di Roma grazie all’interessamento di Michele Di Sivo, esperto studioso di processi storici, e viene adesso pubblicato: una grande opera elaborata con studi pazienti e approfonditi che trasforma quella serie non organica di fotocopie di un documento scritto in condizioni di violenza e di drammatica tensione in pagine di stampa dall’aria definitiva.
L’immagine di copertina mostra un Aldo Moro solenne e profetico. Ci si chiede se possiamo davvero dirci nella condizione di consegnare questo documento «alla storia». Le ragioni sono diverse, alcune di dettaglio ma non trascurabili, intanto, perché quelle fotocopie casualmente accozzate corrispondono a documenti autentici che forse sopravvivono, e chissà quante sono le persone ancora in vita che potrebbero completare, arricchire o almeno contestualizzare meglio il dossier. Ma è la natura stessa di quel documento a contrastare la voglia di leggerlo come una profezia. Il lettore si sente combattuto e perplesso davanti alla domanda su chi sia l’Aldo Moro di questo scritto: se il testimone e protagonista di una durissima battaglia politica ancora aperta, oppure il martire designato che guarda al futuro di un mondo senza di lui e lascia in eredità ai posteri la sua profezia.
Se scegliamo questa seconda via, Moro si distacca dalla scena di lotte non solo intellettuali per il possesso e la gestione del potere politico e si sposta di lato per unirsi a una ben diversa e più solenne compagnia: quella delle grandi ombre della tradizione intellettuale e religiosa italiana che hanno avuto nella prigione il loro luogo di macerazione e di sacrificio.
Grafia di stati d’animo
Un fatto è certo: Moro scrisse queste pagine nella fase in cui si preparava a una liberazione attesa a giorni, ricorrendo a stilemi a lui familiari e ad argomenti degni di un congresso della sua Dc, per giocare le proprie carte politiche in una partita viva come non mai. Su questo i curatori sembrano concordi. Michele Di Sivo pone correttamente il dilemma sulla natura del lavorio di Moro quando si chiede se il Memoriale fosse «il frutto di una manipolazione», oppure espressione «della capacità di Moro di vigilare il testo». E ricorda quale fosse la natura della risposta scritta di Moro alle domande dei carcerieri: una natura speciale, non di immediato consumo politico ma di più duratura e di lunga gestione, simile in questo alle confessioni dei prigionieri del carcere segreto dell’Inquisizione ecclesiastica.
Chi lo scrisse dovette elaborarlo come un testo che non si esponesse a smentite nell’immediato, ma anche tale da poter circolare di lì a non molto nel contesto di una battaglia nel paese da condurre in prima persona: non ha il tono, dunque, della profezia di una vittima in procinto di immolarsi. Di fatto, quando Antonella Padova cerca – nel volume – di cogliere dai segni grafici lo stato d’animo d ello scrivente, registra una vera e propria veemenza di toni alti nel rispondere a chi aveva dichiarato non autentiche le sue scritture.
L’autografia, secondo Padova, rivela l’ansia di decidere se potesse apparire più convincente e personale una calligrafia incerta e tremolante o una copiatura accurata e leggibile. Di nuovo – noi che fummo testimoni di quei lunghissimi giorni – ci troviamo davanti alla polemica suscitata allora dalla sciagurata dichiarazione di diversi «amici di Moro», persone peraltro note e rispettabili che sottoscrissero un pubblico disconoscimento dei suoi messaggi, in uscita dalla prigione brigatista. Un dato è indiscutibile: l’atroce ambiguità della posizione di Aldo Moro, che mentre ha davanti a sé le domande dei carcerieri, sa anche che quanto scriverà potrà essere reso noto e tornargli indietro con gli esiti e le risposte del mondo esterno – quelle dei compagni di partito e quelle di una opinione pubblica sconcertata, spaventata, non tutta disposta a simpatizzare per lui.
Non gli resta se non una soluzione: parlare di politica nel modo che gli è familiare e che gli ha consentito di esercitare sul suo partito una egemonia intellettuale e sull’opinione pubblica una funzione quasi soporifera, anestetizzante, ambedue in funzione del suo progetto di lentissimo avvicinamento – le allora famose e fumose «convergenze parallele» tra forze moderate cattoliche e masse comuniste. Se ne ha un buon campione nella risposta alla domanda sulla strage di Banca dell’Agricoltura: era questo un argomento su cui i brigatisti avevano promesso di scoprire la verità e di rivelarla al «popolo» di cui si autonominavano tribunale. Ma non raccontarono nulla di quanto Moro scrisse e oggi leggiamo nel Memoriale. Perché: ecco la domanda da rivolgere a chi ancora conserva ricordi e carte e responsabilità di cose e fatti.
Una sintesi infedele
Una sola verità ci resta, sulla strategia della tensione e sulla vicenda Moro: il complotto che allora ci apparve così enorme da evocare oscure potenze straniere in lotta sul corpo del paese Italia ha finito con lo svelare quasi soltanto volti familiari e le già conosciute tare radicate nella nostra società. Questa verità, tuttavia, non è diventata patrimonio delle nuove generazioni. Come ha scritto Antonio Carioti: «se chiedi a uno studente che cosa è successo quel 12 dicembre 1969, lui ti guarda perplesso: le Brigate rosse, risponde».
Questo articolo è stato pubblicato dal quotidiano Il manifesto il 5 gennaio 2020