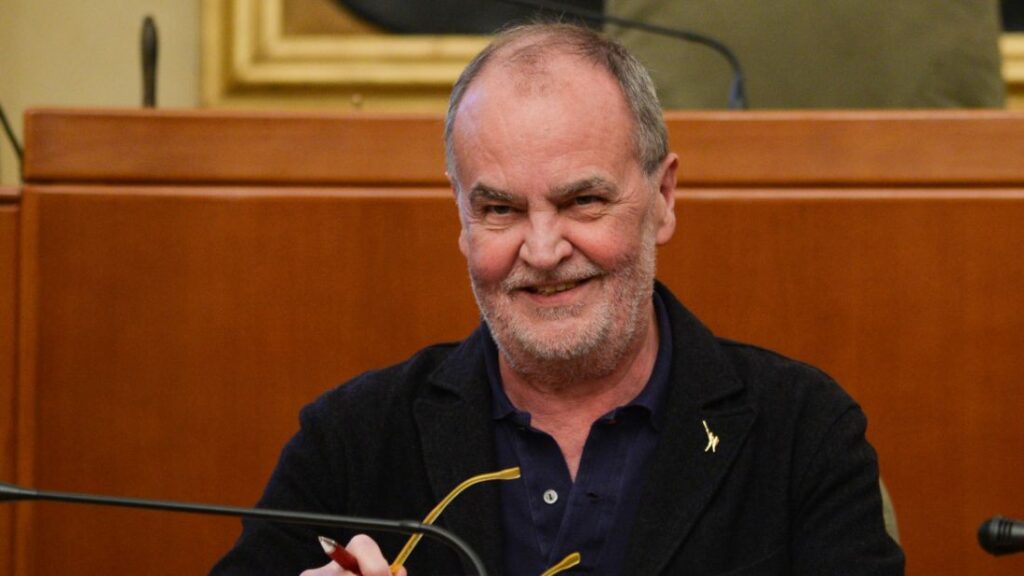di Salvatore Settis
Cento fantasmi si aggirano per l’Italia: le Province. Che andassero abolite lo sosteneva Licio Gelli e poi altri padri della patria, insistendo su questa indispensabile (per loro) misura di risparmio. Quanto fosse il risparmio non fu dato sapere fino alla lettera del Ragioniere Generale dello Stato (28 ottobre 2014) da cui risulta che “i risparmi di spesa che deriverebbero dall’abolizione delle Province non sono quantificabili” dato che “le funzioni svolte dovranno essere riallocate ad altri livelli di governo”.
Eppure la legge Delrio (2014), dando per scontata l’approvazione della riforma costituzionale Renzi-Boschi, già aboliva le Province, determinando l’attuale mostruosità giuridica, secondo cui le Province esistono, perché lo dice l’art. 114 della Costituzione vigente, e non esistono, perché così fantasticavano Renzi, Boschi e Delrio. Oggi le Province sono “enti di secondo livello” governati da un presidente (il sindaco del capoluogo) con un’assemblea di sindaci e consiglieri comunali.
La riforma Delrio (una sorta di eiaculatio praecox in attesa della riforma costituzionale poi abortita) prefigurava a livello locale lo stesso meccanismo di cooptazione, senza elezione diretta, previsto per il nuovo Senato, ma è rimasta in piedi anche dopo la solenne bocciatura di quel modello istituzionale. Risultato: non sono state abolite le Province, bensì gli elettori delle Province, cioè i cittadini. Per giunta restano al loro posto i prefetti (uno per ogni Provincia), che rappresentano il governo centrale.
Anzi la legge Madia ne accresce enormemente i poteri, per esempio ponendo alla “dipendenza funzionale dai prefetti” le Soprintendenze preposte alla tutela del paesaggio e dei beni culturali. Insomma, nelle Province manca un organo di governo eletto dal popolo, ma si è rafforzata l’autorità del governo centrale.
Ma le Province sono state veramente abolite? C’è da dubitarne. Due restano in piedi con identico nome (Trento e Bolzano), una (Aosta) continua a coincidere con la Regione, dieci cambiano etichetta diventando altrettante Città metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Roma, Napoli e Reggio Calabria), a cui le leggi regionali ne aggiungono altre cinque (Palermo, Catania, Messina, Cagliari, e ora Trieste). In Sicilia le Province sopravvivono travestite da “liberi consorzi”, in Friuli sono ribattezzate Uti (Unioni territoriali intercomunali), mentre le cinque Province della Sardegna sono state recentemente riordinate (2017), e in tre diverse regioni si sono riciclate alcune Province chiamandole “montane” (Belluno, Sondrio, Verbano).
Su 106 Province, ne sussistono di fatto 34 (il 32% del totale), mentre il caos nel trasferimento di personale e competenze sta avendo pesanti conseguenze sui servizi pubblici (scuole, musei, biblioteche), anche secondo la Corte dei Conti. Tale disastro istituzionale, coperto nella legge Delrio dalla giaculatoria “in attesa della riforma del Titolo V della Costituzione”, ha nella Carta vigente un solo tenue appoggio, la menzione delle Città metropolitane nell’art. 114 secondo la riforma del 2001. Pessima idea di una pessima riforma, il concetto di “città metropolitana” par fatto apposta per promuovere l’espansione a macchia d’olio delle città, l’urban sprawl che devasta aree preziosissime come la Pianura Padana o la Campania.
Eppure, se l’idea di abolire le Province ha avuto una sua popolarità una ragione c’è. La sottoarticolazione territoriale in Regioni e Province non ha mai funzionato bene, anzi ha creato a livello regionale potentati locali e mini-stati, come testimonia l’impropria etichetta di “governatore” prelevata di peso dal federalismo americano. Forse una riforma istituzionale ci vorrebbe davvero, e dovrebbe partire dalla Costituzione, che ovviamente può e anzi talvolta deve essere cambiata, ma un pezzo per volta e non all’ingrosso come usa in casa Renzi-Boschi.
Questa riforma (proviamo a ragionarne come se questo Paese avesse un governo, come se vi fosse qualcuno che traguarda verso il futuro non solo in termini di alleanze) dovrebbe cominciare con l’abolire la distinzione fra le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale. Ma dovrebbe ripensare alla radice l’assetto territoriale, sostituendo alla doppia articolazione Regioni-Province un’unica suddivisione in entità intermedie fra Stato e Comuni, e rivedendone le competenze attraverso una sapiente comparazione fra gli statuti delle Regioni alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Si potrebbero conseguire due risultati importanti: rilanciare il rapporto fra cittadini e territorio rivedendo confini, nomi e natura delle nostre “piccole patrie”. E rimescolare le carte delle sclerotizzate manovre politiche a orizzonte regionale, inaugurando una fase in cui i cittadini ripensino il destino dei territori a partire dai loro problemi e non dalle clientele di partito.
Il numero di queste nuove entità dovrebbe essere a metà fra Regioni e Province, intorno a quaranta. In alcuni casi (Aosta, Bolzano, Trento) esse potrebbero coincidere con le attuali Province. In altri, potrebbero essere “ritagliate” secondo criteri storici o geografici, con riferimento ad antiche ripartizioni d’area di cui l’Italia abbonda, per esempio Romagna, Casentino, Cadore, Marca Trevigiana, Polesine, Maremma, Sila. Nuove aggregazioni di cui si è spesso parlato, come l’ipotesi Lunezia che sommerebbe Parma, La Spezia e Massa-Carrara.
Entità raccolte intorno ad antiche città-Stato, da Mantova a Siena a Lucca. In una fase di discussione e progettazione, che dovrebbe coinvolgere i cittadini, si potrebbe ad esempio sostituire alla “città metropolitana” di Catania, etichetta che invita all’urbanizzazione sfrenata, un “Comprensorio dell’Etna”, che suggerisce il rispetto del paesaggio. “Comprensorio” potrebbe essere appunto il nome di queste nuove entità, ma la nostra storia offre numerose alternative (circondario, circoscrizione, cantone…).
Sarà sognar troppo in un Paese che nemmeno sa darsi una legge elettorale decente, per non dire di un governo? Ma annotiamole, questa e altre fantasie o messaggi in bottiglia. Chissà che non aiutino a pensare, e che un giorno o l’altro non vengano buone.
Questo articolo è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano il 9 maggio 2018