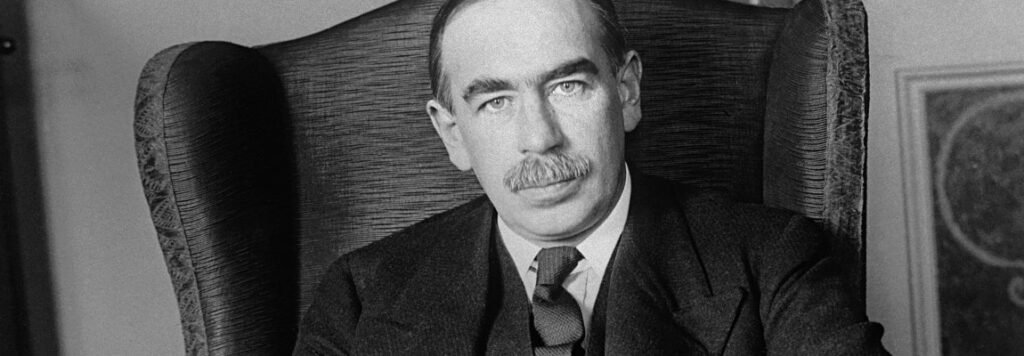Sono passati oramai quasi quarant’anni da quando Foucault con straordinaria lungimiranza teneva il famoso seminario (Nascita della biopolitica. 1978-79 [1]) nel quale proponeva una genealogia del neoliberalismo, letto come fenomeno epistemologico e “governamentale” emergente, ma di sicuro avvenire. Già dal 1973 in Francia era stato infatti precocemente annunciato l’imminente tramonto di quell'”età d’oro” delle politiche keynesiane, da Stato provvidenziale, che erano invalse nei paesi capitalisti dal dopoguerra fino appunto alla metà degli anni ’70 [2].
1. Ascesa ed apogeo
Quanto ne è seguito non ha fatto che confermare questa previsione. Impugnato come bandiera da Reagan e dalla Thatcher, coi loro famigerati slogan “meno stato, più mercato”, “no alternative!”, il neoliberalismo si è trovato a cavalcare da conquistatore la stagione segnata dal crollo del muro di Berlino, il disfacimento dell’Urss e la conversione capitalistica della Cina.
Uscita trionfante da tali prove, questa dottrina ha quindi iniziato a impiantarsi ovunque nel mondo, influenzando a suo modo le più clamorose novità intervenute tra il secondo e terzo millennio: dalla “globalizzazione dei mercati”alla “rivoluzione informatica”, dalla “finanziarizzazione dell’economia” all’ unificazione monetaria di buona parte dell’Europa, dal nuovo sviluppo di paesi già “arretrati” (i cosiddetti Bric) al progressivo approfondirsi della povertà su tutto il pianeta. E così via.
Il mondo che ne è uscito pare distante anni luce dal mondo quale era una quarantina di anni fa, quando, non solo era spaccato in due, tra paesi capitalisti e paesi socialisti, ma era anche popolato da una molteplicità di prospettive strategiche che si pensavano e sperimentavano in modi diversi e contrastanti tra loro.
Dalla fine del secolo scorso ad oggi, invece, si può dire non ci sia più azienda o istituzione pubblica e privata sulla faccia della terra che non abbia fatto propri linguaggio e visuale del neoliberalismo. Così, niente lo qualifica meglio della sua definizione come “pensiero unico”. Esso detiene infatti un monopolio culturale verso il quale oramai finiscono per convergere, sia pur con diverse velocità e giustificazioni, praticamente tutti i diversi schieramenti partitici e governativi, su scala planetaria.
Il tutto mentre la “guerra al terrorismo”, lanciata dai paesi più ricchi e più accanitamente neoliberali, sta destabilizzando intere aree del pianeta: per la gioia dei più sfrenati commerci di armi, materie prime, droga e simili, e per la disdetta di sempre più vaste popolazioni costrette a fuggire ed ad ingrossare ulteriormente la già esorbitante povertà sul globo.
Patria indiscussa del neoliberalismo restano sempre gli Stati Uniti [3]. I quali tramite le loro reti comunicative e le loro università esportano questo modello culturale, plasmando così in modo sempre più univoco “ceto medio” e “classi dirigenti” di ogni altro paese sulla faccia della terra. Russia e Cina inclusi.
Se la supremazia economica e militare a stelle e strisce è meno certa di un tempo, più certa che mai rimane invece la sua egemonia planetaria a livello “intellettuale”.
2. Una cosa sconcertante
Dal 2008 però qualcosa è cambiato. La crisi che sta degenerando in stagnazione di lungo periodo ha infatti finito per smorzare gli entusiasmi dei più ferventi apologeti del neoliberalismo. I suoi riconosciuti progenitori, come Ludwig Von Mises, Friedrich Von Hayeck e Milton Friedman, non trovano più giovani eredi in grado di ridare smalto al loro lascito. A quasi nessuno viene più in mente di celebrare le “meravigliose sorti e progressive” che questo “pensiero unico” promette. A ricevere maggiori consensi oggi sono economisti come Krugman, Stiglitz, Piketty o Varoufakis e le loro dettagliate ricette anti-neoliberali. Ricette, che hanno come solo difetto di richiedere un potere di governo per essere applicate, mentre questo potere resta quasi dappertutto talmente dipendente dagli “umori” dei mercati da non potersi permettere alcuna svolta clamorosa.
Ciò nonostante, ad alleggiare attorno alle politiche neoliberali non è più certo quell’aura trionfale che le ha accompagnate al finire del secondo millennio. Oggi su di esse grava piuttosto l’ombra del discredito: che esse siano fonte di una sempre maggiore sperequazione tra ricchi e poveri, che esse escludano qualsiasi rimedio efficace per la ripresa dello sviluppo sono opinioni oggi quanto mai condivise.
Così accade una cosa assai sconcertante: che, malgrado questa crisi di consensi, malgrado tutti i dubbi che le politiche neoliberali suscitano, esse continuano a non trovare alternative, dunque ad influenzare la maggior parte dei governi esistenti. Insomma, è come se tutti oramai sapessero che la nave globale ha preso una rotta sbagliata, ma il timone restasse bloccato nella stessa direzione, perché nessuno sarebbe in grado di indirizzarla verso una nuova rotta.
3. Alternative?
Un modo per consolarsi di questa sconcertante realtà lo si trova nelle supposizioni (ontologiche) “post-operaiste” e/o di “sinistra”. Secondo queste supposizioni l’alternativa ci sarebbe già bella e pronta, perché sarebbe radicata nell’essenza “buona”, altruistica e cooperante, della stessa umanità. Quell’essenza buona dell’umanità che si manifesterebbe nei fenomeni di lotta e di resistenza alla conseguenze più letali delle politiche neoliberiste.
Senza considerare l’episodicità, la frammentarietà e la costante reversibilità di tali fenomeni li si enfatizza come sintomi di una più o meno imminente svolta epocale a seguito della quale la lotta di classe e le rivendicazioni di diritti “dal basso” potrebbero ritornare ad essere diffuse come più di quarant’anni fa. Anziché capire l’ipoteca asservente che su ogni comportamento impone lo strapotere della cultura neoliberale se ne suppone addirittura un uso alternativo, di sinistra o, se si preferisce, da “moltitudine”.
Uno dei paradossi più estremi cui giungono queste supposizioni riguarda ad esempio la categoria della “biopolitica”. Foucault non aveva forse sostenuto che le politiche neoliberali si esercitano sulle stesse condizioni dei viventi in quanto tali, dunque si configurano come “bio-potere”? Ebbene, da un punto di vista delle supposte ontologie “di sinistra” ciò significa che basta vivere in modo altruistico e cooperante per avere già un’alternativa al neoliberalismo. Cosicché l’unico problema politico starebbe nel celebrare e nel mettere in comunicazione tra loro queste esperienze “alternative”.
Non diversamente pensano ed agiscono non pochi dei centri sociali, collettivi, coalizioni o reti “di sinistra” che pullulano in Italia e altrove nel mondo esattamente da quando lo stesso neoliberalismo imperversa ovunque. I legittimi risentimenti contro di esso trovano così un loro sfogo, ma nessuna reale alternativa prende piede. Quanti summit, quanti G8 o 20 di pura facciata, inutili, perché ipotecati da trattative condotte altrove, hanno avuto come sfondo proteste certamente più che giustificate, ma politicamente inefficaci, frustranti e spesso dannose per i loro stessi partecipanti?
Il fatto è che, lungi dall’essere individualistico ed élitistico come lo è il liberalismo classico d’origine britannica, il neoliberalismo, che è invece d’origine più prettamente americana, è profondamente comunitario e “democratico”. Contrariamente a quanto credono le sue critiche più banali, e che oggi vanno per la maggiore, il neoliberalismo non esclude affatto, ma contempla espressamente altruismo, cooperativismo e filantropia. Solo che li contempla in un senso del tutto particolare: all’unico scopo di celebrare e favorire il primato evolutivo di quelle comunità che si dimostrano più funzionali alla selezione meritocratica degli individui più capaci in termini concorrenziali.
Ecco dunque che in quest’ottica non c’è nessuna difficoltà nel coesistere con “altre” comunità, anche quelle più dichiaratamente anticoncorrenziali o anticapitaliste: è proprio il loro riconoscimento a confermare la necessità di mettere “in sicurezza” e di favorire le comunità supposte essere vincenti perché più concorrenziali. L’aspetto polemico, antagonistico, bellicoso nei confronti di comunità diverse da quelle da promuovere è insomma del tutto necessario al modo di pensare e di governare propri dello stesso neoliberalismo [4].
Ciò significa che oggi lotte sporadiche, rivolte momentanee, proteste occasionali e rivendicazioni estemporanee sono tanto più legittime ed inevitabili quanto più fungono da banco di sperimentazione delle politiche neoliberali.
4. “Il punto di vista del lavoratore”
Niente da fare, dunque? Tutto al contrario, ce ne è fin troppo. Ma quello da attivare non è un fare “naturale”, “spontaneo”, da supporsi ontologicamente scaturente dalla sostanza buona dell’umanità. Quello da attivare e organizzare oggi è un fare intelligentemente elaborato, capace di visioni strategiche.
Per orientarsi in tal senso vale allora la pena di ritornare alle analisi di Foucault sul neoliberalismo, in quanto in esse si può trovare spiegato quello che è uno dei maggiori segreti del successo di questa corrente di pensiero. Capendo meglio questo segreto sapremo meglio cosa ci vuole per cercare effettive alternative politiche a quelle neoliberali.
Cosa dice dunque Foucault di tanto interessante? Molte cose, ma qui ne considero una che trovo cruciale. Si tratta di quello che Foucault chiama “il punto di vista del lavoratore” [5]. Secondo lui, il grande merito del neoliberalismo sarebbe proprio quello di fare quello che non era mai stato fatto in precedenza: porsi da questo punto di vista. Tale è il merito che egli riconosce soprattutto al premio nobel Gary Becker, primo promotore di quel concetto del “capitale umano”, il quale sarebbe l’unica condizione epistemologica per analizzare e valutare le scelte di chi di capitale non ne possiede affatto, ma per vivere non può che lavorare; un lavorare che comunque presuppone delle competenze, quanto meno “muscolari”: competenze che sarebbero da gestire appunto come qualsiasi capitalista fa col proprio capitale.
Ad una prima lettura di questa argomentazione non si può non avere l’impressione che Foucault con essa stia cedendo al gusto della provocazione. Non sarebbe infatti stato proprio il bersaglio polemico principale di questa corrente neoliberale, non sarebbe stato proprio Marx ad averlo scoperto e fatto valere, questo “punto di vista del lavoratore”? ben prima e ben diversamente da Gary Becker?
Foucault lo nega decisamente, ma lo fa in un modo che, letto attentamente, non risulta affatto provocatorio. Egli infatti spiega come in Marx il lavoro resti sempre un concetto astratto, considerato dall’esterno, analizzato nei termini esclusivamente quantitativi della forza e del tempo ceduti al capitalista: dunque sì certo evidenziandone il rapporto storicamente e generalmente conflittuale col capitale che lo sfrutta, ma mai chiedendosi cosa i lavoratori possano in concreto pensare e volere.
5. Il punto di vista del Partito
Certo, si può obiettare che, al seguito di Marx, i successi del socialismo e del comunismo nell’arco di un secolo e mezzo stanno lì a dimostrare [6] quante enormi masse di lavoratori si siano fatte coinvolgere da un entusiasmo senza precedenti per il “punto di vista” del marxismo – cioè per ciò che in suo nome si voleva una “scienza”, quella del materialismo storico e dialettico. Checché se ne dica oggi, questa formazione intellettuale e politica di intere popolazioni sfruttate, povere e poco o nulla istruite è stato un fenomeno storico di una vastità e un’intensità senza pari. Il merito di ciò va principalmente a tutti quegli innumerevoli militanti che durante questo secolo e mezzo si sono dedicati ad educare gli operai per elevarne la coscienza a coscienza “di classe”. In questa opera si è inevitabilmente messa alla prova l’indicazione socratica della maieutica: se i militanti marxisti sono riusciti a crearsi un tale straordinario seguito è stato sicuramente perché hanno saputo convincere i loro ascoltatori partendo dal loro linguaggio e dalle loro condizioni concrete di vita, di lavoro e sfruttamento.
Tuttavia resta che, per quanto ci sia stata attenzione per le condizioni del lavoratore, in nome del marxismo gli è stata sempre proposta una prospettiva, quella rivoluzionaria e comunista, che restava sempre la stessa, indipendentemente da ogni situazione concreta e singolare. Il fatto è che la prospettiva rivoluzionaria e comunista è sempre stata derivata da un filosofema storico millenarista, quello per cui il trionfo mondiale del comunismo avrebbe dovuto essere un destino prima o poi inevitabile. Così ogni intervento in suo nome ha sempre significato l’applicazione in concreto di tale visione storica millenarista: un’applicazione su cui i Partiti Comunisti, specie dal secondo dopoguerra in poi, hanno finito per imporre il proprio monopolio.
Per venire dritti al punto, si può convenire con quello che è un costante presupposto più o meno esplicito di Foucault: che il “punto di vista del lavoratore” per il marxismo ha finito per significare solo “il punto di vista del Partito (comunista) sul lavoratore”.
Certo un’eccezione c’è stata. Un’eccezione alla quale lo stesso Foucault non è restato del tutto insensibile [7]. Essa riguarda il marxismo così come è stato sperimentato nel corso di quelle contestazioni attorno al “’68″ che hanno preso di mira anche gli stessi Partiti comunisti, assieme tutte le organizzazioni ad essi connesse. Questa eccezione è stata simboleggiata anzitutto dagli straordinari e sia pur momentanei consensi planetari riscossi dalla cifra ampiamente enigmatica del maoismo. E sopratutto da una delle più note tesi sostenute in suo nome. Quella secondo la quale anche le masse pensano: pensano a loro modo, diverso da qualunque forma di coscienza possa essere dedotta nei termini del materialismo storico e dialettico.
Ciò ha portato ad esaltare l’inchiesta tra i lavoratori come necessaria fonte di ispirazione per la ricerca di politiche alternative a quelle capitaliste. Ma il declino della credibilità mondiale del marxismo ha finito per estenuare in gran parte queste ricerche nel corso degli anni ’70, inficiando anche la portata di ogni loro successiva ripresa.
6. Il ciclo dell’antagonismo anticapitalistico
Non a caso i primi successi delle teorie neoliberali in proposito si collocano a ridosso di questa stessa sequenza. Esse in effetti sono riuscite a requisire quel “punto di vista del lavoratore” che aveva fatto la forza del marxismo, dei Partiti comunisti e di tutte le organizzazioni connesse. Importante è capire che un tale spossessamento è stato possibile quando questa forza ha cominciato a indebolirsi per l’accumularsi delle conseguenze dei suoi vizi d’origine. Anzitutto proprio quello segnalato da Foucault: aver considerato il punto di vista del lavoratore dall’esterno, non in rapporto a cosa gli stessi lavoratori pensano, ma in rapporto all’antagonismo che essi possono esprimere nei confronti del capitale.
Tre passaggi storici del secondo dopoguerra sono fondamentali per capire come la sperimentazione di tale antagonismo di classe sia andata progressivamente estenuandosi.
Il primo è grosso modo tra il ’47 e la metà degli anni ’50 quando l’antagonismo comunista nei confronti del capitale ha raggiunto un livello così estremo da divenire politicamente impraticabile. A ciò infatti ha portato la conflittualità tra il sistema capitalista a modello americano e il sistema socialista a modello sovietico; una conflittualità che si è meritata l’appellativo di “guerra” sì “fredda”, ma che si è comunque spinta sino alle soglie del rischio di una distruzione atomica planetaria.
Il secondo è quando, dopo la morte di Stalin e la destalinizzazione diretta da Chruščëv, l’apogeo bellicista dell’antagonismo anticapitalista ha cominciato sia pur contraddittoriamente a declinare in nome della “coesistenza pacifica”. Quando cioè entrambi le due superpotenze, già nemiche mortali, hanno cominciato invece a riconoscersi come concorrenti nella stessa gara: quella di realizzare il benessere di tutta l’umanità.
Il terzo è quando, nella seconda metà degli anni ’70, le contestazioni e le organizzazioni rivoluzionarie insorte attorno al “’68, non si sono dimostrate in grado di riportare in auge l’antagonismo di classe contro il capitale, così come era stato inteso prima della costruzione dell’Urss.
Tre momenti, questi, che hanno dunque formato una sorta di ciclo: il ciclo che ha segnato il destino dell’antagonismo anticapitalista nel secondo dopoguerra.
In effetti, è solo alla conclusione di questo ciclo che l’operazione neoliberale è diventata relativamente facile: è bastato convertire tale supposto antagonismo in compatibilità, anzi in conformità. Ecco quindi che i comportamenti del lavoratore hanno potuto cominciare ad essere analizzati conformemente a quelli del capitalista, come se fossero quelli di un capitalista: anche se pur di un capitalista che non ha altro capitale se non le sue competenze ossia il suo cosiddetto capitale umano.
Di qui in avanti non c’è più stato argine a tutte le conseguenze che si potevano trarre da questo spunto iniziale. Ecco allora l’imperversare delle favole sul dovere divenire “manager di se stesso”, sull'”empowerment, sul “monitoraggio delle risorse umane”, sulla personalizzazione del lavoro e così via. Il tutto portando sempre alla stessa morale: che se sei retribuito poco, sei trattato male come lavoratore, se neanche riesci a trovarlo, un lavoro, tutto ciò lo si deve imputare solo a te, alla tua cattiva gestione del tuo stesso “capitale umano”.
Un'”ovvietà” questa divenuta oggi quasi banale, ma che fa rimuovere il fatto questo sì quanto mai ovvio per davvero: che per un operaio capace di diventare “manager di se stesso” ce ne saranno sempre migliaia e migliaia che non potranno farlo. Ma soprattutto che fa vedere negli operai delle “persone”, mentre tutti sanno che le loro condizioni di vita sono e resteranno sempre un problema impersonale, deciso da strategie globali che nessuna persona in quanto tale può minimamente influenzare.
7. Una problematica inesplorata
Dove cercare degli orientamenti alternativi per non farsi travolgere da una simile deriva?
Cercando di ritrovare come stella polare il solito concetto generale del lavoro [8]? In realtà, così si non fa altro che cercare di far girare all’indietro la ruota della storia – come si diceva un tempo. Il successo di tale concetto nel secondo dopoguerra infatti aveva tra le sue condizioni anzitutto il successo dei Partiti e delle altre organizzazioni di classe. Senza tali organizzazioni, con la disgregazione attuale dei lavoratori da quarant’anni soggetti a politiche neoliberali, ritornare a rivendicare il rispetto del lavoro in generale finisce inevitabilmente per risultare anacronistico [9].
Così ad esempio in Italia pretendere di arroccarsi attorno ai valori dell’articolo 1 della nostra Costituzione significa solo nascondere il fatto incontrovertibile che il concetto del “lavoro” (nonostante sia sempre formalmente mantenuto come fondamento di tutta la nostra giurisprudenza) si trova da tempo già completamente destituito di senso a causa della famosa legge detta “Biagi”. Ciò che con essa si impone è infatti un ben diverso concetto: quello “dei lavori”, sarebbe a dire del lavoro così come viene definito in ogni situazione particolare dalle relazioni interpersonali tra chi lo offre e chi lo accetta.
Dobbiamo allora piuttosto andare a ricercare qualche ispirazione tra le righe del magistrale insegnamento di Foucault? Certo, come vedremo meglio in seguito, ciò può essere di una qualche utilità, ma non è dirimente. Per quanto magistrale questo insegnamento una pecca infatti ce l’ha. E non da poco. Accreditando il pensiero neoliberale come il primo modo di porsi dal punto di vista del lavoratore Foucault infatti sostiene una cosa quanto mai unilaterale. Più esatto sarebbe riconoscere che il pensiero neoliberale molto più semplicemente estende il punto di vista del capitalista fino ad includere, fino a colonizzare anche quello del lavoratore: fino a fare come se capitalista e lavoratore dovessero vivere e ragionare allo stesso modo.
Un’idea, questa, certo molto “democratica”, molto all’americana, ma che dimentica un fatto cruciale: detto in poche parole (che spiegherò meglio in seguito), che mentre il primo governa di fatto la vita di tanti altri che neanche conosce, il secondo è tale solo in quanto fatica per governare anche solo la propria vita.
Inquadrato in una simile prospettiva, il punto di vista del lavoratore risulta tutt’ora, anche in termini epistemologici, un terreno problematico in gran parte inesplorato.
È di qui dunque, da questa fatica di ogni lavoratore a governare la propria vita, che sarebbe opportuno ricominciare a studiare, anche per ridare spunti utili a politiche alternative a quelle neoliberali. Ecco allora che sarebbe l’inchiesta, l’inchiesta tra i lavoratori, l’inchiesta su ciò che i lavoratori pensano, a dover tornare in auge.
Se tutte le esperienze condotte in nome del marxismo e del comunismo sono state esperienze guidate da una scienza e da politiche ispirate da una filosofia della storia e da una critica dell’economia politica, oggi per riprendere esperienze simili non sarebbe dunque il caso di cambiare almeno in parte i riferimenti epistemologici? Non sarebbe il caso di dare priorità a ricerche di tipo antropologico ed etnografico? Ricerche di tipo antropologico ed etnografico che ponessero al centro ciò che pensa chi lavora, cioè chi fatica per governare la propria vita?
8. Una profonda diversità
Quando si parla di fare inchiesta tra i lavoratori la prima cosa che oggi viene in mente è quella di cui Romano Alquati è considerato il maggiore epigono e che (spesso solo con vaga attinenza al suo stesso complesso insegnamento [10]) si chiama “conricerca”. Termine col quale si intende anzitutto ricerca fatta “insieme”: insieme tra i ricercatori e le popolazioni interpellate dalla ricerca.
Ciò significa, da un lato, adottare un metodo d’indagine, non principalmente “dall’alto”, sociologico e statistico, ma anzitutto “dal basso”, a diretto contatto, in stile antropologico e etnografico, con i soggetti da indagare. E su questo non c’è nulla da eccepire.
Ma, dall’altro lato, ciò che si usa chiamare il metodo della “conricerca” comporta un ulteriore presupposto, questo invece tutto da ridiscutere. In effetti, l’unione tra i ricercatori e le popolazioni interpellate dalla ricerca, alla quale si allude con questo termine, sarebbe garantita a priori dal fatto che entrambi queste figure, quella indagante e quella indagata, si porrebbero sullo stesso fronte della lotta di classe: quello dell’antagonismo anticapitalista.
Ecco allora che in qualsiasi “conricerca” si sa sempre in anticipo a quale risultato si deve giungere: individuare e analizzare come, dove e fino a quale grado si esprime la coscienza dell’antagonismo di classe.
Ora, certo, se non si vuol finire sedotti del canto delle sirene neoliberali, come a suo tempo è capitato allo stesso Foucault, è assolutamente necessario supporre che tra il punto di vista del lavoratore e il punto di vista del capitalista non ci sia convergenza, ma profonda diversità; tuttavia se si giunge subito alla conclusione che questa diversità si deve tradurre sempre in coscienza antagonista, e dunque in comportamenti di lotta più o meno manifesta, si finisce per eludere proprio la domanda più importante di tutte, ossia proprio quella che consiste nel chiedersi cosa pensano in concreto i lavoratori.
Perché tale domanda sia posta al centro delle inchieste occorre interrogarsi preliminarmente, metodologicamente, per stabilire in che cosa consista questa differenza tra il punto di vista del lavoratore e il punto di vista del capitalista.
Marx, specie con le sue magistrali analisi de Il capitale , ha egregiamente insegnato che questa differenza sta nel fatto che il primo è sfruttato, mentre il secondo è sfruttatore. Niente da obiettare. Ma appunto non basta. Non basta perché si tratta di una spiegazione economica, una spiegazione che non spiega nulla antropologicamente, se non col ricorso al filosofema storicistico secondo il quale ogni sfruttato prima o poi si ribellerà. Il fatto è però che il detto “là dove c’è oppressione, c’è rivolta” ha fatto il suo tempo e comunque non si spiega nulla di cosa pensa l'”oppresso” quando, come oggi accade sempre più spesso, non si rivolta, né si organizza concretamente per farlo.
Questione prioritaria diventa allora precisare ulteriormente la profondità di questa differenza tra il punto di vista del lavoratore e il punto di vista del capitalista.
9. Il metodo della disconnessione
In proposito può essere di qualche utilità tornare al lessico e alle problematiche di Foucault, anche per essere giusti con la sua opera e non attribuirle, come qualche commentatore è stato tentato di fare [11], un definitivo cedimento alle dottrine neoliberali. In effetti, se questo cedimento c’è effettivamente stato, nella sua opera c’è di che ripensarlo altrimenti.
Non si tratta qui di ripercorrere il tragitto compiuto da tale opera e che l’ha portata a reiterate e spesso monumentali ricerche sui temi del dominio assoggettante o viceversa produttivo del potere e del sapere, della sessualità, delle strategie di governo, dei regimi di verità e così via. Né occorre discutere quanto sia condivisibile il presupposto spesso rivendicato da Foucault secondo il quale le uniche alternative sono da cercare nella resistenza dei corpi o nel pullulare nascosto di esperienze e saperi dimenticati. Tanto meno si tratta di condividere l’approccio critico del suo pensiero che, sulle tracce anzitutto di Kant e Nietzsche, si è voluto prima epistemologico ed archeologico, poi genealogico, infine ispirato a quell’ideale etico del cinismo antico chiamato il coraggio della verità.
Basta riconoscere che Foucault, come il suo amico e commentatore Deleuze, ha sempre cercato di distinguere radicalmente, di disconnettere le diverse problematiche affrontate, alla reiterata ricerca delle loro differenziazioni e delle loro discontinuità [12]. Così ad esempio già nel suo libro Le parole e le cose [13]del ’66 il sapere quale si è configurato e riconfigurato tra il XV e il XIX secolo viene analizzato come irriducibilmente duplice: tanto profondamente scisso da non conciliare neanche il parlare e il vedere, i quali sono assunti come due dimensioni intrinsecamente disgiunte. Come dice appunto il commento di Deleuze su questo punto, l’approccio di Foucault permette di capire come nel sapere moderno “non si vede ciò di cui si parla, e non si parla di ciò che si vede” [14]. Una disconnessione, questa, che si spiega con l’antiumanismo di tale approccio, insistentemente ostile nei confronti della figura dell’umanità quale soggetto unificante il tutto. In Le parole e le cose, infatti, si può dire che ad essere pensati come soggetti o meglio come agenti protagonisti della storia non siano per nulla l’umanità o meno che mai le persone o gli autori, ma proprio quelle figure epistemologiche che Foucault chiama i saperi (soprattutto quelli relativi al linguaggio, alla vita e all’economia) nel loro reciproco condizionarsi e differenziarsi nel corso dei loro sviluppi.
Perché questo metodo della disconnessione [15] è così importante? perché resta un’arma sempre utile per fronteggiare il “pensiero unico” neoliberale? Di primo acchito si può rispondere: proprio perché quest’ultimo è unico, perché punta costantemente a trovare un’unica relazione che connette, unifica con le altre ogni problematica intellettuale, scientifica, sociale, politica ed economica.
“Disconnettere il sapere” significherà dunque non solo restituire ciò che è più proprio ad ogni sua problematica, ma anche rivelare la miseria intellettuale dell’isomorfismo [16] omologante rivendicato da tale pensiero unico neoliberale.
10. Sapere comunicare?
In effetti, tale pensiero da quando Foucault ne ha fatto la sua critica in parte accondiscendente [17] ha avuto ulteriori sviluppi specie in riferimento a quella che è stata chiamata la “rivoluzione informatica”. Ulteriori sviluppi che hanno più che mai confermato questa propensione a trovare una relazione capace di spiegare e cambiare ogni altra. Tale relazione, supposta essere una sorta di chiave universale, è stata enfatizzata grazie ad una tesi avveniristica: la tesi secondo la quale ogni società sarebbe (destinata a divenire) “società della conoscenza”, cosicché anche la produzione diventerebbe un fatto immateriale [18].
Da allora ad oggi, numerosi eventi (tra i quali la bolla finanziaria scoppiata nella new- ovvero nella net-economy già nei primi anni ’90) si sono incaricati di sbugiardare questa tesi. Essa continua però ad imperversare come del resto tutti i dogmi neoliberali ad essa connessi, destinati come sono a replicarsi fino a che non intervenga un’alternativa.
La “conoscenza” dunque come matrice di ogni società: questo un dogma cruciale per il neoliberalismo nella sua fase più sviluppata – e anche per coloro che, credendo che basti criticarlo come semplice dottrina egoistica e inumana, finiscono per assecondare serenamente questo dogma come se fosse un dato scontato.
Ma qual è dunque il tipo di conoscenza prediletta dal neoliberalismo? È un tipo di conoscenza assai particolare che non ha precedenti nella storia del pensiero. Si tratta di un sapere che, senza pretendere di sovrastare tutti gli altri (come ad esempio il Sapere Assoluto di Hegel o più genericamente il sapere divino nelle religioni), si pone trasversalmente a tutti gli altri: rappresenta la possibilità di renderli interscambiabili, di metterli in comunicazione tra loro, proprio come il mercato regolato dal denaro che rende merce scambiabile ogni prodotto materiale o intellettuale. Ecco allora che per il neoliberalismo divenuto sistematicamente cognitivista, la relazione cognitiva immanente, ma onnipresente, che lo giustifica come “pensiero unico” sta proprio nella comunicazione ossia nello scambio di informazioni [19].
Da tale angolatura oggi ovunque assunta, il problema epistemologico principale allora non sta più nel distinguere i diversi orizzonti, le diverse problematiche che intessono il sapere e dunque dischiudono l’esperienza e la conoscenza a svariate possibilità. Molto più importante diventa la distinzione tra un saper fare, implicito, informale, corporale, e un sapere esplicito, formale, accademico. Una distinzione, questa, che serve anzitutto all’obiettivo di confondere, di mixare queste due diverse dimensioni del sapere.
Due sono allora le operazione congiunte che servono a tale obiettivo e che ritroviamo costantemente perseguite in ogni ambito della cultura del nostro tempo. Da un lato, elevare la credibilità del sapere implicito, informale, corporale, esaltandone e valorizzandone l’aspetto emotivo. Dall’altro, rimettere invece in discussione la tradizionale razionalità del sapere esplicito, formale e accademico, criticato per il suo essere freddo, autoreferenziale, élitario o burocratico. Il tutto col risultato di imporre ovunque il valore di un unico supposto sapere “intermedio”: quel sapere pragmatico che si ritiene fondato sulle capacità di comunicare informazioni. Un sapere, questo, che la biologia neo-darwiniana, fedele ancella del neoliberalismo cognitivista, suppone addirittura come condizione della stessa evoluzione di tutti gli esseri viventi [20].
Una misura evidente delle conseguenze politiche di un tale rivolgimento epistemologico può venire ad esempio se si pensa alla qualifica rivendicata in Italia dal primo governo creato fuori di ogni legittimazione istituzionale: quel governo Monti il quale ha riscosso il suo breve ma significativo momento di consensi mediatici presentandosi come “governo del fare”.
Altra misura di tali conseguenze può venire se si pensa che attualmente ogni comportamento, da quello del lavoratore a quello dell’impiegato, da quello del ricercatore universitario a quello del manager, può essere valutato [21] tramite parametri simili a quelli utilizzati dalle famigerate agenzie di rating finanziario.
Ecco dunque dove sta una risorsa fondamentale del successo del neoliberalismo: nell’avere demagogicamente dato dignità al sapere più tipico dei lavoratori, cioè al “sapere fare” concependolo come sapere pari ad ogni altro.
Ma ecco anche l’aspetto più reazionario del pensiero unico neoliberale: l’aver dato dignità al “sapere fare” solo a condizione che si renda interscambiabile con altri saperi, più in particolare con quelli di cui ogni potere sugli altri si è sempre avvalso: ancora più in particolare, con quelli di cui il capitalismo si è avvalso e si avvale (applicando le scienze alla produzione) per imporre e gestire il suo potere sulla società.
Ed ecco anche, infine, perché il metodo della disconnessione di Foucault può tornare utile per criticare questo “pensiero unico”: perché permette di concepire che il “sapere fare”, per quanto sia interscambiabile con altri saperi, mantenga sempre e comunque una sua specificità. La specificità di essere un sapere che si forma anzitutto in rapporto al fare, al fare come attività concernente anzitutto le cose, e non il potere sugli altri, che sia esso subito od esercitato.
11. Il reale
Qui sta dunque un punto decisivo per la ricerca di una differenziazione tra il punto di vista del capitalista e il punto di vista del lavoratore [22].
In che consiste infatti la condizione singolare del lavoratore se non il suo diretto rapportarsi alle cose? a quelle con le quali a che fare nel suo lavoro (attrezzi, catena di montaggio e così via) e a quelle, come alloggio, cibo e ogni tipo di assistenza che gli mancano se il lavoro gli manca?
E in che consiste invece la condizione che il capitalista condivide con ogni altra figura tradizionale o moderna del potere, se non nel condizionare la vita di altri, ai fini particolari di ricavarne profitto?
Se proviamo a scollegare fino in fondo queste due figure avremo dunque un’asimmetria radicale: quella per cui il lavoratore in quanto tale, non ha altro sapere che il sapere fare, cioè la capacità di rapportarsi alle cose, senza detenere alcun potere nel condizionare la vita degli altri; mentre il capitalista si caratterizza principalmente per il sapere col quale gestisce il suo potere nei confronti degli altri: più in particolare, di quegli altri, i lavoratori, che sono sfruttati tramite investimenti di capitale.
Questa distinzione può certo scandalizzare il marxista dogmatico sempre fedele a quell’idea di totalità storico-sociale per la quale ogni relazione è sempre in dialettica con ogni altra. Così si dirà che l’operaio è tale solo perché c’è il capitale che lo usa, ossia che ogni relazione con le cose è anche relazione con gli altri. E tuttavia contro simili obiezioni si può ricordare che lo stesso Marx ha anche sempre tenuto a distinguere tra la una “base socio economica” più reale, imperniata attorno alla produzione di cose, e una “sovrastruttura” tutta intessuta di relazioni di potere. Senza nulla rimpiangere di questa topica, materialista storica e dialettica, va comunque ribadito che se ci si vuol mantenere nel solco della tradizione materialista la dimensione delle cose, del reale, dunque anche del lavoro quando è la prima condizione di vita, va sempre tenuta distinta da quella delle relazioni con gli altri.
Del resto, anche in economia non si è soliti distinguere tra l’economia “reale”, che produce cose, da quella che invece funziona tutta tramite segni convenzionali, monetari? Il fatto è che però questa distinzione è poco economicamente pertinente dal momento che anche l’economia detta “reale” funziona solo se è finanziata da quella convenzionale. Tale distinzione è invece del tutto pertinente se ci si pone in un’ottica antropologica. Solo da questa angolatura è infatti rilevante ammettere che ogni economia non solo si fonda su due settori diversi tra loro come la produzione e il commercio, ma necessita anche all’interno della stessa produzione di due attività, di due tipi di esperienza e di conoscenza profondamente diversi tra loro: da un lato, quelli volti alla gestione del potere aziendale e tecnologico, dall’altro, quelli dediti invece anzitutto a mettere mano alle cose, a erogare fatica per provvedere alla propria esistenza
In proposito può infine tornare utile anche rifarsi alla problematica psicanalitica lacaniana dei tre registri del “Simbolico”, dell'”Immaginario” e del “Reale”, i quali sono sempre da ritenersi tra loro annodati, ma secondo modi diversi a seconda del primato detenuto da uno di questi tre registri. Ecco allora che si potrà dire che il punto di vista del lavoratore, pur essendo condizionato dal simbolico e dall’immaginario, ha più direttamente a che fare col reale. Se non altro, più direttamente di quanto avviene dal punto di vista del capitalista.
12. Inchieste tra i lavoratori
Perché dunque è così necessario per un’ottica antropologica e etnografica distinguere il punto di vista del lavoratore dal punto di vista del capitalista? Perché solo così si può fare inchiesta su cosa pensano i lavoratori, concentrandoci su ciò che rende la loro esperienza più reale, più in rapporto sulle cose con cui hanno che fare o che loro mancano.
È solo così che si potrebbe entrare finalmente nel merito di questo terreno epistemologico finora sconosciuto.
Ed è solo così che si potrebbero concepire politiche effettivamente alternative a quelle neoliberali.
Come infatti si può pretendere di trovare simili alternative senza sapere sul serio cosa i lavoratori pensano? O come si può pretendere di saperlo, basandosi solo sui sondaggi d’opinione o sui reportage d’informazione che le attuali “società della conoscenza” ci propinano in continuazione? O ci si dovrebbe fidare di quello che dei lavoratori dicono i partiti o gli aspiranti tali che si vogliono “di sinistra” solo perché provano di imitare quello che sono stati i partiti “di classe” di quarant’anni fa?
Ciò che più manca oggi sono proprio delle organizzazioni capaci di condurre inchieste tra i lavoratori. Certo non mancano collettivi, coalizioni, reti di sinistra o gruppi di ricerca che si impegnano da tempo e a volte in modo interessante [23] in inchieste simili. Ma troppo spesso l’ ipotesi strategica è già definita in nome dell'”antagonismo di classe” o della “partecipazione democratica”. Circa quarant’anni di quasi incontrastata egemonia neoliberale dovrebbero però bastare per convincere di quanto oggi sia necessario aprirsi a nuovi orizzonti per cercare strategie davvero alternative a tale egemonia. E tra questi orizzonti un posto di rilievo andrebbe sicuramente dato al punto di vista di chi non ha altre risorse che il proprio lavoro.
Sono dunque le parole dei lavoratori, il loro stesso pensiero in rapporto a cosa fanno che dovrebbero essere al centro delle inchieste volte a trovare di che contrastare le politiche neoliberali.
Certo, non tutto quello dicono i lavoratori è oro colato per il solo fatto di essere enunciato da loro. Ma ancora più certo è che essi sperimentano una relazione con il reale, che ai capitalisti resta estranea, e che per ciò resta del tutto incognita alla cultura dominante.
È dunque proprio questo patrimonio immenso di elaborazioni intellettuali provenienti dalla fatica di provvedere alla propria esistenza, è questa preziosa risorsa continuamene sprecata, che l’inchiesta dovrebbe puntare a rivelare e mettere in circolazione.
A tal scopo sarebbero comunque indispensabili metodi ad hoc. In antropologia le discussioni, per quanto complesse e spesso confuse, sono aperte [24]. Non lo sono a livello politico. Sarebbe il caso che si riaprissero.
13. Conclusioni
Finché i governi resteranno così condizionati come sono attualmente dagli “umori” dei mercati non si troveranno mai alternative alle politiche neoliberali.
Per rompere questo condizionamento ci vorrebbe un profondo rivolgimento in questo o quel paese, per giungere al quale non c’è che una condizione: dar voce a ciò pensano i lavoratori. Ma questo dar voce non sarà mai possibile se questo pensiero non sarà adeguatamente studiato, conosciuto e preso come riferimento decisivo per concepire e promuovere un radicale rinnovamento politico.
Quanto poi a Foucault, ha probabilmente ragione Michael Behrent quando lo inquadra come un “liberale antiumanista”. E tuttavia va riconosciuto che il suo è comunque un antiumanismo particolarmente creativo (capace di rendere possibile un’inedita epistemologia della molteplicità dei saperi senza unità, se non contingente e singolare), e certo pure con implicazioni nichiliste, ma di un nichilismo abbastanza “attivo” da poter ispirare una ripresa contemporanea, materialista e post-marxista, della causa dei lavoratori.
Note
- [1] Michel Foucault, Naissance de la Biopolitique. Cours au Collège de France. 1978/79, Seuil/Gallimard, Paris 2004 (trad. it. di Mauro Bertani e Valeria Zini, La nascita della biopolitica. Corsi al Collège de France 1978/79, Feltrinelli, Milano, 2005).
- [2] [2] Come fa notare Michael C. Behrent, Le libéralisme sans l’humanisme. Michel Foucault et la philosophie du libre marché. 1976-79 in Daniel Zamora (a cura di), Critiquer Foucault. Les années 1980 et la tentation néoliberale , Aden, Bruxelles, 2014, pp.50-1.
- [3] Certo tra le prime fonti del neoliberalismo Foucault segnala e analizza magistralmente l’ordo-liberalismo tedesco dal quale sarebbe condizionata la stessa costituzione della Repubblica Federale post-nazista. Resta però da lui poco considerato il fatto quanto mai evidente che in questo pezzo di Germania sul fronte più caldo della Guerra Fredda non poteva accadere nulla che gli Stati Uniti non avessero previsto e avallato fin nei più minimi dettagli. Dimenticarlo oggi può indurre in inopportune sopravvalutazioni dell’autonomia della Germania e del suo ruolo di guardiano dell’austerità nell’Ue, fino addirittura a vedere nelle politiche dell’amministrazione Obama un’alternativa all’austerità neoliberale del governo della Merkel.
- [4] Tra i cui testi sacri andrebbe annoverato anche il famigerato Samuel P. Hungtington, The clash of civilizations and the remaking of world order, Simon & Schuster, New York, 1996,(trad.it. di Sergio Minucci, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti, Milano, 2000).
- [5] Michel Foucault, Naissance.. (cit.): Leçon du 14 mars 1979, pp.222-39.
- [6] .. e proprio perciò negati dalla cultura neoliberale che li riduce a frutto avvelenato di un’ideologia totalitaria.
- [7] Si veda ad esempio il colloquio del 1971 con Chomsky.
- [8] Come sembrano tentare le ultime proposte della Cgil.>
- [9] tanto più che in paesi come l’Italia, e più in generale in tutti quelli più ricchi, l’importante aumento di popolazioni straniere tra i lavoratori ha completamente riconfigurato questa categoria e i suoi rapporti con la controparte capitalistica.
- [10] Romano Alquati, Per fare conricerca, Calusca, Padova, 1993.
- [11] Si veda ad esempio il libro collettivo a cura Daniel Zamora, Critiquer Foucault… cit.
- [12] Tema questo cui Judith Revel ha dedicato il suo interessante Foucault, une pensée du discontinu, Mille et un nuits, Paris, 2010, comunque tutto orientato a confermare quella compatibilità tra Marx e lo stesso Foucault che è oggi un tema privilegiato dai post-operaisti (vedi ad esempio: Toni Negri, Un’esperienza marxista di Foucault).
- [13] Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Gallimard, Paris, 1966 (trad. it di Emilio Panaitescu, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane,, Rizzoli, Milano, 1967).
- [14] Gilles Deleuze, Foucault, Minuit, Paris,1983, p.117 (trad. it. di Pier Aldo Rovatti e Federica Sossi, Foucault , Cronopio, Napoli, 2002).
- [15] vedi soprattutto Qu’est-ce que les Lumières? (What is Enlighthenment? in the Foucault Reader, Pantheon Books, New York, 1984) in Dits et écrits.1954-1988, tome 4: 1980-88, Gallimard, Paris, 1994 (trad. it. in Kant, Foucault, Cos’è l’Illuminismo?, Mimesis edizioni, 2012) p. 576.
- [16] Una critica decisiva della categoria d'”isomoformismo” in campo linguistico la si trova in Jean-Claude Milner, Introduction à une science du language, Seuil, Paris, 1995, pp.275-90, testo dal quale sono tratte non poche delle considerazioni esposte qui di seguito.
- [17] Questa accondiscendenza ha certo profonde radici nel pensiero di Foucault. Si può in effetti convenire con Michael C. Behrent (Le libéralisme sans l’humanisme, cit.) quando gli attribuisce un apprezzamento fondamentale per la stessa tradizione del liberalismo economico. Merito principale di questa tradizione agli occhi di Foucault sarebbe stato quello di aver coltivato l’idea “che si governa sempre troppo” (Naissance del biopolitique, cit. p. 324) e dunque di avere rappresentato un’alternativa a quegli eccessi di potere legittimati invece dall’altra, più arcaica, visione del potere: quella giuridica e sovranista. Constatazioni, queste, che mi paiono pertinenti e degne di ulteriori considerazioni, ma che non obbligano comunque a ridurre l’opera del filosofo francese ad una semplice variante dello stesso liberalismo. Né tanto meno a considerarlo correo dello strapotere che il neoliberalismo ha guadagnato con le sue ulteriori elaborazioni dopo gli anni Settanta.
- [18] In proposito e a proposito di tutte le considerazioni che seguono rimando all’introduzione del libro collettivo da me curato Fuori della società della conoscenza. Ricerche di etnografia del pensiero, Infinito edizioni, Roma, 2009.
- [19] La controversia tra il sapere come pluralità univoca e il sapere come molteplicità infinita è cominciata con la rivoluzione copernicana, come spiega tra l’altro uno dei maestri di Foucault: Alexander Koyré (specie in From the Closed World to the Infinite Universe (1957) – trad. it.di Luca Cafiero, Dal mondo chiuso all’universo infinito, Feltrinelli, Milano, 1970). Ma la controversia non è ancora finita, anzi è ripresa più che mai con la restaurazione della prima opzione ovunque imposta appunto dal neoliberalismo cognitivista, tramite quello che si potrebbe chiamare il culto dell’informazione. Ed è soprattutto volendo opporsi a questo culto che Foucault, assieme ad altri antiumanisti francesi degli anni Cinquanta e Sessanta come Lacan e Althusser, risulta riferimento prezioso.
- [20] D’obbligo è qui ricordare la magistrale critica di Richard Lewontin, Biology as Ideology. The doctrine of DNA, Harepr collins, London, 1993 (trad it. Biologia come ideologia.La dottrina del Dna, Bollati-borighieri, Torino, 1993).
- [21] Vedi Valeria Pinto, Valutare e punire, Cronopio editore, Napoli, 2012.
- [22] Per non esagerarne i meriti occorre tener presente che lo stesso Foucault si è ben guardato anche solo dall’adombrare qualcosa di simile. Trattando del “rapporto con le cose”, anche in Qu’est-ce que les Lumières? cit. – dove questo tema è quanto mai centrale – egli non fa mai menzione delle questioni del lavoro.
- [23] Un esempio ne è il libro collettivo (In) sicurezze. Sguardi sul mondo neoliberale fra antropologia, sociologia e studi politici (a cura di Javier Gonzalez Diez, Stefano Pratesi , Ana Cristina Vargas), Novalogos, Aprilia, 2014, di cui ho già discusso altrove.
- [24]Rimando qui ancora una volta a Fuori della società della conoscenza…, cit.
Questo articolo è stato pubblicato su Inchiesta online il 19 marzo 2916