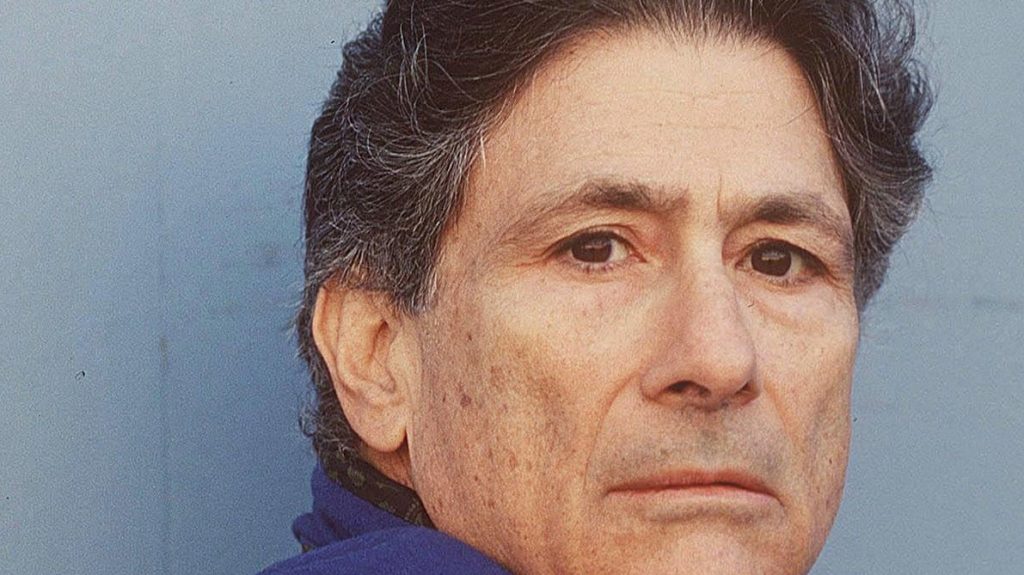Tre reporter italiani, Paolo Battaglia, Daniela Garutti e Giulia Frigieri, sono partiti questo fine settembre in un tour alla ricerca di storie dal finale “They made it”. Il loro viaggio interamente autofinanziato, ora si vuole concretizzare in un libro e un documentario e per ottenere i fondi hanno lanciato una campagna di crowdfunding sul sito indiegogo. Abbiamo chiesto a Daniela Garutti di raccontarci le sue impressioni del viaggio.
Siamo partiti il 29 settembre con l’obiettivo di incontrare e intervistare persone di origine italiana che vivono nelle piccole comunità sparse per tutti gli States. Dopo 35 giorni di viaggio, 10.100 km al volante, 16 tappe e 25 stati attraversati dalla East alla West Coast, 130 ore di guida e 130 di sonno, 6 aerei, 105 persone intervistate originarie di 19 regioni italiane, 60 ore di materiale video girato e più di 8.000 fotografie, siamo tornati nella “Old Country”, come chiamano gli italiani d’America la madrepatria, con abbastanza materiale per lavorare su un duplice progetto: editoriale e documentaristico. Libro e documentario sono al centro di una campagna di crowdfunding che permette a chiunque lo desideri di contribuire a distanza e che si chiuderà il 29 novembre.
Alle origini di questo viaggio c’è una ricerca di due anni, sfociata nel libro di Paolo Battaglia “Trovare l’America. Storia illustrata dell’esperienza italo-americana attraverso le collezioni della Library of Congress”, pubblicato nel 2013 in Italia e negli Stati Uniti. Il successo della pubblicazione e l’accoglienza avuta negli States l’hanno incoraggiato a continuare la ricerca nel presente.
Abbiamo scelto alcune delle cittadine americane – e alcune grandi città – più italiane e abbiamo percorso, centocinquant’anni dopo, il viaggio che milioni di emigrati fecero verso una nuova opportunità di vita, per se stessi e per chi sarebbe venuto dopo. Volevamo incontrarne i discendenti, gli Italian Americans di oggi, chiedere loro di condividere i propri ricordi con noi e ricambiare con i nostri. Volevamo comprenderli e comprenderci meglio, vedere quanta Italia fosse rimasta in queste comunità e – perché no – quanta America ci fosse in noi.
Abbiamo incontrato intere famiglie ansiose di raccontare l’avventura dei propri nonni o dei genitori, partiti da ogni parte d’Italia per trovare impiego come cavatori, minatori, muratori o braccianti agricoli, gli unici mestieri a cui potesse accedere un aspirante cittadino dal cognome italiano. Che abitassero negli slum di New York, nelle company home di proprietà delle compagnie minerarie o nei ranch del Nevada, gli emigrati italiani si americanizzarono in fretta per necessità di sopravvivenza: molti di essi cambiarono il proprio cognome in uno anglosassone, tutti spinsero i figli ad abbandonare la lingua italiana in favore di quella inglese, mantenendo invece vivi alcuni elementi di identità come la religione cattolica, la cucina, i legami sociali con gli altri connazionali emigrati, specie se dello stesso paese d’origine.
I loro discendenti, oggi, sembrano aver perfettamente completato il sogno americano degli avi: sono proprietari terrieri o imprenditori, governatori e giudici, medici, ex giocatori di football, commercianti. Hanno perso, e se ne pentono, la lingua d’origine – ricordando solo qualche espressione dialettale – e i loro figli scelgono di studiarla a scuola. C’è un generale, nuovo interesse negli States per tutto ciò che è italiano: l’arte, il cibo, la lingua, la cultura. Molti hanno fatto ricerche genealogiche, e ad Ellis Island abbiamo assistito a un composto pellegrinaggio delle origini.
A Tontitown, in Arkansas, così chiamata in onore dell’esploratore italiano Enrico Tonti, abbiamo incontrato i discendenti di un nucleo di veneti ed emiliani stabilitisi qui nel 1898. Qualche anno dopo essersi insediati a Lake Village, circa 300 miglia a sud, sulle sponde del Mississippi, queste famiglie decisero di fuggire da una zona insalubre e da condizioni di lavoro pressoché schiavistiche. Con l’aiuto del prete forlivese Bandini si stabilirono qui e avviarono pratiche di coltivazione che oggi rendono il paesaggio e i prodotti agricoli molto simili alla pianura padana. Lì abbiamo sentito qualche anziano parlare il dialetto vicentino mescolato all’americano. Sentire esclamare ‘Ostrega!’ o ‘Me son dasmentegà”, “mi sono dimenticato” nel bel mezzo dell’Arkansas è stata una sorpresa!
A Barre, in Vermont, in pieno centro svetta la statua di un uomo con in mano un martello e uno scalpello. È Carlo Abate, “scultore, mentore e amico”, come recita l’iscrizione, che da Milano alla fine dell’Ottocento portò la sua arte in America, da emigrato, e la insegnò per anni. Sul basamento una dedica: “In onore di tutti gli italoamericani le cui conquiste arricchirono la vita sociale, culturale e civile di questa città, questa regione e questo Stato. I nipoti e gli amici”.
Gli italiani emigrati a Barre si affermarono grazie ai segreti della lavorazione della pietra, che portarono con sé quando vi approdarono alla fine dell’Ottocento. Gli scultori toscani (ma anche emiliani e veneti) fusero la propria esperienza alla tecnica dei cavatori scozzesi, arrivati pochi anni prima, facendo della cittadina la capitale americana del granito.
Qui abbiamo incontrato Mark Gherardi, titolare della Buttura & Gherardi Granite Artisans, una delle maggiori aziende di lavorazione del granito da cinque generazioni. E qui abbiamo scoperto che gli immigrati italiani erano fortemente politicizzati: gran parte aderì al movimento anarchico. Il più noto di essi fu Luigi Galleani, che a Barre nel 1903 iniziò a pubblicare la rivista Cronaca Sovversiva. Una traccia dell’importanza di questo gruppo nel paese si può trovare nel cimitero locale, dove su una lapide posta in prossimità del bosco, accanto al nome e alla data di morte campeggia soltanto una parola italian: Anarchico.