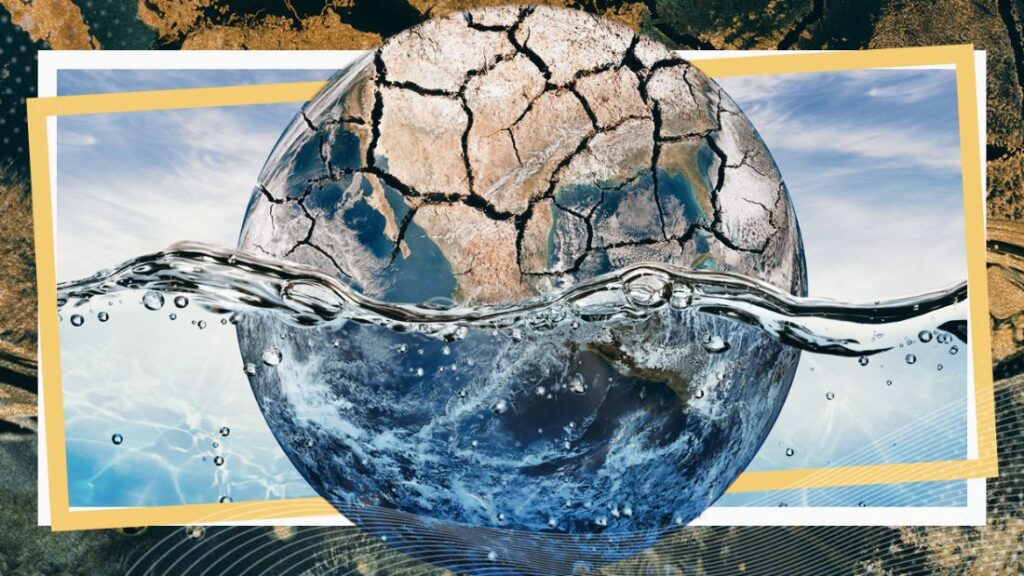E’ sbagliato prospettare la transizione ecologica come mera sostituzione di fonti di energia rinnovabile a quelle fossili perché le cose possano continuare a svolgersi come prima. Ci sono molti altri fattori che incidono sul riscaldamento globale e che incideranno sull’organizzazione delle nostre vite. Innanzitutto, l’agricoltura industriale che insterilisce e uccide il suolo, impedendogli di assorbire carbonio ed emette gas che contribuiscono al riscaldamento della Terra molte volte più della CO2. La maggior parte dei suoli coltivati e delle derrate prodotte è destinata all’alimentazione animale, cioè alla produzione di carne e latticini, che per questo sono fra le cause maggiori dei cambiamenti climatici. Anche il riscaldamento dei mari e degli oceani riduce la loro capacità di assorbire carbonio. Sono processi che continueranno ad aumentare il riscaldamento globale per decenni anche se l’emissione di CO2 cessasse domani; il che, ovviamente non può succedere: non solo perché, anche volendo, la costruzione degli impianti per la generazione di energia rinnovabile richiede tempo, ma soprattutto perché la necessità di lasciare gli idrocarburi sotto terra non è ancora entrata nella testa della maggior parte della gente e soprattutto in quella di coloro che con i fossili fanno profitti o pensano che abbandonarli minerebbe il loro potere. Poi, lo scioglimento del permafrost emette metano e la scomparsa dei ghiacciai e delle calotte polari aumenta l’assorbimento del calore prodotto dai raggi solari. Sono processi che si alimentano da soli, spingendo il riscaldamento globale verso l’irreversibilità.
Questi processi obbligheranno comunque tutti a cambiare abitudini: a cercare di vivere con meno perché la terra assolata, desertificata e attraversata da uragani e alluvioni produrrà meno; e anche l’industria, il commercio e il turismo, sconvolti da disastri ambientali sempre più frequenti, non saranno più quelli che conosciamo. Le nostre vite saranno comunque sempre più difficili e ai nostri figli e nipoti andrà anche peggio. L’alternativa che abbiamo di fronte è lasciare che la “natura”, sconvolta, faccia il suo corso, peggiorando progressivamente la vita di tutti, a partire da quella di chi ha meno, fino alla completa estinzione del genere umano; oppure ridurre ovunque in modo programmato il consumo di madre Terra e le diseguaglianze che permettono a pochi di continuare ad arricchirsi e a vivere nel lusso a spese dei più, della loro miseria e, sempre più spesso, della loro morte. Bisogna adoperarsi non solo per bloccare al più presto il ricorso ai fossili (mitigazione), ma anche prepararsi alle condizioni più difficili in cui ci si verrà a trovare (adattamento). Ma a imboccare una strada del genere non saranno certo le imprese o i Governi. L’ecologia “calata dall’alto” è sempre menzogna. Ma nemmeno si può pensare a un cambio di rotta lasciando che ognuno si arrangi “come può”.
Bisogna creare l’ambito in cui possa svolgersi una vera transizione o, meglio, una conversione ecologica consapevole, volontaria e desiderabile: certo, affidata all’urgenza di evitare il peggio; ma anche, e soprattutto, a una svolta culturale irrinunciabile. Non c’è più niente da sostituire: la cultura, intesa come capacità di confrontarsi con i problemi della propria epoca, è morta da tempo, sloggiata dal sequestro dell’informazione da parte dei big della rete (la Grande Cecità ha ormai investito tutti i settori); ma soprattutto azzerata dalla perdita del confronto fisico, dell’incontro faccia a faccia, dello sguardo rivolto non solo alle altre persone, ma anche a tutta la vita che ci circonda.
Per questo l’ambito di questa transizione non può che nascere dalla ricostituzione di una comunità, di molte comunità, fondate su relazioni il più possibile dirette tra le persone e tra persone e cose: “naturali” e artificiali, belle o brutte, utili o dannose; dobbiamo imparare a curarci anche delle cose brutte e dannose per trasformarle, o cancellarle con cose belle e utili. Per portare avanti la transizione le comunità dovranno riunirsi – specie là dove prevalgono le interdipendenze, ma perseguendo ciascuna il massimo di autonomia possibile – in quegli aggregati di abitanti che sono le città, dove ormai si ritrova più della metà della popolazione mondiale. Il termine città indica un territorio, il suo assetto urbanistico, i suoi rapporti con la vegetazione e gli animali dentro e fuori dell’abitato, il suo clima e i suoi collegamenti (la ville); ma soprattutto le pratiche e la cultura condivise da una parte significativa dei suoi abitanti, la cité (Richard Sennet): due risvolti di una stessa realtà indissolubilmente intrecciati e reciprocamente condizionati. Nel processo di transizione questa cultura non può avere una configurazione rigida e identitaria; deve essere aperta e flessibile: un cammino in fieri che coinvolge tutti coloro che vedono nella ricostituzione di una o tante comunità, cioè di relazioni il più possibile dirette tra le persone e con il proprio ambiente, il passaggio obbligato per la conversione ecologica. Vista in questa luce, la città non è una realtà né statica né armonica, ma conflittuale: vedrà contrapposti, con alterne vicende, coloro che intendono partecipare alla transizione a coloro che ancora in qualche modo traggono vantaggi dalla situazione esistente; questi, forti delle risorse che controllano; i primi, sostenuti dalla forza delle loro coalizioni, ma anche dall’evidenza dell’aggravarsi della crisi climatica e delle sue conseguenze. Si tratterà di un processo, mai interamente definito e concluso, di progressiva riappropriazione di spazi, strutture, servizi, beni comuni, poteri decisionali: “Riprendiamoci la città”. Cinquant’anni fa, in un orizzonte ancora non dominato dall’imminenza di una catastrofe ecologica, questa parola d’ordine trasformata in programma era stata lanciata – in un’arena sociale, territoriale, generazionale e di genere differenziata, ma sotto la spinta di una classe operaia allora in lotta quasi permanente – come sbocco necessario di un conflitto che voleva superare l’impianto meramente operaista delle principali lotte in corso. Ma in quegli stessi anni, e del tutto indipendentemente, però in una prospettiva analoga, il sociologo francese Henri Lefebvre pubblicava un libro sul Diritto alla città, palesemente influenzato dalle teorizzazioni situazioniste sulla “deriva urbana” (la presa di coscienza dell’influenza che gli assetti urbani esercitano sulla psicologia e la cultura di una popolazione). Quei temi, poi ripresi nel 2006 dal geografo inglese David Harvey, sono oggi al centro di un ripensamento radicale del ruolo giocato nei processi trasformativi dal territorio, dall’iniziativa dal basso, dalla partecipazione al conflitto in forme non istituzionalizzate di democrazia di base. Una prospettiva che non rende la democrazia partecipativa incompatibile con quella rappresentativa, sempre più impotente; ma che destina la prima ad esautorare progressivamente le funzioni della seconda; in modo non dissimile da come i governi costituzionali sono stati a lungo, e ancor oggi, compatibili con la permanenza della nobiltà, dei suoi lussi e dei suoi sprechi, pur avendone da tempo espropriato sostanzialmente i poteri.
Questo articolo è stato pubblicato su Pressenza il 10 agosto 2023