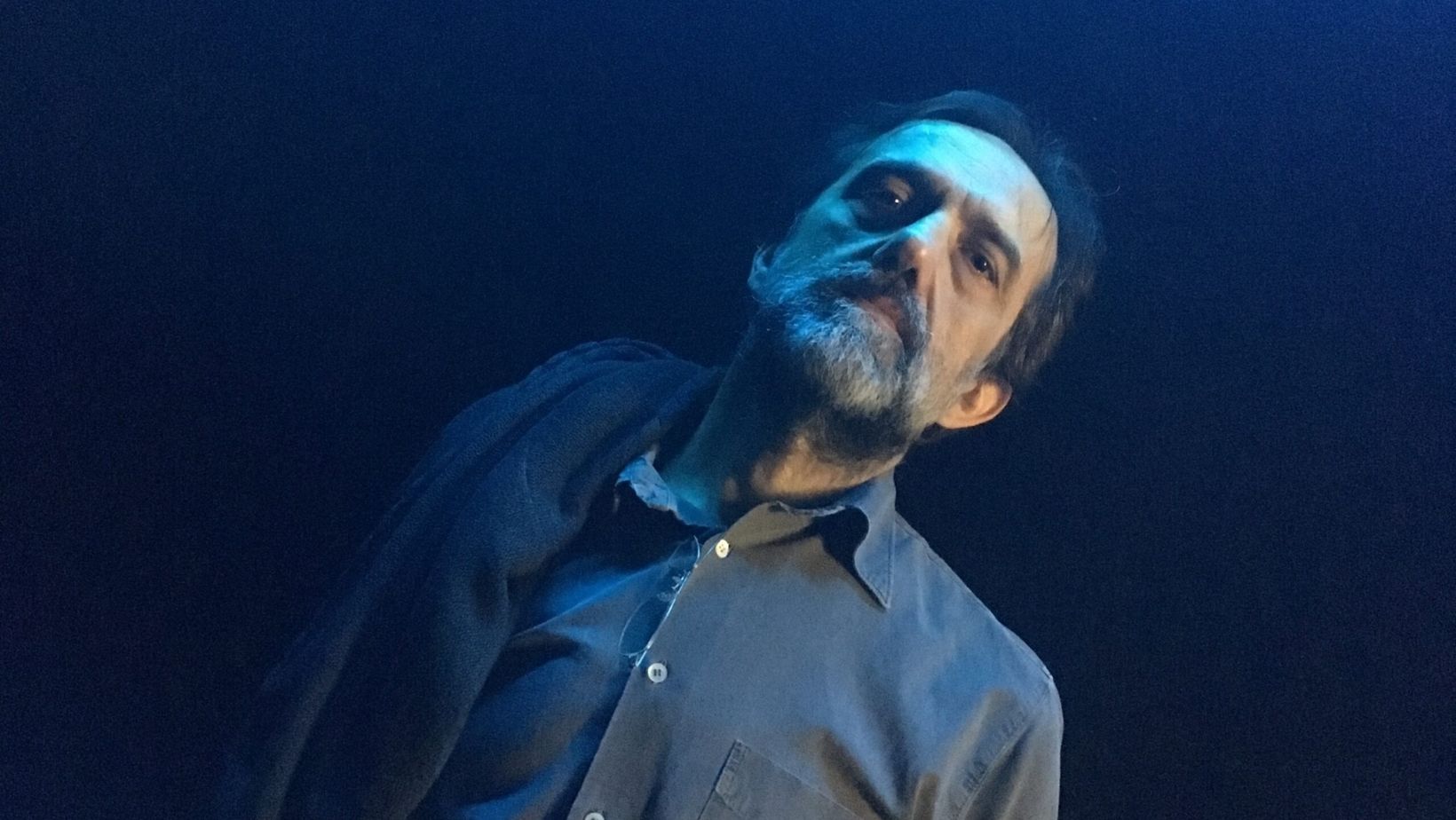La settimana culturale e teatrale è stata a dir poco movimentata, anche se suona quasi risibile questa attestazione in un momento cosi fosco nella Storia, possiamo dire, mondiale :credevamo di aver visto già di tutto con l’interminabile pandemia e il corollario di crisi energetiche, ambientali, climatiche, quasi in agguato a disfare la chimera di una plausibile ripresa, se non palingenesi. Ed invece, ecco inverarsi le più impensate fantasie distopiche di conflitto globalizzato con il corollario assai realistico di indicibile sofferenza che ciò sta comportando.
Una sfida politica, diplomatica, etica,, umanitaria che per ora sembra coglierci smarriti e impreparati e nei confronti della quale, forse come ci suggeriva lo stesso Celestini,uno che certo non le manda a dire, per ora è saggio astenersi dallo schierarsi,meglio forse, darsi il tempo di riflettere, documentarsi, studiare, perché il quadro è complesso e sicuramente una forma di fascismo strisciante è quella che impone semplificazioni, banalizzazioni e mantra comunicativi, se non apertamente fake news, al posto di elementi di informazione.
In questo senso, naturalmente, come si diceva, una settimana pasoliniana è comunque un buon viatico per una sorta di cura disintossicante dall’opinionismo mainstream dilagante, una settimana che peraltro si chiude densamente con varie iniziative e commemorazioni tra bilancio, rimpianto e riscatto dell’epopea settantasettina. Lo spettacolo di Societas, presentato in Arena del Sole, Bros, a sottolineare una fratellanza umana scellerata che si basa su una tradizione giudaico-cristiana patriarcale, colpevolizzante, maledicente come una coazione a ripetere di atti sadomasochistici e purificatori insieme, oltre a riaffermare le radici della poetica di Castellucci, con la sua programmatica cupezza rituale, accentua una percezione diffusa di resa dei conti di civiltà. Difficile dire, a fine serata, quando il pubblico specialmente più giovane, acclama con fervore il manipolo di uomini in divisa coreograficamente disposti sul palco, se questo stesso pubblico si sia semplicemente riconosciuto in un immaginario ormai sequestrato dalle paranoie coercitivo securitarie o ne abbia preso le distanze con fastidio e disagio.
È a questo punto che decido di concedermi una bella chiacchierata con Stefano Casi, direttore artistico di Teatri di Vita, un luogo ove forme teatrali anche sorprendentemente scandalose spesso hanno trovato casa. Non sono ancora riuscita a trattare dell’ultimo lavoro targato Adriatico, di cui ho accennato su queste colonne e mi riprometto di farlo più avanti alla ripresa, ma intanto, tra una conferenza filologico-celebrativa e la proposizione di spettacoli inediti per freschezza, come questo la Nebbiosa, tratto da una sceneggiatura cinematografica pasoliniana poi irrealizzata, che doveva trasferire un certo malessere delinquenziale e teppistico dalla Roma coatta che sappiamo, alla Milano del frettoloso boom industriale, sempre vigile è la lucidità intellettuale di Casi su quanto sta avvenendo nel mondo in generale e nel cortile teatrale italiano, in particolare.
So che sei infastidito da una certa voglia teatrale che assume ora forme interattivo-partecipative, ora forme intimistiche, di offrire sponde di riconoscimento, unificazione e infine quasi riconciliazione ammiccante al pubblico. In questo senso, nei tuoi molteplici ruoli di curatore, studioso, traduttore, sceneggiatore, direttore, ma anche giornalista, impegnato per esempio in battaglie informative sul medio Oriente, dove senti oggi posizionato il tuo attivismo, se cosi vogliamo definirlo?
Difficile rispondere con buon senso e onestà, se non riferendomi a numi tutelari, a figure intellettuali che ho molto frequentato e trattato. Credo che proporre una certa tipologia di spettacoli, che scuota le coscienze, in qualche modo incrini certezze e perturbi, sia una forma di militanza culturale. Il teatro non deve pacificare, deve essere anzi il luogo in cui si rappresenta il conflitto e mi chieda di leggere questo conflitto nella sua interezza e complessità. Non si tratta certo di sedersi a vedere una certa cosa che poi ci convinca a prender partito e arruolarci in questa o quella milizia, bensì di assorbire qualcosa che ci costringa ad una lenta elaborazione e assunzione di responsabilità. in questo senso, per esempio, penso che essendo tutte le tipologie di narrazione forme di acquisizione mediata e filtrata della realtà fattuale, non sia poi cosi tanto strano se difficilmente si rintraccino instant books o spettacoli sulla pandemia. Io credo che per ora in realtà affiori e si senta in certe atmosfere o approcci, ma non abbia trovato le parole per dirsi compiutamente. In fondo poi siamo ancora sospesi a vedere come va a finire che subito arriva una nuova emergenza.
Se ti vuoi riferire in qualche modo al nostro amato Pasolini, cosi militante nel suo celebrato polemismo, certo che noi che un po’ facciamo e ci occupiamo di teatro, possiamo dire di essere testimoni, più che attivisti, ma certo lui ha interpretato filologicamente il termine fino alle estreme conseguenze: la radice etimologica di testimone è infatti martire. Si sa che i testimoni molto scomodi sono fatti sparire o vengono altrimenti portati all’autodissoluzione.
Molto interessante, rispetto ai conflitti, anzi alle guerre in corso che ormai rischiano di diventare totali, la sua riflessione sulle periferie del Mondo. Perché è li che già si vedeva benissimo la dominanza di un unico pensiero di un unico sistema di sfruttamento, di un unico consumo, che noi oggi ora chiamiamo globalizzazione e che omologando però non unifica affatto. Poiché per appiattire, assimilare si procede per sistematiche distruzioni culturali e depauperamenti economici e morali. Distruzione chiama Distruzione, come ben possiamo vedere. Il veggente, come sempre, non predice il futuro, ha semplicemente il coraggio di vedere lucidamente il Presente e per questo risulta sgradevole ai suoi contemporanei.
Tu sai benissimo come noi, per rimanere in tema, con il fervore dettato da una insaziabile curiosità e da una oggi impensabile incoscienza, ci avventurammo già molti anni or sono nella sfida di proporre teatro dall’estero: e che estero! Da posti o avamposti veramente difficili da raggiungere in tutti i sensi, realmente inaccessibili per la comune conoscenza o per la fase storica drammatica o censoria che vivevano. Ora in un certo senso, anche se i conflitti casomai si sono moltiplicati, è molto più facile vedere un po’ ovunque e dunque anche a Bologna, spettacoli stranieri. Vi è tutto un circuito più ricettivo e occasioni festivaliere e la necessità per esempio di dare un senso ed un respiro al nostro essere europei e dunque anche a poter conoscere e riconoscere eccellenze altrui. Casomai la difficoltà può sempre essere economico-logistica, specie in tempi pandemici e come sai, anche noi abbiamo dovuto cancellare diversi spettacoli per questo.
Ma voglio sottolineare che noi siamo sempre stati lontani dall’effetto vetrina di proposte o pura documentazione. Come sai noi in genere ci siamo dedicati a full immersion perigliose in mondi anche molto lontani con varie iniziative a coté di film e spettacoli e abbiamo sempre usato lo strumento della lettera reciproca tra intellettuali ed esponenti politico amministrativi di qui con omologhi del paese di cui si trattava per dare un senso preciso di scambio.
E se mi chiedi qual è il senso preciso di questo modo di intendere la comunicazione teatrale è quello di ribadire, evidenziare, non tentare di omogeneizzare, o sterilizzare diversità e differenze, con l’intento però di istituire ponti, o quantomeno canali umanitari, i famosi corridoi, diremmo oggi. Che però vanno costruiti sempre, non solo all’ultimo momento in fase emergenziale. Io ricordo bene nel lontano 96, quando iniziammo la nostra lunga collana del Cuore di…, ospitammo un gruppo teatrale dall’ex Jugoslavia e ricordo benissimo le nostre conversazioni telefoniche con loro che ci parlavano sotto le bombe e ci dicevano che non potevano assicurarci di essere ancora al mondo per la data dello spettacolo. Ricordo anche di aver ospitato un gruppo ucraino proprio quando c’era la guerra del Dombass, che molti hanno scoperto essere accaduta e durata lunghissimi otto anni prima di approdare ai recenti esiti, soltanto oggi, in pratica.
Proprio per questo,credo, non si aiutino mai le popolazioni a vario titolo coinvolte in guerre di qualsiasi tipo, censurando le loro proposte culturali, o limitandone la diffusione. Oltre ad aiuti umanitari e asset diplomatici, credo che dovremmo invece offrire loro da ambo le parti, la possibilità di rappresentazione, diffusione, esportazione culturale.
In questo senso credo che un autore che sul post colonialismo e le differenze e divergenze etnico-culturali abbia molto da dire ancora adesso perché di grande statura lirico-poietica è senza dubbio Koltes, che noi abbiamo contribuito a tradurre, far conoscere, che abbiamo molto studiato e amato. Bisognerebbe essere in grado di rappresentare bene quelle posizioni differenti da cui si tenta di comunicare, spesso parlandosi addosso, come solo lui sapeva fare. Se vuoi una notizia in anteprima, posso dirti che a breve uscirà, un volume di lettere inedite di Koltes e che io ho avuto il piacere e l’onore di tradurre.
Purtroppo anche Koltes ha testimoniato per noi per un tempo troppo breve e in questo ultimo periodo abbiamo perso moltissimi maestri e punti di riferimento.
Per tornare anche ad una riflessione storica nell’ambito della pratica teatrale, ti voglio invitare alla lettura di questa riedizione del mio testo: 600mila azioni per Giuliano Scabia,figura cosi legata anche alle memorie settantasettine di questa città e certo anche ad una epopea da cui ha preso vita tutta la ancora vitale e fruttifera stagione della rete dei teatri sociali e della Salute. Io in questo volume, sono andato a recuperare tutta la fase più combattiva e disturbante del lavoro di Scabia, quando in quattro periferie industriali torinesi si mette in mente fare teatro partecipato con gli operai o di far scrivere agli operai genovesi il libretto d’opera per Luigi Nono. Siamo nel pieno di un decentramento culturale avvenuto tra il 69 e il 70, che non aveva precedenti e in realtà non ha poi avuto seguito, almeno in quelle modalità di lotta e sovvertimento gerarchico.
Adesso il fatto teatrale, anche se è normale rappresentare un po’ ovunque, forse è tornato ad avere una sua centralità statutaria anche quando coinvolge soggetti altri e magari è una evoluzione naturale. Per quello che ho potuto constatare io con tutta la fatica che ho fatto per costruire il libro, devo dire che quelle esperienze non furono, all’uso dei tempi, molto documentate e, probabilmente furono più importanti nella vita ed esperienza degli artisti che le intrapresero piuttosto che delle altre soggettività che pure ne furono parte fondante e integrante. Spesso, visto che molte esperienze rimasero estemporanee, i partecipanti di allora hanno molte difficoltà a ricordare, contestualizzare e incorniciare ciò che avvenne. Appunto perché spesso non vi era nulla di sistematico. La storia tuttavia ha una sua importanza anche nel costruire fatti teatrali compiuti e convincenti. Come sai è il caso in particolare di questa ultima edizione di Premio Scenario.
Tra tanti lavori pure interessantissimi, finalmente un po’ usciti dalla logica intimista della cameretta, ma pur sempre marcati da un certo pessimismo esistenziale, i vincitori poi principali sono risultati due spettacoli, o meglio, lavori, perché ricordiamoci che le commissioni hanno poi visionato ipotesi di spettacolo della durata di 20 minuti, che solo ora, in seguito al finanziamento e alla residenza che sono la sostanza del premio, sono diventati allestimenti, quelli che facevano i conti con una dimensione civile e storica.
Si tratta infatti di Topi, spettacolo vincitore della sezione Periferie, dedicato alle vicende del G8 genovese, svolte in modo originalissimo come grande rimosso storico di coscienza collettiva e attraversate da molteplici tecniche narrative, che utilizzano anche l’audiovisivo documentario e di Le Etiopiche, un altro ibrido sorprendente, sospeso tra teatro di danza e performance sostenuto da una parte video scenografica, che tramite una sapiente commistione idiomatico-filosofica, impone allo spettatore una vertigine spaziotemporale in corsa tra secoli e chilometri di confini. La figura per noi un po’ libresca di Alessandro Magno qui diviene un medium potentissimo che ci racconta le nostre origini meticce e l’ineluttabilità storica del fenomeno migratorio. Possiamo dire dunque due lavori di visione e sarà interessante capire quanto quello che nel frattempo accade intorno a noi avrà anche indirettamente influenzato lo sviluppo dei due spettacoli: già è interessante notare che il gruppo di performer di Etiopiche si è mosso in un contesto altro come quello di Lubiana, dove abitualmente opera, anche per realizzare la residenza e certamente anche questo può spiegare uno spiccato interesse al tema dei borders.
Congedandomi da Stefano Casi, non mi resta che ricordarvi di appuntarvi questi due titoli e tenervi liberi per l’ultimo fine settimana del mese a Teatri di Vita che vi consentirà di poter visionare in sequenza queste due assolute primizie teatrali e il cielo sa di quanta bellezza necessitiamo tutti in questi giorni amari!