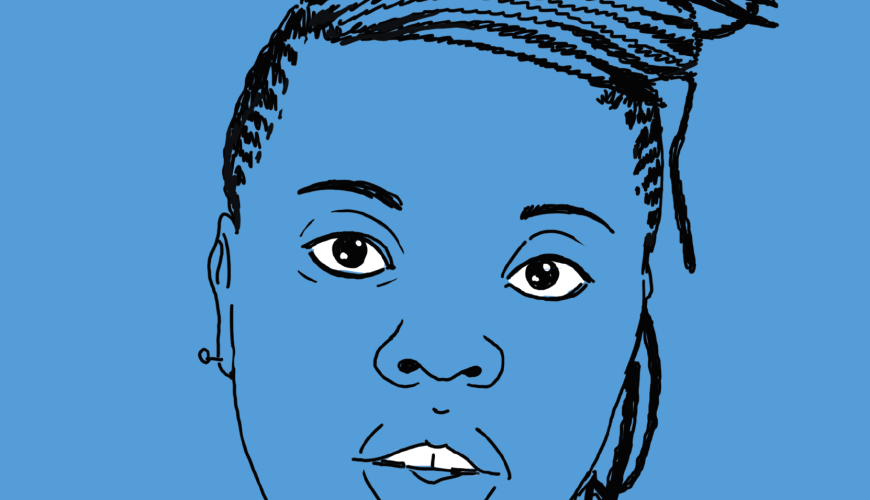Dietro l’allarme per la cosiddetta cancel culture e le critiche alle identity politics si intravede il vuoto intellettuale di chi non conosce la solidarietà e si sente minacciato dalla lotta alle ingiustizie
Il dibattito sulle identity politics da un lato e la cancel culture dal lato opposto sembra non avere fine, con la ripetizione di schemi sempre uguali, in base ai quali si creano discussioni infinite nei luoghi della rete dove si riunisce il ceto medio riflessivo (e anche meno riflessivo) del paese.
In un articolo apparso il 31 ottobre 2021 su la Repubblica sul politicamente corretto, Luca Ricolfi elenca cinque questioni riguardanti il linguaggio inclusivo che secondo lui si sono trasformate in un attacco alla convivenza democratica. Ricolfi esordisce con l’assunto che riformare il linguaggio, cioè lo specifico del politicamente corretto delle origini, è una «posizione, profondamente idealistica e anti-marxista, in quanto ha condotto, nel giro di un decennio, a […] creare un fossato fra la sensibilità dei ceti istruiti, urbanizzati, e tendenzialmente benestanti, e la massa dei comuni cittadini, impegnati con problemi più terra terra, tipo trovare un lavoro e sbarcare il lunario». La preoccupazione per il linguaggio, secondo Ricolfi, fin dalle origini di questo processo interessa solo la media borghesia, mentre le classi inferiori si preoccuperebbero da sempre solo di mettere assieme pranzo e cena.
Si tratta di una visione che definire semplicistica è fin troppo generoso, a partire dall’accusa di anti-marxismo insita nei problemi del linguaggio, che denota la volontà di mantenere separata la lotta per i diritti sociali da quella per i diritti civili, percepiti come necessità unica dei ceti privilegiati. Citando Natalia Ginzburg, Ricolfi ci ricorda che la «svolta linguistica, […] non solo preferiva cambiare il linguaggio piuttosto che la realtà, ma creava una frattura fra linguaggio pubblico e linguaggio privato, fra l’élite dei virtuosi utenti della neo-lingua e i barbari che continuavano a chiamare le cose come si era fatto per secoli e secoli senza che nessuno si offendesse».
Il problema di questa visione per quanto riguarda la contemporaneità è che la modalità espressiva delle classi subalterne si è radicalmente modificata attraverso una graduale quanto pervasiva presa di coscienza del proprio ruolo nei processi produttivi. Per questa acquisizione di consapevolezza hanno fatto molto di più i social media negli ultimi dieci anni di quanto abbia mai fatto la sociologia di scuola marxista. Citare una posizione esternata da Ginzburg in un’epoca radicalmente diversa dalla nostra è operazione di captatio benevolentiae che va decodificata. La frattura fra il linguaggio pubblico e quello privato, innanzitutto, è sempre esistita. Lo sanno gli studiosi di una famiglia, i Manzoni, che proprio alla Ginzburg stava tanto a cuore da scriverci un libro. Lo sanno gli studiosi della stessa Ginzburg, che sulla frattura fra pubblico e privato ha costruito un’intera poetica. Questa abitudine a decontestualizzare e risemantizzare questioni che viste al microscopio risultano molto più sfaccettate non è ingenua: ha lo scopo di divulgare attraverso la semplificazione argomenti su cui appoggiare una difesa della classe dirigente. E guarda caso la presa d’assalto di un quotidiano in origine di sinistra trasformandolo in cassa di risonanza dei discorsi auto-affermativi delle oligarchie industriali avviene proprio in contemporanea a grandi trasformazioni sociali, le quali si presume suscitino una certa inquietudine vista una tale levata di scudi.
Naturalmente Ricolfi, nella sua convinzione di avere uno spaccato sufficientemente ampio delle dinamiche di rete, appoggia la sua argomentazione sul fatto che la rete si rivolta contro chi non usa un linguaggio inclusivo. Questa certezza è alla base di un libro piuttosto pubblicizzato, scritto da una nota anti-femminista che viene citata da Ricolfi come autorità, e si regge sull’assunto che di fatto in rete venga negata la libertà di esprimersi con un linguaggio nella sostanza anti-inclusivo, che insomma non si possa più dire nulla sennò la gente si arrabbia. La realtà è che la policy dei maggiori social media ammette largamente discorsi di matrice razzista, sessista e discriminatoria, a patto che non siano presenti turpiloquio e oscenità, in osservanza del principio primo della comunicazione anglo-americana, ovvero che si può dire tutto, l’importante è non offendere la morale comune. Il discorso di Ricolfi è quindi inficiato alla radice da una scarsa, scarsissima dimestichezza con i social media, di cui tuttavia parla diffusamente.
Procede poi a definire demenziali gli esperimenti di inclusività linguistica attualmente in atto anche in questo paese, esperimenti appunto, cioè tentativi di sorpassare il limite primo delle lingue romanze che è quello di possedere due generi ben definiti, essendo caduto in disuso il neutro nel processo di volgarizzamento della lingua posteriore al declino dell’impero. Che la presenza dei due generi nelle lingue neo-latine sia un limite all’inclusività in un momento in cui la metamorfosi della società contemporanea passa anche per una ridefinizione dell’identità di genere, sta diventando evidente anche ai linguisti più tradizionali. Da sempre il linguaggio è auto-rappresentazione, e lo è per i conservatori quanto per gli innovatori. La scelta di esprimersi attraverso un registro e uno stile è una scelta identitaria, e in quanto tale dovrebbe essere libera. Ricolfi procede a fornire una serie di esempi che suggeriscono la sua completa ignoranza di una caratteristica fondamentale della lingua, ovvero la sua connotazione come esito della maggiore diffusione di certi termini in determinati contesti. Ad esempio, se la parola supremacy ha iniziato a dare i brividi mentre la Casa Bianca era in mano ai suprematisti bianchi, è perché ha mostrato di essere fortemente connotata e sostituirla con altri termini meno connotati non fa che aiutare a ripristinare la pace sociale in un contesto di violento conflitto. Si tratta di prassi linguistiche che non minacciano nessuno e definirle «deliranti» o «demenziali» equivale ad aderire ideologicamente a una volontà di denigrare e svalutare la parte sociale che chiede riconoscimento.
Il discorso pubblico di questo decennio ruota largamente attorno all’intersezionalità delle lotte, anche grazie alla gigantesca operazione di auto-educazione delle masse a un linguaggio inclusivo. Questa trasformazione ancora in corso ha ripercussioni concrete sulla realtà: si vedano le scelte narrative dei colossi dell’intrattenimento, da Disney a Marvel e Netflix, che propongono questioni intersezionali nei loro prodotti culturali. Il rifiuto del subordine linguistico ha portato a esercitare diritti basilari come un’adeguata retribuzione o un maggiore riconoscimento del proprio ruolo sociale, proprio a partire da quelle che Ricolfi declassa come pratiche demenziali. Forse Ricolfi vorrà fornire una spiegazione di come la graduale acquisizione di consapevolezza della propria centralità nei processi di produzione da parte di categorie storicamente subalterne possa essere definito anti-marxista. A corollario di ciò, si può affermare che definire oggi cosa sia marxista o anti-marxista, alla luce di due secoli di interpretazione delle categorie marxiane, è per lo meno insufficiente dal punto di vista dell’analisi. Senza un’adeguata contestualizzazione resta una pura provocazione gettata da un quotidiano ormai di proprietà della destra industriale.
A questo punto della disamina della cosiddetta cancel culture ha perso di senso continuare a dibattere attorno a un tema ormai polarizzato. La dimostrazione di quanto la discussione si sia avvitata su sé stessa la fornisce un articolo di Guido Vitiello apparso su Il Foglio il 6 novembre 2021, in cui si definiscono derive terroristiche alcune caratteristiche del linguaggio inclusivo. Vitiello si appoggia all’ironia, figura che ha un corso lungo e nobile e la cui funzione in certi snodi della storia del pensiero è stata di disinnescare dinamiche discorsive obsolete. Diventa invece patetica quando è utilizzata per riaffermare una posizione già storicamente acquisita. Come sempre, chi non sa a cosa aggrapparsi se la prende col ‘68, e neppure Vitiello si esime da questa pratica ormai noiosissima, andando a ripescare una pubblicazione ultraspecialistica del 1985 (uscita in traduzione italiana nel 1987) per affermare una banalità plateale, ovvero che non è colpa di chi nasce dalla parte giusta della storia se esistono le ingiustizie.
Non occorreva scomodare gli umanisti secolari francesi (cioè gli illuministi del ventesimo secolo) per sostenere che le diseguaglianze non sono da attribuire a tutti gli uomini bianchi etero, atteggiamento che prendendo in prestito le parole di due filosofi francesi, definisce ricattatorio e disumanizzante. Disumanizzazione è il termine utilizzato da Primo Levi per definire il trattamento inflitto nei campi di concentramento nazista, se ne potrebbe dedurre che Vitiello sta dando delle nazifemministe alle femministe intersezionali con un’abile perifrasi che solo chi ha una solida cultura di base può decodificare. L’uso del registro e delle retoriche dell’élite intellettuale per sembrare intelligenti sortisce esattamente l’effetto ricercato, ovvero di sembrare intelligenti. Ma se si va a scavare sotto questa patina si trova un vuoto intellettuale spaventoso, quello di chi non conosce la solidarietà e non capisce che della lotta contro le diseguaglianze beneficia la società, e non solo l’individuo. Paradossale poi che si affidi alle parole di due critici dell’individualismo sessantottino un pensiero che di per sé è l’epitome dell’individualismo medio-borghese bianco.
Perché l’ironia funzioni da grimaldello chi la usa deve trovarsi in posizione subalterna all’interno di una gerarchia. Al contrario, ciò che si ottiene è una grottesca manipolazione del punto di vista, in cui emerge il capetto che bullizza i più deboli.
Perché negare che un soggetto maschio bianco appartenente a quella media borghesia istruita destinata a diventare ceto intellettuale detenga un potere che gli è dato dall’essere banalmente nato sotto una buona stella, significa sostanzialmente negare svariati secoli di storia sociale europea. Si può fare? Certo che si può, d’altronde sembra che nessuno glielo impedisca, anzi a questo negazionista viene dato un megafono di tutto rispetto. È opportuno farlo? Forse su questa inveterata abitudine una riflessione si può fare.
A chi giova l’uso del registro ironico nei confronti delle lotte intersezionali? Può darsi che aiutare un quotidiano di destra a mantenere discorsivamente terreno in un momento in cui in tutto il mondo si frantumano stereotipi di genere, disabilità, etnicità sia persino positivo, quanto può esserlo mantenere al suo posto una statua per ricordarci che siamo stati così, abbiamo celebrato schiavisti e colonizzatori. Può darsi anche, tuttavia, che liberarsi dei simboli di oppressione sia di giovamento persino per chi ha avuto la ventura di nascere nel seno della cultura degli oppressori. Che rappresenti un’emancipazione per tutti sul piano intellettuale vedere riconosciuta l’autorevolezza del proprio discorso indipendentemente dalla propria appartenenza di gruppo sociale, e non in virtù di essa. Ma è da qualche secolo che proprio in questo paese le corti permettono ai cortigiani di mangiare. Che nessuno abbia alcun interesse a smantellare un settore tanto improduttivo quanto parassitario come quello del giornalismo rappresentativo della classe medio-borghese è abbastanza normale e in fondo anche comprensibile: c’è da chiedersi quanti sagaci autori di questo ceto sociale metterebbero insieme il pranzo e la cena senza una corte.
La lotta femminista intersezionale non leva un grammo di privilegio a nessun maschio bianco, ciò a cui punta invece è l’estensione dei diritti civili, diritti basilari come il riconoscimento di una diseguaglianza di partenza, e della necessità di una compensazione per permettere a chiunque, indipendentemente dalle condizioni di nascita, di realizzare le proprie aspirazioni e di coltivare i propri talenti. La retorica del merito ha affogato per anni nella melma darwinista la realtà che esistono concretamente, storicamente, diseguaglianze di base che impediscono a un numero spropositato di persone di emergere grazie alle proprie abilità e competenze. La scuola delle competenze è la massima realizzazione di quel bluff per cui i famigerati skill si acquisiscono a scuola. È sufficiente osservare le dinamiche all’interno di una classe scolastica italiana per comprendere in meno di mezz’ora chi sono i soggetti privilegiati, cioè quegli individui in età evolutiva che avendo ricevuto fin dalla prima infanzia stimoli di grado culturale elevato hanno sviluppato le competenze adeguate per emergere socialmente. Benessere socio-economico, offerta culturale varia, intelligenza normodotata, appartenenza al gruppo etnico dominante, assenza di bagaglio emotivo sono alcune delle condizioni di partenza che preludono al successo scolastico e quindi professionale. Questo lo sa chiunque insegni, ma non lo sanno i giornalisti di destra che mandano i figli alle scuole private, o evitano accuratamente di occuparsene i difensori della scuola della fatica, come Ricolfi e la sua sodale Paola Mastrocola.
Fra qualche anno saremo in fila per l’acqua potabile, ma ancora oggi in questo paese c’è chi trova opportuno mantenere intatte differenze di censo, di genere, di etnia, cosicché in quella fila c’è chi avrà la precedenza e chi resterà ultimo. La differenza è che nel frattempo c’è chi ha costruito comunità, chi ha saputo guardare agli slittamenti essenziali di quest’epoca, che sono semantici quanto economici, e su questi ha voluto edificare un orizzonte di lotta, mentre altri difendevano il fortino. Ma arriva un momento in cui i fortini diventano un peso per tutti.
Questo articolo è stato pubblicato su jacobin il 9 novembre 2021