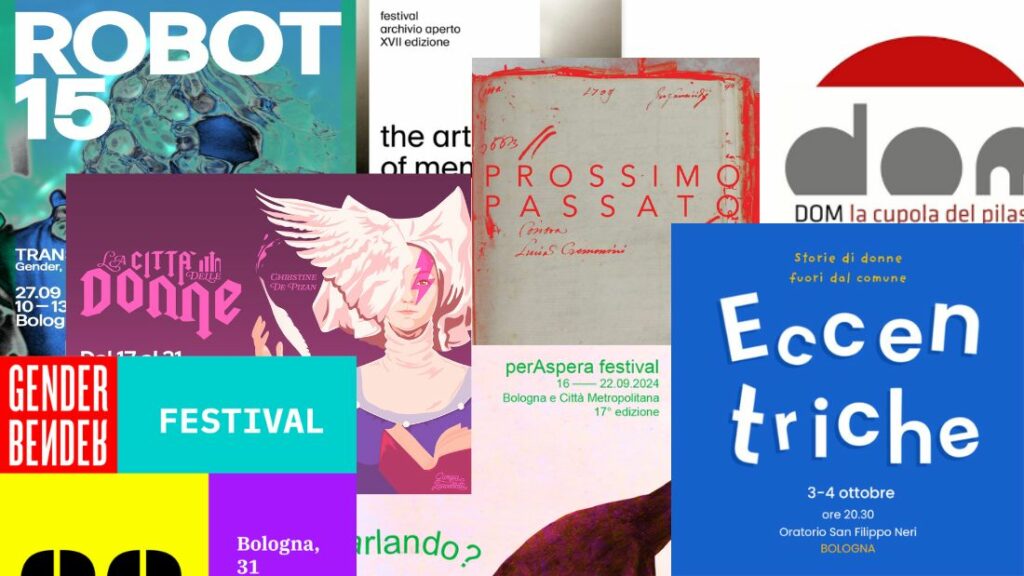Si respira sempre un’aria bella anche nell’afa più pressante, anche quando si capita in una giornata topica per la rappresentazione collettiva nazionale quale è sempre la finale di un qualche torneo calcistico di livello, arrivando dalle parti di una delle patrie romagnole di Tonino Guerra: sarà che Santarcangelo vuol dire un po’ sempre giovinezza, anche se le primavere sono molte di più. Il festival stesso, del resto, è sospeso nel limbo pandemico di questo lungo dilatato cinquantenario, gestito con l’ottimismo dei visionari che si fanno attraversare, piuttosto che, da discorsi di epokè, catastrofe, globalità quali sono i componenti del dream team chiamato Motus.
Sarà che questo festival è partecipato sul serio da quelli che lo fanno, lo vivono, lo organizzano, lo promuovono, lo recensiscono e documentano in primis e poi da sempre, da tanti altri globe trotters della curiosità culturale che si lasciano incantare dalle trovate e locations e forme di socialità di un festival mutageno e proteiforme per natura, in grado di stare con leggerezza e puntiglio anche dentro gli angusti recinti dei contenimenti anticovid. Forse viene scalfita dalle contingenze, una attitudine di fiesta mobile popolare, ma l’entusiasmo partecipativo non viene mai meno in un festival che è un fuoco di fila di proposte diversificate, molte delle quali laboratori ali e pensate per ogni segmento di età ed esigenza espressiva, insieme ai talks, necessari per fare il punto, alle performance musicali rigorosamente free, alle rassegne filmiche itineranti.
Un festival dunque radical e pop, nel senso migliore, in grado ogni volta di shakerare sapientemente generazioni diverse, rivelazioni internazionali come Amanda Pina e Betty Apple per citarne due di cui si sentirà molto parlare, con astri già confermati e discussi: sto pensando a Milo Rau, insieme a consolidati nomi della scena locale che sono da un pezzo stars intercontinentali a loro volta. L’organizzazione, nonostante i trasferimenti, le zanzare, il caldo, il clima informale, c’è e funziona e “tutti”, come dicevo vedono tutto o quantomeno ci provano. In questa situazione di appassionata dedizione, ho potuto vedere in sequenza due lavori nostrani, per così dire, non certo a firma di novellini e sicuramente molto diversi tra loro accomunati dall’urgenza di fare i conti con il Tempo e i Tempi, esorcizzati in entrambi i casi da suggestive parrucche volutamente autoironiche e memento dello stare sempre e comunque dentro il gioco della rappresentazione. Mi sto riferendo a due convintamente applauditissimi spettacoli, quali Sovrimpressioni, titolo ispirato alla poesia di Zanzotto,della premiata ditta Deflorian – Tagliarini, coprodotto, tra gli altri, dal Comune di Rimini in omaggio alle celebrazioni felliniane e la Madre delle Albe ravennati. Di nuovo, qualcosa bisogna dire sulle locations, naturalmente, che la fanno da padrone in un festival sempre stato site specific ben prima che il termine divenisse di largo uso. La sala Pamphili del teatro degli Atti di Rimini, dispone nel primo caso, in tutta la sua monacale suggestione due file dirimpettaie di pubblico in tutta lunghezza, creando una piazza corridoio, dove i due protagonisti accennano falsi movimenti, dispiegano volteggi, elucubrano perpatetici e nevrotici soliloqui in stile Moretti e stanno seduti come in graticola, alla prova trucco e parrucco, servita in scena da ancelle competenti, sorta di coro muto di una azione sempre rimandata, desiderata e temuta, ma anche no, come si usa dire nel gergo comune, ma che sempre è tutto fuorché un atto di spontaneità, o di adesione convinta, piuttosto pare lo scaramantico riscaldamento o rituale propiziatorio di chi si tuffi, nel vuoto o nell’acqua. Che nel primo caso si chiama futuro, nel secondo memoria.
Tutto è residuale nelle ultime performances di questa anomala coppia non coppia, che tuttavia non scoppia affatto, ma anzi si riconferma, rinnova un patto fiduciario, anzitutto al suo interno e poi rivolto al pubblico, sulla base di un passato che non è certo terra straniera o bruciata, ma che comunque non cessa di porre interrogazioni, quasi enigmi, vaticini rovesciati, a colorare il quotidiano presente di paradossi.
Paradossi ai quali il personaggio Daria o Amalia-Masina da Ginger e Fred di felliniana ascendenza o addirittura Greta Garbo, nella quiescenza del suo stesso mito, reagisce con sgomento piccato, con gran dispitto di questo tribolare inevitabile che è il nostro inevitabile declino, mentre il personaggio Antonio-Mastroianni Pippo, poi anche sorta di Birdy della danza, tanto per stare su reminiscenze filmiche, affronta con lucida introspezione e melanconia.
Il gioco di specchi metaforico ed agito tra i due, che si presentano in imbarazzate vestaglie cappotti, concentrazionari nel non colore e che giocano di calzature a sugellare una lunga storia performativa novecentesca d’avanguardia che ci corre innanzi agli occhi, ma che qui non rivela identità, bensì le camuffa alla meno peggio, si sostanzia nella polarità introversione-estroversione.
Del resto, qualcosa della beckettiana logorroica Winnie, Deflorian ci riverbera, ma, come accade in tanta produzione artistica e culturale in senso lato di questi nostri giorni, l’autofiction o costruzione del sè biografico, non avviene più tramite i cosiddetti reperti personali, come il rossetto o il pettine o lo specchietto, perché sarebbero frammenti da un disastro aereo o da un lager, bensì attraverso la lettura filtro di un vasto immaginario antropop cui attingere, o attraverso, appunto, l’immagine che gli altri ci rimandano. Ognuno ha le madeleines che merita o si sceglie e Deflorian ha l’appiccicarsi del riso integrale alla pentola e nessuna certezza che quella boheme scelta pure con determinazione e così impreziosita dal rapporto con l’altro, il compagno di un percorso, la spalla imprescindibile, siano stati in assoluto giorni felici, più felici di questi, che comunque sono un chiudersi, un imbozzolarsi. Naturalmente nessuno può credere che siano solo l’imborghesimento o l’invecchiare la cifra di questa sorta di entropia e anche qui, avvertiamo leggera l’eco di questi nostri giorni complicati di isolamento, di mancanza di scambio.
E allora nel trovarobato esistenziale di questo peculiare duo, ci si confronta con candore su numeri, forme, caratteristiche, del sistema produttivo-spettacolo di un tempo e del suo star system, così lontano da noi e da loro, tanto da accennare una specie di retroattivo me too all’amatriciana sulla comparsa esposta sul set del film feticcio dello spettacolo, da Fellini in persona, come miglior culo, nonostante la presenza di una moglie protagonista che prima si incrina una costola, poi pretende un velatino perché non si notino troppo le rughe… Deflorian-Tagliarini vivono dentro le slabbrature del mito cosi consolatorie nel rituale del make up, make up in favore di un pubblico che con il suo sguardo epifanico li rende attori e contribuisce all’identità dello spettacolo. Se Sartre diceva che l’inferno sono gli altri, la coppia in questione invece sa bene quanto ognuno abbia almeno un piccolo purgatorio personale, fatto di insicurezze e ironiche competizioni, vedasi l’accenno all’inossidabile carisma del collega Castellucci.
Di nuovo, un pretesto filmico accende divagazioni, funge da escamotage narrativo come accadeva con Deserto rosso, con la grossa differenza a mio avviso che l’adesione emotiva, identitario-narcisistica, a quella storia, a quella protagonista, a quell’immaginario, erano viscerali e la sottotraccia del lavoro erano il tema della cesura, di una fine, forse la solitudine che si prova nel transitare ad una compiutezza di maturità. L’amaro prezzo della consapevolezza, insomma.
Qui invece, il tema sembra essere la scoperta di un presente sempre più uguale a se stesso, o, per dirla meglio, di un futuro che minaccia di essere una pagina bianca scritta via via dal farsi di questo presente tanto inafferrabile quanto apparentemente vuoto, forse perché percepito come denso di minacce inconfessabili. In questo senso, il futuro praticabile è un ritorno, che sceglie la compostezza di uno stile definito che rifiuta lustrini e piume, per una misura di classicità: camicetta bianca e gonna al ginocchio per lei, una Masina rivisitata dall’algida Garbo, smoking per lui che preferisce concepire la danza come un rifugio, amico immaginato tra le piante e pertanto rinuncia ai volteggi con la sua Ginger, per prenderla a braccetto, come fanno i vecchietti. Lo spettacolo infine si prende uno scroscio commosso di applausi, perché, senza parere, dopo un avvio volutamente estenuato, forse un filo troppo preso dal meccanismo in sequenza collaudata, è costruito in levare dal punto di vista emotivo e sa offrire molti nervi scoperti comuni anche al pubblico Uscire di scena forse è tollerabile salvando il senso di una umanità profonda e condivisa: per una volta i fantasmi degli attori tromboni del Burg Teather, cari alla ferocia di un Bernhard, sono stati neutralizzati.
Si esce dal caldo abbraccio claustrale, per venire graziosamente traslati dall’organizzazione presso un luogo d’incanto nel crepuscolo fucsia, quale il freschissimo ex Imbosco, punteggiato da sdraio relax nell’attesa dello spettacolo di un’altra pluripremiata ditta, quale quella costituita dal regista drammaturgo poeta Marco Martinelli e dalla sua sposa-musa Ermanna Montanari, una delle straordinarie voci femminili di Romagna. Parterre du roi, per questo lavoro di recentissimo debutto e davvero varrebbe la pena scrivere un saggio sulle numerose e talentuosissime coppie costituenti del teatro di ricerca.
In questo specifico caso, il lavoro è costruito anche a partire dalle peculiarità dei contributi di due sensibilissimi artisti quali Stefano Ricci, pittore illustratore affabulatore di livello internazionale, ma con saldi legami biografici romagnoli e Daniele Roccato, compositore contrabassista di rara versatilità entrambi in scena con la mattatrice più proteiforme che c’è.
Dopo la pace rosata del tramonto, siamo quasi divorati dal buio opprimente che emana dal palco, che inizia a palpitare, quasi sussultare di gorgogli, borbottii, luci fioche. Siamo in una campagna da fuochi fatui, dove ci si riferisce ai figli cresciuti, quasi mitologicamente come giganti.
Ermanna appena intuibile in scena è più che mai incattivita nel gioco di tutte le parti in commedia, che su poemetto-dittico scritto da Martinelli con particolare accuratezza linguistica, sono un figlio neghittoso, irresoluto, spietato come lo sono i vigliacchi conniventi ed una madre – vittima delle circostanze in apparenza, in realtà indistruttibile perché al centro della conoscenza e capace di fusioni, mutamenti, adattamenti con gli elementi e le forme di vita altre, del tutto incomprensibili al suo rampollo.
Intanto che Ricci, non nuovo a imprese di questo tenore, disegna con la perizia visionaria che gli conosciamo dal nero, sul nero, nel nero, un suo personalissimo manuale naturalistico da fiaba oscura e sempre più Roccato da una punteggiatura in funzione narrativa, passa a tessere partiture di respiro classico che si fanno personaggio –coro, si delinea una dialettica precisa tra il figlio-pensiero, volto a prendersela con la sbadata noncuranza materna, femminea, attirata in tutta evidenza dall’elemento acqua, fino a cadere nel pozzo e il pensiero di lei, che più che tale è una reminiscenza sul passato, una invettiva sul presente, che si trasforma in presagio sul futuro.
A questo punto, ci rendiamo conto che mito e attualità, in questa parabola dark, in cui in qualche modo Cappuccetto è nonna, lupo, cacciatore tutto insieme e il personaggio figlio ha il piglio di un Fagiolino futuro Balanzone azzeccagarbugli, vanno a braccetto per raccontare una storia ulteriore, quella della visione che è soprattutto un forgiare il qui ed ora grazie ad un sapere pratico e sciamanico, quello che abbiamo riconosciuto al griot e al Teatro in tutti questi anni non trascorsi invano, quello della pitonessa, creatura sirena del profondo con i capelli impigliati nell’umido del pozzo. Un pozzo, va detto, personaggio creatura esso stesso, entità fattrice di bisce dagli occhi di smeraldo e collare di perle che s innestano nella madre trasferendole pieni poteri: poteri di lettura della realtà che possono prescindere dalle tecnologie così care ai comuni abitanti del sopra. Poteri in grado di svelare le mistificazioni e ideologie giustificatorie in cui ci acquattiamo per dire quietamente, fermamente con la vocina peraltro inquietante dell’inconscio, vocina da grillo parlante il romagnolo della madre di Pantani, oltre e dopo il folle autoritarismo della mere Ubu, per approdare infine all’autorevolezza di una madre superiore e collettiva, una madre che denuncia l’Uomo figlio, il gigante distratto, preso in mille pensieri e affari: ha magari spinto lui, senza volere, ma chissà, giù nel pozzo, lei. E, adesso, non ha tempo, né energie, né umiltà, per rimediare e chiamare a raccolta i suoi simili, se si chiamano polacchi o rumeni o altre etnie cui stoltamente rivolge sospetto, diffidenza, disprezzo. Come se non si fosse tutti dentro questo scenario di spoliazione che è diventato per noi, l’ambiente naturale.
Questa madre, a questo punto, che non può essere salvata con strumenti e modus operandi consolidati, se non attuando un processo di metanoia, o rovesciamento dei paradigmi, contro la ybris filiale, non è piu solo tramite sacerdotale, ma ci si rivela come Pangea essa stessa, la nostra madre Terra depredata e avvelenata, strattonata fino al precipizio.
Un apologo morale che ritocca lo spirito leopardiano per adeguarlo ai nostri bisogni: la Natura non è qui matrigna, ma piuttosto una madre di sospetto candore costretta a difendersi e recuperare ascolto come può rispetto ad un figlio degenere che non la contesta, ma la sfrutta, la disconosce, la calpesta.
Insomma, come rileggere un Edipo più sordo che cieco, alla luce di grandi archetipi di autodifesa naturale. Già dai tempi delle ispide memorie campianesi e “della vita agli arresti di Aung San Suu Kyi”, Montanari ingaggia una sua personalissima ricerca-sfida sulle radici della resilienza e del potere delle identità femminili non convenzionali, rintracciando sempre una matrice generatrice anche laddove il codice patriarcale mainstream vorrebbe vedere solo ribellione, caos, turbamento gerarchico. La terra di Romagna è ormai consacrata a diverse eccelse personalità attoriali e autoriali femminili di cui possiamo tranquillamente stilare un lungo elenco, ormai noto agli appassionati e non solo: quando dal cono d’ombra di questo sorprendente assolo collettivo emerge anche in questo caso una protagonista con parrucca, e che parrucca! Una chioma bianca ondeggiante lunga al sedere, abbiamo la certezza che esistono sirene, ageè o meno che siano, anche nel sottosuolo e che esistono divinità ctonie accessibili a noi stolti mortali. Grande festa l’abbraccio finale di un pubblico amico e solidale, mentre si levano anche cori da stadio in sottofondo, in lontananza, data la coincidenza di date con una attesa finale calcistica: meno male che Santarcangelo c’è sempre e che porta con nonchalance le sue 50 e passa primavere, in fondo, un campionato anche questo.