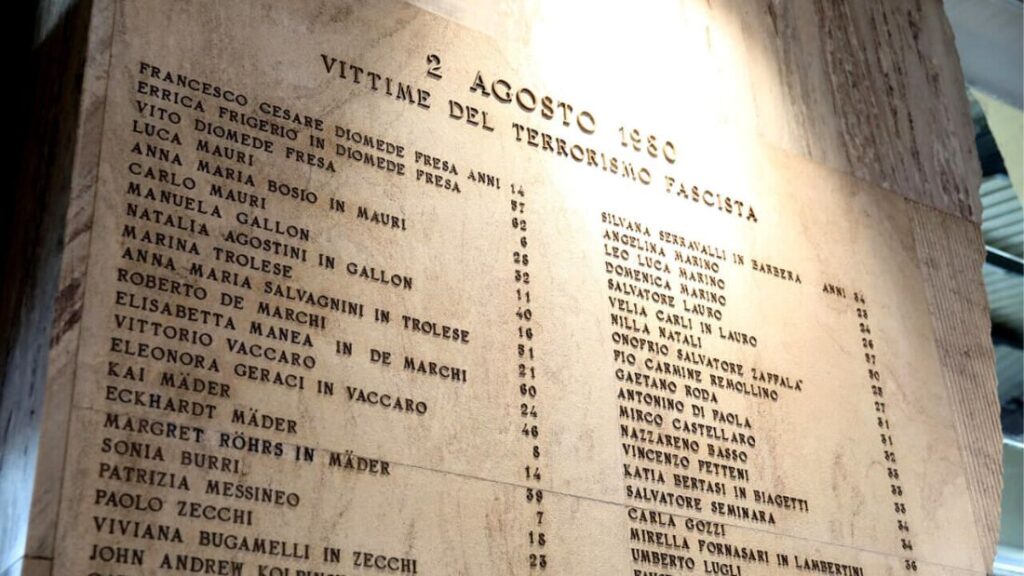Lungo un vago confine tra Iraq e Iran un uomo in barca caccia anatre di notte. Altrove un ragazzo s’apposta con il fucile pronto a sparare a creature in volo nel cielo grigio. Sulla strada di campagna uomini in cerca di prede guidano in un’alba di nebbie. Figure di cacciatori abitano le immagini di Gianfranco Rosi, da Notturno a Fuocoammare. Nel film ambientato a Lampedusa un uomo in tuta da sub s’immerge con un fucile a tracolla, marinai pescano seppie quando il mare è mosso e il giovane Samuele imita per gioco i gesti di caricare l’arma e fare fuoco. Samuele, ancora, è un abile tiratore di fionda, ma ha un occhio pigro: alla visita oculistica egli ammette di serrare la palpebra sinistra per mirare l’obiettivo. Questa connessione tra visione e caccia predatoria mi ha ricordato il saggio sulla fotografia di Susan Sontag: “La macchina fotografica – scrive Sontag – è l’arma ideale di una consapevolezza di tipo acquisitivo […], la macchina fotografica viene venduta come arma predatrice, automatizzata il più possibile e pronta a scattare”; e per questo “l’atto di fare una fotografia ha qualcosa di predatorio”, dove “invece di guardare in un mirino telescopico per puntare il fucile, [si guarda] in un mirino fotografico per inquadrare un’immagine”. Se estendo l’analogia alla macchina da presa, i cacciatori incontrati nei film sono proiezioni dell’attività del regista.
Il cacciatore d’anatre in terre paludose conosce la pazienza. S’acquatta mentre sullo sfondo bruciano le fiamme emesse da torri petrolifere e attende il momento giusto per colpire. Anche il regista pazienta in attesa e torna a casa con il paniere ricco d’immagini in movimento: corpi di migranti tremanti di convulsioni dopo un lungo viaggio (Fuocoammare); il balbettio di un bambino traumatizzato dalla visione di crimini di guerra (Notturno); un morto dissepolto durante lavori cimiteriali (Sacro GRA); i movimenti sgraziati di sofferenti psichici rinchiusi nel cupo corridoio d’un sanatorio (Notturno); i morti su un barcone alla deriva (Fuocoammare); un uomo appena ferito in un incidente sul raccordo anulare (Sacro GRA); detenuti in un carcere opprimente disposti in fila sotto gli occhi delle guardie (Notturno). Il cinismo venatorio di Rosi offre un cinema della crudeltà sotto i vasti cieli di una natura indifferente.
In Fuocoammare l’oculista spiega a Samuele la cura: «Allora, gioia, abbiamo un problema con quest’occhio, è un occhio pigro. Sai cos’è un occhio pigro? È un occhio che non lavora. Quindi il tuo cervello non recepisce le immagini dell’occhio sinistro. Allora noi dobbiamo costringerlo a usare l’occhio sinistro. Quindi per un breve periodo porteremo una benda sull’occhio buono, così costringiamo il tuo cervello a usare l’occhio pigro e a farlo lavorare. Piano piano lo dobbiamo abituare». Secondo l’oculista l’abitudine è allenamento alla visione corretta. Ancora Sontag: “Vale per il male la stessa legge che si applica alla pornografia. Il trauma delle atrocità fotografate svanisce vedendole ripetutamente, come la sorpresa e lo sconcerto che proviamo assistendo per la prima volta a un film pornografico si attenuano sino a sparire se se ne vanno a vedere altri. […] L’enorme catalogo fotografico della miseria e dell’ingiustizia nel mondo ha dato a tutti una certa consuetudine con l’atrocità, facendo apparire più normale l’orribile, rendendolo familiare […], inevitabile”. In un mondo carico d’orrore il cinema di Rosi aiuta ad abituare lo sguardo dinanzi all’osceno.
Che l’immagine sia pregna di un senso morale è forse un’illusione, questo penso quando vedo i film di Rosi. L’immagine, infatti, non suggerisce alcun senso, non ha profondità, non allude ad alcunché di celato: l’immagine non è altro che sé stessa e mostra solo sé stessa. Per questo non colgo alcuno stimolo di conoscenza, ma solo infecondo disorientamento: Sacro GRA non fornisce una mappa critica della terra desolata attorno alla tangenziale, Fuocoammare non aiuta a comprendere il meccanismo dell’accoglienza e del controllo lungo la frontiera marittima, Notturno è una generica commistione di visioni raccolte nelle terre a oriente del Mediterraneo.
“Contrariamente a quanto ci dicono le tesi umanistiche proposte per la fotografia – sostiene Sontag –, la capacità della macchina fotografica di trasformare la realtà in qualcosa di bello proviene dalla sua relativa debolezza come mezzo per trasmettere la verità”. Il pensiero critico è digiuno di conoscenza, ma può almeno definire il rapporto genetico tra l’immagine in movimento e il potere, ovvero la relazione tra le ombre sullo schermo e le forze che hanno acconsentito alla loro esistenza. Nei titoli di coda di Fuocoammare il regista ringrazia, tra gli altri, il Ministero dell’Interno, la prefettura di Agrigento, la Marina Militare, la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza, l’Arma dei Carabinieri. In Notturno i titoli conclusivi scorrono accompagnati dall’inno nazionale iracheno e menzionano il Ministero dell’Interno e quello della Cultura iracheni, la Direzione di informazioni militari irachena e quella libanese, le forze Zeravani, corpo militare peshmerga addestrato dall’esercito italiano.
Nel nostro tempo l’immagine è cinica e predatoria, effetto ed espressione di crudeltà; l’immagine è apparenza di superficie senza verità, un esercizio d’abitudine all’orrore; l’immagine è secrezione del potere e dei suoi rapporti di forza. Rosi potrebbe essere un autore della demistificazione, il maestro d’un cinema negativo che, spregiudicato, svela le astuzie d’una prevalente ipocrisia. Eppure questo non accade. Rosi si presenta – ed è presentato – come cantore d’un cinema umanitario.
Leggendo le recensioni a Fuocoammare e Notturno dei giornali più autorevoli, ho costruito un archivio di citazioni. Il cinema di Rosi “ha sempre evidente la volontà di ricercare l’umano” e compone “un organismo unico: quello dell’Umanità con la U maiuscola”. Infatti Fuocoammare evidenzia “l’emergenza profughi che l’Europa stenta ancora ad affrontare in modo veramente unitario e umanitario”. Questo cinema umanitario non è dunque crudele, ma delicato: opera di “esistenze illuminate con delicatezza”. Rosi non è cinico, ma empatico perché “sembra dire, infatti, che esistono le tragedie ma l’umanità, la pietà e la compassione continueranno a salvare il mondo”. E l’immagine non s’arresta alla superficie, anzi “Rosi ha saputo spingere sempre più a fondo la propria riflessione” ed è “problematico dietro un’evidenza che ne cela la complessità”. La sovraesposizione del dolore non allena all’abitudine, al contrario “il regista crea una magia spirituale di comunanza e affratellamento”. Notturno, ancora, è un film apportatore di conoscenza perché è ricco di “una sensibilità che cerca d’interpretare”. E lo stesso autore dichiara in una intervista che «a Berlino qualcuno mi ha detto: le parole chiave di questo film [Fuocoammare] sono tre: l’amore, la passione e la compassione. La compassione del medico, l’amore di Maria per il marito – quando fa il letto, prepara il pranzo – e la passione di Samuele».
Credo che le interpretazioni citate non siano abbagli. I critici, sebbene poco acuti, hanno ragione e lo stesso regista sostiene le loro tesi. Allora Rosi m’appare come un cacciatore di teste amato negli oratori, un predatore apprezzato dalle giurie dei festival del cinema. Ora vorrei comprendere come questo possa accadere. Forse la valenza etica dell’immagine è un’attribuzione del nostro sguardo? In Fuocoammare, per esempio, i pescatori catturano delle seppie, una donna le squarta e i personaggi, nella scena successiva, masticano e risucchiano i molluschi in un banchetto spietato. Poco dopo l’operatore cattura le immagini di migranti adagiati sul ponte della nave, tremanti creature indifese disposte a nutrire la compassione degli spettatori. Forse sono insensibile alla vista delle seppie e compatisco gli uomini a causa di codici culturali ben appresi: la coloritura etica di un’immagine afferrata sarebbe un’elaborazione del mio sguardo. Eppure questa è una spiegazione troppo semplice: la conversione umanitaria mi sembra interna alla forma del cinema di Rosi. La magia che trasforma e camuffa la crudeltà è un’affezione del meccanismo filmico.
In Fuocoammare il medico Bartolo siede di fronte a uno schermo dove appare la foto di un barcone. Egli commenta: «Ottocento quaranta erano in questa barca. C’erano quelli della prima classe, erano fuori e avevano pagato mille e cinquecento dollari. Poi c’erano quelli della seconda classe che erano qua in mezzo e avevano pagato mille. E poi, non sapevo, giù nella stiva ce n’erano tantissimi: avevano pagato ottocento dollari, la terza classe. Quando li ho fatti scendere praticamente non finivano mai, mai. Centinaia di donne e bambini che stavano male, soprattutto quelli nella stiva. […] Erano disidratati, erano affamati ed erano stanchi». Il medico spiega l’immagine, la inscrive in un contesto di relazioni: la sua voce – in posizione strategica, centrale – traduce tutte le immagini che precedono e seguono. Poi sullo schermo posto dinanzi a Bartolo compaiono un altro barcone e il corpo di un bambino migrante coperto di ustioni. Ora avverte il medico: «È dovere di ogni uomo che sia un uomo aiutare queste persone». Questa sequenza è l’incantesimo che trasfigura il freddo cinismo dell’operatore in sguardo commosso dello spettatore.
Il richiamo etico all’intervento del medico Bartolo – oggi parlamentare europeo – mi ricorda un altro passo di Sontag: “Fotografare è di fatto un atto di non intervento. L’orrore di certi ‘colpi’ memorabili del fotogiornalismo contemporaneo, come le immagini del bonzo vietnamita che tende la mano verso la lattina di benzina o del guerrigliero bengalese che sta baionettando un collaborazionista legato, deriva in parte dalla plausibilità che ha assunto, nelle situazioni in cui il fotografo può scegliere tra una fotografia e una vita, la scelta della fotografia. Chi interviene non può registrare, chi registra non può intervenire”. Imputare a Rosi di non essere intervenuto durante l’incidente di Sacro GRA o sulla nave dei sommersi e salvati in Fuocoammare, sarebbe un atto d’insopportabile moralismo. La questione è più sottile: l’autore nasconde il suo mancato intervento, non vuole che esso costituisca l’oggetto di una riflessione problematica. Questo è il paradigma primo del cinema di Rosi: la cancellazione della presenza dell’operatore implicato nella scena.
Nel cinema di Rosi non ci sono movimenti di macchina o, se ci sono, sono quasi impercettibili. Dominano le immagini fisse, quasi fossero fotografie increspate da movenze interne. Se l’inquadratura si sposta, se repentina segue un volto o un gesto, essa denuncia la presenza d’un soggetto sulla scena, ovvero d’un mobile osservatore coinvolto. Rosi, invece, manipola l’immagine in modo che scompaia l’uomo con la macchina da presa. Allora sembra che la registrazione sia operazione asettica, neutra, elaborata da occhi meccanici e senza vita, posizionati in un luogo prescelto da un’intelligenza dotata di notevole gusto pittorico (la scena finale di Sacro GRA, non a caso, è un mosaico di visioni del raccordo anulare emesse da telecamere a circuito chiuso). Se l’operatore cinico e predatore scompare dalla scena, restiamo noi scrutatori di immagini di sofferenza – siamo soli di fronte al dolore degli altri, e non possiamo che essere empatici, restare umani. Rosi nasconde la sua arma e mostra alla nostra intelligenza compassionevole la preda ansimante dagli occhi spalancati.
Vorrei leggere una storia del cinema dedicata ai movimenti della macchina da presa e del corpo che la regge, ma non so se esiste. Penso a Dziga Vertov e al suo cinematico occhio instabile; penso alle scene finali del Vangelo secondo Matteodi Pasolini dove la passione è osservata da occhi mobili di apostoli che scrutano tra le nuche di altri osservatori. Ora sono reduce dalla visione di Notturno etorno ancora al mondo martoriato che si trova a oriente rispetto a me. Più di un anno fa ho visto un film siriano così tremendo da lasciarmi quasi silente: Still recording di Saeed Al Batal e Ghiath Ayoub. Un gruppo di giovani operatori e cinefili di Damasco sono d’improvviso immersi nel conflitto e decidono di parteggiare per le fazioni ribelli che combattono contro Assad. Le loro armi sono le macchine da presa e così documentano i bombardamenti, la giocosa vita privata, le vittime, i gesti di amicizia, gli scontri a fuoco, le bombe assordanti che esplodono nel soggiorno. Ho visto l’orrore seduto al cinema, ma percepivo costante la presenza di un corpo che stringe una camera. Quel corpo è mediazione viva, storica, tra me e la cruda immagine. Alla fine un operatore è colpito da un cecchino e la macchina continua a riprendere: l’immagine che giunge a me non è la secrezione di un occhio automatico, ma l’estensione percettiva di un corpo caduto.
Questo articolo è stato pubblicato su Napoli Monitor il 29 settembre 2020