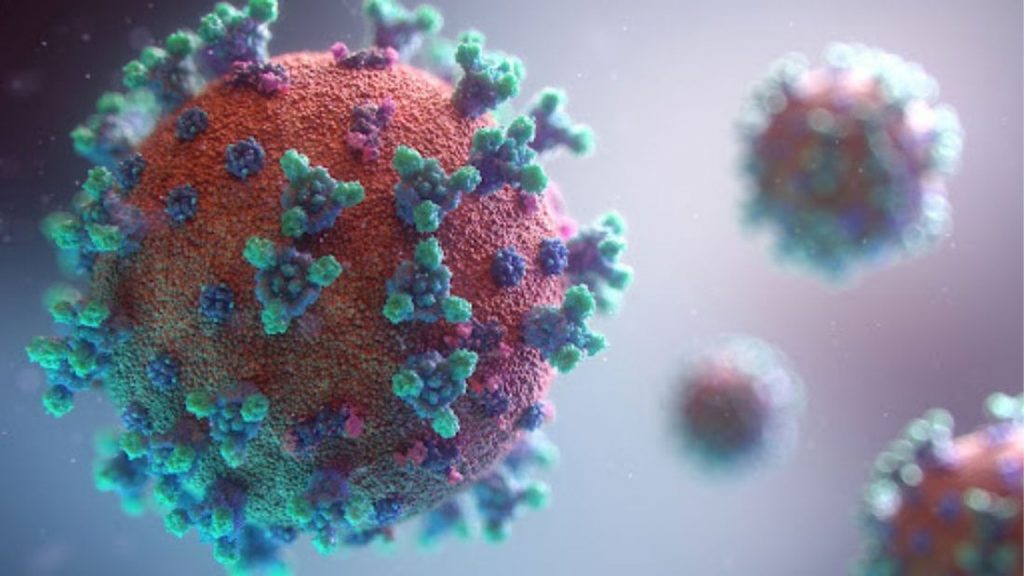1) Necessità e contenuti degli accordi di ripartenza
L’alluvionale decretazione di urgenza che ha accompagnato le diverse fasi della pandemia, ovvero la “chiusura” prima e la ripartenza, ora, delle attività produttive e commerciali, non deve far perdere di vista il provvedimento decisivo che ha costituito l’architrave della gestione politica della crisi: lo scambio, o, comunque, la stretta correlazione tra il divieto, per cinque mesi, di licenziamenti per ragioni produttive ed economiche, da un lato, e la concessione “universale”, per lo stesso periodo, di integrazioni salariali a tutti i lavoratori coinvolti dalla “chiusura”.
Si è trattato, indubbiamente, di un anestetico molto potente, che ha stornato il pericolo di esplosione di una crisi sociale gravissima, ma che deve far riflettere sulla drammaticità dell’“appuntamento” implicato dalla prevista cessazione nel mese di luglio-agosto di quelle misure tra loro compensanti. Perché delle due l’una: o in quel momento la crisi economico-produttiva risulterà superata da un (miracoloso) totale recupero dei livelli di domanda e di produzione “ante crisi”, tali da riassorbire tutto l’esubero di personale, o la prospettiva di licenziamenti di massa a la connessa crisi sociale diverrà drammaticamente attuale. La “riapertura” generalizzata delle attività manifatturiere del 4 maggio 2020, e di quelle commerciali del 18 maggio, non potevano – è ovvio – di per sé compiere il miracolo e la proroga del divieto di licenziamenti e dell’intervento delle integrazioni salariali per ulteriori due mesi e più, ne sono l’eloquente testimonianza, ma proprio nulla garantisce che il recupero si produrrà in questo lasso di tempo mancante alla scadenza.
Per altro verso, l’atteggiamento, anzitutto psicologico, delle parti sociali non è dei migliori, nel senso che evidenzia una pericolosa predisposizione al conflitto sotto le bandiere spiegate delle proprie ragioni, esibite in modo fondamentalista. I datori di lavoro, invero, in una sorta di rigurgito neo-liberista, invocano contributi a fondo perduto e la liberazione da “lacci e lacciuoli”, compresi, ovviamente, molti diritti e garanzie accampati dai lavoratori, ma questi ultimi ricambiano con angoscia e rabbia non minori per aver fatto sulla propria pelle, a causa, spesso, di ritardi nell’erogazione di aiuti pubblici, l’esperienza nuova e traumatizzante della caduta a precipizio nella miseria.
Lo slogan “nessuno deve restare indietro” ha acquisito così il significato di un autentico programma rivendicativo e politico, che comprende la continuità delle aziende e dei relativi livelli occupazionali, anche tramite una “irizzazione” seriale o, per così dire, “a pioggia”. Non si potrà, pertanto, scongiurare lo scontro sociale che si preannunzia alla scadenza del blocco dei licenziamenti, con semplici misure “risarcitorie” della perdita del posto di lavoro, quale un miglioramento, ad esempio, dell’ammontare o della durata della “NASPI”. L’unica via appare, pertanto, esser quella del dialogo, della messa a punto di programmi e strumenti condivisi, quali accordi “di ripartenza”, intervenienti tra le parti sociali (ma anche con il multiforme contributo dell’Autorità pubblica) e “multilivello”, di portata nazionale, territoriale ed aziendale. Il cuore di queste intese non può, per quanto si è detto, che essere, per quanto si è detto, la garanzia occupazionale, non , però, limitata all’immediato, bensì estesa al futuro e riguardante non solo i lavoratori occupati prima della pandemia, ma anche – da subito o in breve volger di tempo – i soggetti disoccupati o sottoccupati, ai quali va, adesso, procurata un’occupazione, proprio a partire dalla mobilitazione di energie economiche, politiche, intellettuali indotte dalla pandemia. In questo modo l’imperativo “nessuno deve restare indietro” sarà effettivamente realizzato. Lo scopo potrebbe essere senz’altro raggiunto da una manovra di riduzione degli orari di lavoro (incrociata con l’utilizzo di ammortizzatori sociali vecchi e nuovi) dapprima in funzione difensiva e poi espansiva dell’occupazione, come più ampiamente si dirà nel prossimo paragrafo.
Va, in ogni caso, subito aggiunto fin da ora che accanto a questo capitolo centrale dell’accordo che si auspica altri se ne collocano di strettamente connessi, come quelli riguardanti un nuovo assetto organizzativo aziendale, ma poi anche la ridefinizione di obiettivi produttivi e la correlativa riqualificazione delle risorse umane. In particolare, la tematica di un nuovo assetto aziendale “di ripartenza” abbraccia non soltanto l’argomento della corretta messa in esecuzione dei protocolli di sicurezza e del loro controllo e monitoraggio, ma anche quello, specificamente organizzativo, del migliore o diverso utilizzo delle risorse umane, con particolare riguardo all’istituzione o modifica di turni di lavoro e di utilizzo di specifiche tipologie di rapporto di lavoro. Si allude, ovviamente, allo “smart working”, che è stato il vero protagonista e “star” della fase più difficile della pandemia e relativa “chiusura”, ma, soprattutto, sperimentazione di massa della perfetta possibilità di lavoro “da remoto” mediante attrezzature e sistemi informatici, con conseguente possibilità o proposta di farne una modalità lavorativa permanente e generalizzata nelle mansioni impiegatizie.
A questo proposito, però, è subito insorta una vivace polemica sui “pro” e sui “contra” di una simile prospettiva, e conseguentemente sull’auspicabile caratteristica incentivante o disincentivante di una regolamentazione contrattual-collettiva della materia, non più affidata, stante il suo ormai accertato importante rilievo, alle sole pattuizioni individuali. La ricerca dovrà, allora, essere, come poi meglio vedremo, quella di una disciplina collettiva quanto mai delicata, ed anche bivalente, nella quale eventualmente contemplare per le parti anche uno ius poenitendi. Ed ancora ed infine, perché la “ripartenza” non costituisca solo il difficoltoso prosieguo di una vecchia “routine” bruscamente interrotta, ma l’occasione di un nuovo slancio, gli accordi dovranno contemplare anche i capitoli della riqualificazione professionale delle risorse umane, correlata, da un lato, con la riduzione dell’orario di lavoro, e dall’altro con la fissazione di nuovi traguardi produttivi convenientemente incentivati ed incentivanti per le risorse umane riqualificate.
2) Le garanzie occupazionali
Per definire con accettabile approssimazione il primo e più importante contenuto degli accordi “di ripartenza” si può cominciare con il ricordare che la prima “riapertura” (quella del 4 maggio 2020) ha riguardato circa 4,5 milioni di lavoratori addetti, sostanzialmente, ad attività manifatturiere, e la seconda (quella del 18 maggio) altri 1,5 milioni del settore commerciale e terziario. Come già notato, la circostanza che questi 6 milioni di lavoratori siano tornati ad essere utilizzabili con la riapertura delle imprese datrici di lavoro non significa, però, affatto che siano fattualmente davvero utilizzati e a tempo pieno, perché la caduta della domanda e degli ordinativi ha certo inciso sull’andamento delle imprese, con un calo produttivo valutabile, almeno, nel 20%. Non per nulla – si è notato – le “riaperture” sono state accompagnate dalla proroga del divieto di licenziamento, da un lato, e, in parallelo, dalla proroga delle integrazioni salariali dall’altro fino, addirittura – presumibilmente – alla scadenza del corrente anno 2020.
Delle due l’una, allora: o ci si limita a sperare che per quel tempo si determini (miracolosamente) una spontanea piena ripresa produttiva e di redditività o ci si prepara per tempo al governo, con strumenti contrattuali e normativi, di un esubero che potrebbe riguardare un 20% di quei lavoratori e tradursi dunque nel terribile pericolo di oltre 1.000.000 di licenziamenti. Ragioni di pace sociale e di giustizia sostanziale impongono, a parer nostro, il postulato che nessuno venga licenziato e che, anzi, venga finalmente ammesso nel circuito occupazionale anche chi fin da prima ne era escluso. Ciò può essere ottenuto con accordi di solidarietà, prevedenti una riduzione dell’orario settimanale da 40 ore in cinque giornate a 30 ore in quattro giornate, da utilizzare dapprima in funzione “difensiva” , poi trasformata in ”espansiva”, una volta recuperato il precedente livello di ordinativi e di produzione. Questa “trasformazione” dei contratti di solidarietà da difensivi in espansivi è già conosciuta nel nostro ordinamento (art.41 comma 3 bis D. Lgs. N. 148/2015) e significa, semplicemente, che una volta raggiunto l’originale livello produttivo, resta, tuttavia, l’orario settimanale ridotto di 30 ore su quattro giornate e la necessità ulteriore di forza lavoro viene soddisfatta con l’assunzione di disoccupati (preferibilmente giovani destinatari di reddito di cittadinanza). In tal modo si uscirebbe dalla crisi del Coronavirus non già con 1.0000.000 di licenziamenti ma, al contrario, con l’assunzione di 1.000.000 di disoccupati.
Un piano così ambizioso, eppure sicuramente ed anche agevolmente realizzabile, presuppone, però, degli adeguamenti normativi che investono l’assetto attuale degli ammortizzatori sociali, ed un’attenta valutazione e messa a punto delle risorse finanziaria da apprestare. Invero, sulla necessità di una riscrittura praticamente totale del sistema degli ammortizzatori sociali, vi è ormai un generale consenso, ma per motivi politici prima che tecnici: perché l’emergenza sanitaria ha posto all’ordine del giorno la necessità di reimpostarli all’insegna dell’universalismo della tutela, un sistema che, invece, per ragioni storiche, si era configurato come sommatoria di interventi settoriali con macroscopiche differenze di regime e di trattamento da un settore all’altro. Quello di gran lunga privilegiato era il settore manifatturiero ed industriale delle imprese con più di 15 addetti che fruiva, assieme ad altri microsettori equiparati della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria di lunga (un tempo anche lunghissima) durata, ed integrata, nel caso di crisi aziendale sfociante in infine, in licenziamenti, da un generoso trattamento di disoccupazione (“indennità di mobilità”) di durata triennale. Al di fuori di detto perimetro privilegiato – non per capriccio, ben si intende, ma per la preoccupazione politica di salvaguardare il “cuore industriale” – operavano tutele ben più modeste, come quella della Cassa Integrazione Ordinaria, dei Fondi di Solidarietà bilaterale, Fondi di Integrazione Salariale ecc. che, alla fine, lasciavano comunque scoperti i lavoratori delle piccole e piccolissime imprese del settore terziario.
Per poter valutare caratteristiche e fattibilità di un nuovo modello universalistico di ammortizzatori sociali, è però opportuno partire dall’attuale pressante esigenza di garantire l’occupazione esistente e possibilmente espanderla, iniziando con il riflettere su necessità e risorse. La prima considerazione che, a parer nostro, si impone, è che gli allarmismi dell’insopportabilità dei costi, pretesto per giungere allo “sblocco selvaggio” dei licenziamenti, non hanno, in realtà, fondamento razionale, come dimostra una semplice riflessione. Assumiamo pure, per comodità di ragionamento, che i posti di lavoro a rischio siano 1.0000.000 (un milione): ciò significa che, non facendo nulla per salvaguardare l’occupazione lo Stato dovrà, però, pagare 1.000.000 di indennità da NASPI, ossia di un’indennità di disoccupazione universalistica, che spetta a tutti i lavoratori, ha una durata di 18 mesi ed un importo che si aggira su € 1.000,00 mensili. Per “non far nulla e affidarsi al mercato”, come vorrebbero certi neo-liberisti, lo Stato spenderebbe, comunque, 18-20 miliardi, subendo comunque il grave trauma sociale di un milione di nuovi disoccupati. Se, invece, quei 20 miliardi fossero utilizzati per finanziare contratti di solidarietà difensiva per 5 milioni di lavoratori, con diminuzione di 1/5 dell’orario lavorativo, ossia da 5 a 4 giornate settimanali, nessuno verrebbe licenziato, e per tutti si aprirebbe l’opportunità di un giorno libero alla settimana da impiegare, magari, tipicamente o presumibilmente, in necessari corsi di riqualificazione professionale. Tutti comprendono che, dal punto di vista della finanza pubblica, è la stessa cosa dare ad un milione di disoccupati € 1.000,00 mensili, oppure a 5 milioni di lavoratori ad orario ridotto di 1/5 per solidarietà difensiva € 200,00 mensili a compensazione semi-totale della perdita retributiva. Ma dal punto di vista politico e della salvaguardia della pace sociale, la differenza è semplicemente abissale, tra la misura che viene suggerita e quella dello “sblocco” dei licenziamenti con perdita di 1.000.000 di posti di lavoro. Purtroppo è raro che gli osservatori, sia di ceto politico che accademico, riescano ad intravedere questi semplici nessi tra le grandi “voci” di spesa pubblica: allo stesso modo i contratti di solidarietà espansiva che diano finalmente un lavoro a giovani disoccupati poveri che fruiscono del reddito di cittadinanza non costerebbero nulla o quasi nulla alle finanze pubbliche, perché la spesa per la compensazione salariale assicurata ai quattro lavoratori che riducano da cinque a quattro giornate la settimana lavorativa per “fare posto” al nuovo occupato, sarebbe riequilibrata dal venir meno della necessità di pagare a quest’ultimo il reddito di cittadinanza.
Insomma, i contratti di solidarietà difensiva sono un impiego alternativo delle risorse altrimenti destinate alle indennità di disoccupazione NASPI, così come i contratti di solidarietà espansiva sarebbero un impiego alternativo di quelli destinati al reddito di cittadinanza: risorse, dunque, già stanziate, in un caso e nell’altro, secondo la legislazione vigente. Qualcuno, certamente, potrebbe porre in dubbio che siano disponibili nel concreto – pur “dovendolo essere” – i 20 miliardi di competenza NASPI, da utilizzare alternativamente per i contratti di solidarietà difensiva che qui proponiamo. E sarebbe una ben triste obiezione, perché uno Stato che non avesse più i fondi per pagare le indennità di disoccupazione, sarebbe, davvero, in piena bancarotta. Vogliamo essere fiduciosi che così non sia, ma occorre subito aggiungere che, comunque, 20 miliardi siano in arrivo attraverso il progetto europeo S.U.R.E. approvato dal Consiglio UE in data 19 maggio 2020, il quale “esporta”, per così dire, in tutti i Paesi UE l’istituto previdenzialistico della “Kurzarbeit”, che altro non è che, una particolare forma, appunto, di contratto di solidarietà difensivo, una riduzione dell’orario di lavoro opportunamente finanziata e compensata, per evitare il licenziamento. Il punto importante, a nostro avviso, è che la “Kurzarbeit” è istituto universalistico, in quanto si applica anche nelle imprese con un solo dipendente, e dunque è perfettamente in sintonia con quanto viene qui proposto. Si precisano anche, alla luce di queste riflessioni, quali dovrebbero essere le caratteristiche di un ammortizzatore sociale riformato, universalistico, polivalente, che sostituisca tutte le indennità di integrazione salariale e di disoccupazione, che consistesse, ad esempio, in 30 mesi di indennità all’80 % del salario ogni quinquennio mobile. Un ammortizzatore, si ripete, polifunzionale, ovvero a geometria variabile, da utilizzare per contratti di solidarietà difensiva ma anche per sospensioni a zero ore o quale vera e propria indennità di disoccupazione, ossia tanto come ammortizzatore “conservativo” che come ammortizzatore “risarcitorio”.
Questa polivalenza sarebbe, ovviamente, utilissima anche nelle attuali circostanze perché, ovviamente, esistono anche situazioni aziendali nelle quali il contratto di solidarietà difensiva non sarebbe proponibile, come nel caso, ad esempio, della chiusura definitiva di un negozio, comportante, inevitabilmente, il licenziamento della commessa, la quale, allora, potrebbe usare la sua “dote” anche per l’intera durata di 30 mesi, se necessario, come “ammortizzatore risarcitorio”, ossia come indennità di disoccupazione. Razionale corollario dell’istituzione dell’ammortizzatore unico polifunzionale (“dote”) sarebbe il riconoscimento legislativo della teoria cd. dell’ “ultima ratio”, nel senso che, fin quando possibile, l’ammortizzatore unico andrebbe utilizzato come ammortizzatore conservativo, e solo nel caso in cui il licenziamento si imponga, obiettivamente, come unico esito residuo (“ultima ratio”) come indennità di disoccupazione. A questa prima fase prossima futura, riguardante la salvaguardia dell’occupazione, alla scadenza dell’attuale “blocco dei licenziamenti”, mediante contratto di solidarietà difensiva, dovrebbe, poi, seguire una seconda fase, quella della solidarietà “espansiva” nella quale, una volta ritornato normale il fabbisogno di forza-lavoro per la ripresa della domanda interna ed internazionale, non per questo si tornerebbe, però, per i già occupati, all’orario di 40 ore su cinque giorni settimanali. Si attiverebbe, invero, la trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva, e i nuovi assunti (uno ogni quattro occupati ad orario ridotto) fornirebbero le ore lavorative tornate necessarie ma mancanti. Si attiverebbe, in proposito, un’altra fonte di finanziamento, perché i nuovi assunti, sarebbero, con ogni probabilità già percettori di reddito di cittadinanza, che non dovrebbe più, ovviamente, essere loro pagato, con destinazione di equivalenti risorse alla compensazione salariale di quanti, già occupati nell’impresa “restano” ad orario ridotto, lasciando così spazio per i nuovi assunti. E’ chiaro che, stante il carattere dinamico delle vicende di recupero produttivo, l’accordo aziendale di ripartenza dovrebbe assumere un carattere oltre che dispositivo anche programmatico, con la previsione, altresì, di una serie di appuntamenti negoziali correlati all’evoluzione della situazione.
3) Misure organizzative per la sicurezza ed il miglior utilizzo delle risorse umane
La seconda tematica che deve di necessità essere contemplata in un accordo di ripartenza è certamente costituita dalle modalità di applicazione dei protocolli di sicurezza (di cui all’allegato 12 del DPCM 17 maggio 2020) e, per conseguenza ed estensione di un nuovo assetto organizzativo aziendale. I protocolli sono stati qualificati come “condivisi” tra le parti sociali fin dalla loro prima formulazione (14 marzo 2020), ed emblematica, in proposito, è la finale previsione della costituzione nelle aziende di un “Comitato” per l’applicazione e verifica delle regole, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L’effettiva costituzione dei Comitati e la scrupolosità, sistematicità e documentazione della loro attività è nell’interesse specifico delle imprese anche con riguardo alla tematica sollevata in modo clamoroso dalle associazioni imprenditoriali attinente alla responsabilità civile ed anche penale degli imprenditori nell’ipotesi di contagio da Covid-19 in occasione dell’attività lavorativa, visto che detto contagio è stato espressamente qualificato come “infortunio sul lavoro” dall’art. 42 D.L. 18/2020, al fine anzitutto dell’esclusione di un aggravio dei premi assicurativi INAIL. Di qui la richiesta di uno “scudo” legale contro l’insorgere di dette responsabilità, ma è quasi ovvio notare in proposito che la parificazione della “causa virulenta” alla “causa violenta” come causatrice di infortunio sul lavoro è acquisizione antica e tradizionale nella legislazione antifortunistica, fin dal tempo del riconoscimento dell’infezione malarica, e dunque nessuna novità o anomalia logico-giuridica può essere rinvenuta nella previsione dell’art. 42 del D.L. 18/2020, che di per sé costituisce anzi, sotto il profilo finanziario, una norma di favore per le imprese. Nel concreto, però, il problema resta, perché in presenza di una causa “invisibile”, ma comunque insita nell’adibizione lavorativa, è pressoché inevitabile finire con il far capo a quest’ultima, secondo il canone post hoc, propter hoc, e, dunque, ad una negligenza del datore di lavoro con conseguente responsabilità.
Per placare la polemica è stata emanata la circolare INAIL 20 maggio 2020 n.22, la quale, per così dire, ha cercato di “tenere la barra al centro” ribadendo, da un lato, che l’infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro costituisce, come ogni altra causa virulenta, infortunio sul lavoro, ma che l’imputabilità dello stesso al datore di lavoro debba essere esclusa – e con essa l’insorgenza di responsabilità civili e penali in capo al medesimo e di un diritto di regresso dell’INAIL – quando non vi sia stata da parte del datore di lavoro inosservanza dei “protocolli e linee giuda governative e regionali” di cui all’art. 1, comma 14, del 16 maggio 2020 n.23. Con questo, però, la questione non è del tutto risolta, perché le misure protezionistiche vanno valutate sotto un profilo non statico ma dinamico: si pensi, per portare un esempio elementare, ai lavoratori di un magazzino ai quali sono state assegnate posizioni di lavoro correttamente distanziate a stregua dei protocolli di sicurezza ma che poi, al bisogno, si aiutano l’un l’altro nello scarico di materiali pesanti, così creando pericolo di contagio. Acquista, allora, grande rilievo proprio la “verifica” affidata ai Comitati dell’applicazione concreta delle misure di prevenzione, il “monitoraggio” delle prassi in uso e la sua documentazione periodica, alla luce della quale sarebbe poi valutata, inevitabilmente, la diligenza o negligenza dell’impresa nell’osservanza di quanto imposto dall’art. 2087 c.c. Dunque, proprio le modalità, gli oggetti e la documentazione di questi monitoraggi, oltre che della predisposizione “in situazione statica” delle misure previste dai protocolli dovranno costituire oggetto specifico degli accordi di ripartenza. Questi, peraltro, dovrebbero contenere anche misure organizzative, rispettose dei protocolli, riguardanti sia l’assetto logistico dell’Azienda sia l’impiego delle risorse umane, in vista della ripresa produttiva, e di nuove strategie produttive aziendali.
Si allude alla pattuizione di diversi turni di lavoro, con tendenziale estensione della “striscia” temporale complessiva di attività e parallela rarefazione delle presenze per turno, ma soprattutto al ricorso al cd. “lavoro agile” o “smart working” che proprio la pandemia ha fatto conoscere ma, meglio ancora, sperimentare ad un numero molto grande di lavoratori italiani. Poiché la tematica è di singolare importanza, ed addirittura tale da poter far pensare ad un “cambio di paradigma” nell’organizzazione dell’impresa e del lavoro, con riflessi persino sulla condizione esistenziale dei lavoratori, è giocoforza richiamare anzitutto alcune semplici nozioni storico-giuridiche. Ciò che si è determinato, in occasione e a causa della pandemia, è stato un ricorso di massa a prestazioni di lavoro al domicilio del lavoratore, non investito ovviamente di mansioni di tipo manuale, bensì impiegatizie e comportanti l’utilizzo di strumenti informatici, quale unica soluzione possibile per non interrompere l’attività, evitando, da un lato, la sospensione dell’attività di impresa, e, dall’altro, il collocamento in cassa integrazione a zero ore. Questo fenomeno è stato universalmente conosciuto come ricorso allo “smart working” o “lavoro agile”, con applicazione, in teoria, della normativa contenuta nella Legge n. 81/2017, che, a dire il vero, si adatta solo parzialmente all’esperienza concreta verificatasi durante la pandemia stessa. Basti dire che la Legge n. 81/2017 descrive la fattispecie del “lavoro agile” come quella di una prestazione lavorativa che viene eseguita in parte all’interno ed in parte all’esterno della sede aziendale, con forte autonomia esecutiva e proiezione verso risultati specifici. Detto in modo semplice, l’ “identikit” del “lavoratore agile” a stregua della previsione legislativa è, ad esempio, quella di un funzionario del settore o divisione commerciale della Ditta, che è “fuori” tutta la settimana per ispezionare la rete vendita, curare la clientela più importante ecc.. e poi ritorna in sede un giorno per riferire, programmare, aggiornare dati, senza escludere che possa operare, durante la settimana, anche dal suo domicilio, con vari strumenti comunicativi ed informatici. La definizione legislativa del “lavoro agile” come lavoro comunque subordinato, è, però – detto per inciso – molto importante, perché espunge dalla fattispecie gli elementi tradizionali e specifici della eterodirezione, quali i “controlli assidui e direttive capillari”, mettendo, invece, al centro, la piena e responsabile collaborazione alla realizzazione di un piano d’impresa ideato dal datore di lavoro.
Qualcuno potrebbe, pertanto, sostenere che, durante la pandemia, si sia trattato e si tratti, piuttosto che di “smart working”, del ricorso, reso frequente e necessitato dallo stato di emergenza sanitaria, al più tradizionale “telelavoro” domiciliare, già da molto tempo regolato nel nostro Paese dalla Legge n. 191/1988 con riguardo ai dipendenti pubblici e dall’accordo interconfederale 9 giugno 2004 (attuativo dell’accordo quadro europeo del 16 luglio 2002) per i dipendenti privati. Si tratterebbe, però, di una precisazione alquanto miope e pignola, perché, nell’esperienza sociale di questi mesi di emergenza sanitaria, se il “corpo” dell’istituto in concreto utilizzato è stato quello del telelavoro, l’“anima”, invece, è stata quella dello “smart working”, come subito si avrà modo di spiegare. Il telelavoro, in Italia, ha avuto scarso successo (riguarda, in tutto, il 3,6% dei lavoratori, contro il 15%, ad esempio, dei Paesi Bassi), perché si tratta, in definitiva, del “trasloco” di un pezzo dell’ufficio dalla sede ove operava il lavoratore, al suo domicilio, senza altre variazioni nelle mansioni e con probabile detrimento delle possibilità di miglioramento professionale.
Indagini sociologiche hanno rilevato che, per lo più, dopo un primo periodo di soddisfazione per l’esenzione da faticosi pendolarismi e la possibilità di espletamento anche di mansioni di cura familiari, subentra nel lavoratore un senso di isolamento, di ripetitività, ed egli lamenta la soggezione ad una invasività nella vita privata a causa di richieste e controlli e, soprattutto, l’esclusione dalla socialità insita nella comunità di lavoro. Ma proprio questa è stata la peculiarità e la novità della recente esperienza: poiché la pandemia obbligava tutti i lavoratori ad operare in “smart working” la quantità è divenuta qualità, per così dire, e la socialità già vissuta e sperimentata nell’azienda intesa come luogo fisico, si è trasferita e riprodotta sulla rete informatica, spesso con maggiore efficienza e più agevole partecipazione. Già oggi, dopo pochi mesi di necessitata “full immersion” nella modalità lavorativa in “smart working”, l’idea di dover partecipare ad una riunione di lavoro con presenza fisica appare fastidiosa, stancante e arcaica a chi ha fatto ripetute esperienze di riunioni in video-conferenza. E lo stesso dicasi per la consultazione di colleghi, per i “riporti” ai superiori, per commenti positivi o critici ad episodi di lavoro e di vita, tutte comunicazioni che, quando non necessitano di presenza fisica, risultano addirittura semplificate. Gli “accordi di ripartenza” dovrebbero dunque decidere se sia opportuno procedere ad una parziale “smaterializzazione” dell’azienda, che resta, però, una comunità di lavoro, mediante un passaggio allo “smart working” tendenzialmente totale e generale, o se non convenga, per vari motivi, ridurlo, più o meno, al rango di telelavoro domiciliare, come variabile secondaria della prestazione lavorativa su base volontaria individuale, salva, eventualmente, però, la previsione di una casistica che ne faccia un’aspettativa giuridicamente protetta dei lavoratori o del datore di lavoro. Si comprende agevolmente, per converso, come una generalizzazione dello “smart working” comporterebbe un rilevantissimo allargamento del mercato del lavoro. Diverrebbe normale farsi assumere da un’impresa di Milano, garantendole un contributo lavorativo di ottima qualità, senza alcun bisogno di emigrare da Crotone o da Taranto.
In definitiva, con riguardo alla tematica dello “smart working”, un accordo di ripartenza dovrebbe porsi, anzitutto, la tematica dell’adozione generalizzata di tale modalità lavorativa per tutti i dipendenti per i quali risulti tecnicamente possibile, e poiché si tratterebbe davvero di un “cambio di paradigma” organizzativo e lavorativo, un simile accordo dovrebbe essere sottoposto a referendum, a livello aziendale. In alternativa, qualora ci si limitasse a mantenere lo “smart working” nei tradizionali ristretti limiti di una modalità eccezionale, individualizzata, di esecuzione della prestazione lavorativa, occorrerebbe, comunque, stabilire i casi nei quali il passaggio allo “smart working” costituisca un diritto del lavoratore o quanto meno un’aspettativa giuridicamente protetta a stregua del canone di buona fede.
Si ripete, insomma, la vicenda che ha riguardato il lavoro a “part-time”: in origine si tratta va di una semplice pattuizione individuale, poi, però, assoggettata, in progresso di tempo, alla contrattazione collettiva con l’emersione, allora, di ipotesi di pretesa garantita alla trasformazione a “part-time” del rapporto di aspettativa giuridicamente protetta e di clausole varie di governo degli interessi delle parti: si pensi ad esempio, alle clausole di preferenza e precedenza o, invece, di recesso e reversibilità della scelta, ecc…La stessa esperienza della pandemia si è incaricata, d’ altra parte, di dimostrare come il tema del passaggio allo “smart working” non possa restare limitato ad una sfera pattizia individuale: seppur limitatamente al periodo dell’emergenza epidemiologica (che dovrebbe terminare il 31 luglio 2020) il DL n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha previsto che lo “smart working” possa costituire, hinc et inde, oggetto di diritto ed obbligo. L’art. 90 del D.L. n. 34/2020, infatti, al primo comma prevede, infatti, finché duri l’emergenza epidemica, il diritto del lavoratore con almeno un figlio minore di 14 anni, di passare allo “smart working” a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, ed il quarto comma contiene una previsione ben più impegnativa, e cioè che i datori di lavoro privati e pubblici possano applicare lo “smart working” a tutti i rapporti di lavoro subordinato “anche in assenza di accordi individuali”. Il che significa, puramente e semplicemente, che disporre lo “smart working” per tutti o dipendenti diviene, durante detto periodo, un profilo dello ius variandi datoriale. Si può naturalmente osservare che una tale estrema previsione si spiega proprio e solo con l’opportunità e necessità, in fase pandemica, di diradare le presenze nei tradizionali luoghi di lavoro, ma è inevitabile chiedersi se poi, ad emergenza epidemiologica terminata, si tornerà davvero indietro.
E questo perché quando lo “smart working” è compatibile con le caratteristiche della prestazione, i suoi vantaggi, anzitutto economici, per il datore di lavoro sono evidenti, ma anche i lavoratori possono trarne notevoli benefici senza pagare lo scotto di un’emarginazione sociale.