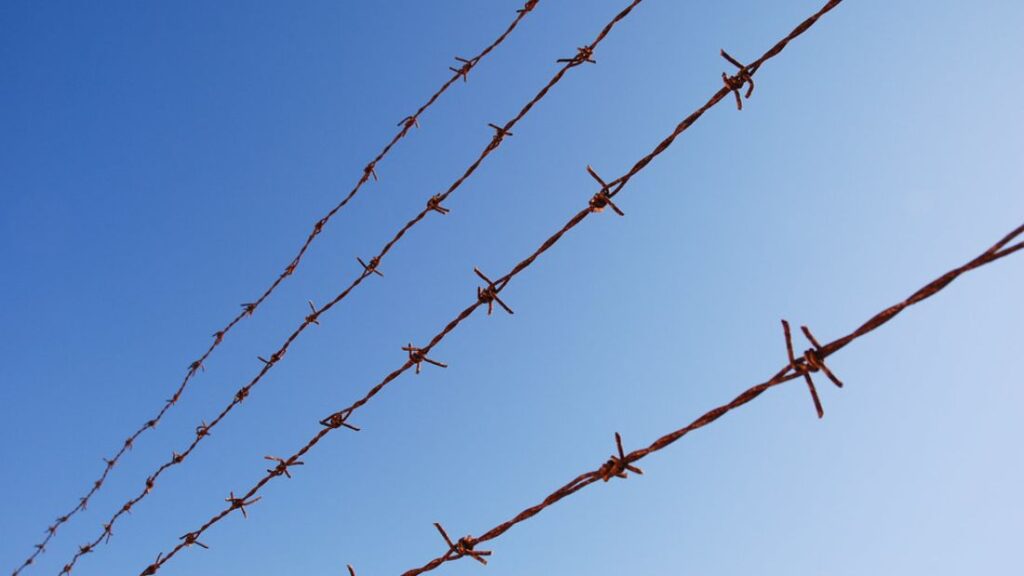di Étienne Balibar
Nel Mediterraneo la situazione è sempre più tesa. Un’ecatombe quotidiana, in parte dissimulata. Stati che, per parte loro, istituiscono o tollerano pratiche di eliminazione che la storia giudicherà senza dubbio come criminali. Contemporaneamente, hanno luogo iniziative che incarnano lo sforzo di solidarietà della «società civile»: città-rifugio, «passeurs d’umanità», navi di salvataggio troppo sovente costrette alla guerriglia contro l’ostilità dei poteri pubblici. Questa situazione esiste anche in altre parti del mondo. Ma per noi, cittadini europei, riveste un significato e ha un’urgenza speciale. Richiede una rifondazione del diritto internazionale, orientato verso il riconoscimento dell’ospitalità come «diritto fondamentale» che imponga agli stati degli obblighi, la cui portata sia almeno eguale a quella dei grandi proclami del dopo guerra (1945,1948,1951). Bisogna quindi discuterne.
In primo luogo, di chi stiamo parlando? Di «rifugiati», di «migranti» o di un’altra categoria che le inglobi entrambe? È noto che queste distinzioni sono al centro delle pratiche amministrative e della loro contestazione. Ma, soprattutto, dal modo in cui nominiamo gli esseri umani che dobbiamo proteggere o bloccare, dipende anche il tipo di diritti che riconosciamo loro e il modo in cui qualifichiamo il fatto di privarli di essi. Il termine che propongo è quello di erranti.
Mi spingo a parlare di erranza migratoria o di migranza piuttosto che di «migrazione». Il diritto internazionale dell’ospitalità deve rivolgersi agli erranti della nostra società mondializzata, riflettere i caratteri dell’erranza migratoria in quanto tale, con particolare riguardo per le violenze che si concentrano nei percorsi. Vari argomenti vanno in questa direzione.
In primo luogo, l’ossessione per il respingimento dell’immigrazione detta clandestina e l’identificazione dei «falsi rifugiati» ha finito per causare un «capovolgimento del diritto d’asilo» (Jérôme Valluy). Le autorità utilizzano la categoria di «rifugiato» non per organizzare l’accoglienza di persone che fuggono la crudeltà della loro esistenza, ma per delegittimare chiunque non corrisponda a certi criteri formali o non sa come rispondere in modo appropriato a un interrogatorio. Questo però non sarebbe possibile se i criteri ufficiali non fossero straordinariamente restrittivi, in modo da separare l’ottenimento dello statuto di rifugiato dal diritto di circolazione, ponendo al tempo stesso la sovranità degli stati al di fuori di ogni possibilità di essere veramente contestata. Non c’è posto per condizioni come la guerra civile o la guerra economica, la dittatura o la restrizione della democrazia, la catastrofe ambientale, tutte situazioni che oggi sono alla radice delle erranze. In più, negando queste realtà, oltre a fare violenza a coloro che le vivono, gli stati trasformano a loro volta masse di migranti in rifugiati senza rifugio, cacciati da un campo all’altro. Sono questi usi (e cattivi usi) che vengono fatti di questa distinzione che ci obbligano oggi a ripensare il problema, per dare una soluzione che ha anche degli aspetti giuridici.
Su questo tema vengono invocate diverse giustificazioni. Una concezione umanista affermerà che la libertà di circolazione è uno dei diritti dell’uomo, altrettanto fondamentale della libertà di espressione o dell’habeas corpus. Esigerà che gli stati pongano meno ostacoli possibili. Una concezione liberale esprimerà la stessa esigenza in termini di «lasciar passare», che vale sia per gli esseri umani che per le merci, i capitali o le informazioni. Nelle varianti egualitarie, insisterà sull’ingiustizia che c’è nel riservare il diritto a cambiare residenza ai ricchi e ai potenti, escludendo i poveri e gli sfruttati. Tutti questi ragionamenti non mancano di forza né di fondamento, ma non mi sembra che affrontino la specificità della migranza contemporanea, perché neutralizzano lo choc tra le situazioni di miseria e gli interventi statali che le affrontano.
Molto più pertinente mi sembra l’applicazione rigorosa delle nozioni contenute nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, a proposito della circolazione, della residenza e dell’asilo: da un lato, a causa della logica che consiste a correlare dei diritti di segno contrario (come il diritto ad emigrare e il diritto al ritorno), dall’altro a causa della preoccupazione di non creare individui privi di diritti o delle non-persone. Il grande limite qui è che fanno dell’appartenenza nazionale e della sovranità territoriale l’orizzonte assoluto dei dispositivi di protezione delle persone, mentre, nella situazione attuale, l’evidente necessità è di limitare l’arbitrio degli stati, opponendo dei contro-poteri legittimi, internazionalmente riconosciuti. Per questo suggerisco di andare al di là di questi testi, dando corpo a un diritto dell’ospitalità, il cui principio è che gli erranti (e coloro che portano loro soccorso) possono rivendicare obblighi dello stato «sovrano» stesso, di modo che la loro dignità e sicurezza non siano, come oggi, sistematicamente schiacciate.
È altrettanto necessario riferirsi qui a una delle formule-chiave del 1948: «ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica» (articolo 6 della Dichiarazione universale). In ogni luogo vuole dire anche negli uffici dell’immigrazione, durante un controllo alla frontiera, in un campo di rifugiati e, se possibile, anche sul fondo di un gommone che deriva in alto mare… È qui che bisogna chiedere all’autorità di rispettare i propri obblighi, ma è anche qui che si deve resistere, a causa della tendenza specifica a sacrificare i diritti umani a delle esigenze «securitarie». Il principio dei principi è che i migranti in situazione di erranza godano di diritti concreti che possono opporsi alle leggi e regolamenti statali, cosa che implica anche che possano difendersi o essere rappresentati davanti a una giurisdizione ad hoc o di diritto comune.
Da questo principio deriverebbero conseguenze di vari ordini:
- a) la proibizione del respingimento: non soltanto gli erranti non possono essere violentemente respinti da una frontiera o da una costa, ma devono poter esprimere i loro bisogni in condizioni dove venga rispettata la loro dignità, l’integrità corporale, l’autonomia individuale, e venga tenuto conto delle sofferenze subite. L’«onere della prova» non deve essere a carico degli erranti, ma degli stati che esitano ad accoglierli.
- b) gli stati e la polizia che opera alle frontiere o all’interno di un territorio non devono brutalizzare gli erranti: nozione purtroppo molto vasta, che va dalle violenze esercitate contro individui senza documenti fino alla creazione di quello che l’attuale premier britannica Theresa May aveva chiamato «hostile environment», un ambiente ostile per gli stranieri, passando per la chiusura nei campi e la separazione delle famiglie.
- c) gli stati non devono stilare liste dei paesi d’origine i cui cittadini abbiano a priori la proibizione di entrare, basate su criteri razziali, culturali, religiosi o geopolitici (nonostante la necessità per gli stati di premunirsi contro azioni terroristiche a cui l’erranza puo’ servire da copertura).
- d) le operazioni militari non devono cercare di distruggere le organizzazioni o le reti di passeurs mettendo a rischio la vita degli erranti, che sono le vittime e non i committenti. Naturalmente le decisioni che impediscono le operazioni di soccorso o tentano di farle fallire, devono essere considerate come complicità criminale (crimini contro l’umanità).
- e) gli stati, per lavarsene le mani, non devono esternalizzare la «gestione» dei flussi di migranti e di rifugiati. In particolare, non devono negoziare con paesi terzi definiti per la circostanza «sicuri», degli accordi di baratto (ritenzione forzata contro sovvenzioni), che, in modo inconfessabile, li abbassano allo stesso livello dei «passeurs» mafiosi di cui denunciano l’attività.
Queste disposizioni pongono soprattutto dei limiti e dei divieti, più che prescrivere dei comportamenti. Questo è conforme alla natura del discorso giuridico quando si tratta di rettificare una violenza o un abuso. Non si tratta di mettere fine per decreto all’erranza dei migranti e dei richiedenti asilo, e neppure di cancellare le cause che hanno causato l’esodo. Ma si tratta di impedire che, con la scusa di gerarchizzare le cause, la politica degli stati trasformi l’esodo in un processo di eliminazione. I migranti in erranza e coloro che vengono loro in aiuto devono avere il diritto dalla loro parte, nei loro sforzi per resistere. È poco – ma forse è molto.
Non c’è un diritto all’ospitalità, poiché è una disposizione collettiva che dipende dalla libertà, una «responsabilità condivisa» (M.Delmas-Marty). Ma bisogna sviluppare il diritto dell’ospitalità, attività civica in pieno sviluppo, a causa dell’urgenza della situazione. Andando al di là della proposta kantiana di un «diritto cosmopolita» limitato al diritto di visita, ne generalizzerebbe la norma fondamentale: gli stranieri non devono essere trattati come nemici. Purtroppo è precisamente questo l’effetto delle politiche di un numero crescente di stati contro la migranza globale.
Gli erranti non sono una classe. Non sono una razza. Non sono «la moltitudine». Direi che sono una parte mobile dell’umanità, sospesa tra la violenza dello sradicamento e quella della repressione. È solo una parte della popolazione mondiale (una piccola parte del resto), ma altamente rappresentativa, perché la sua condizione concentra gli effetti di tutte le ineguaglianze del mondo attuale e perché è portatrice di quello che Jacques Rancière ha chiamato la «parte dei senza parte», cioè la mancanza di diritti che bisogna colmare perché ci sia finalmente eguaglianza nell’umanità. Si tratta di sapere se l’umanità espelle da sé questa parte di se stessa o se ne integra le esigenze nell’ordine politico, nel suo sistema di valori. È una scelta di civiltà. È la nostra scelta.
Questo articolo è stato pubblicato dal quotidiano Il manifesto il 12 agosto 2018