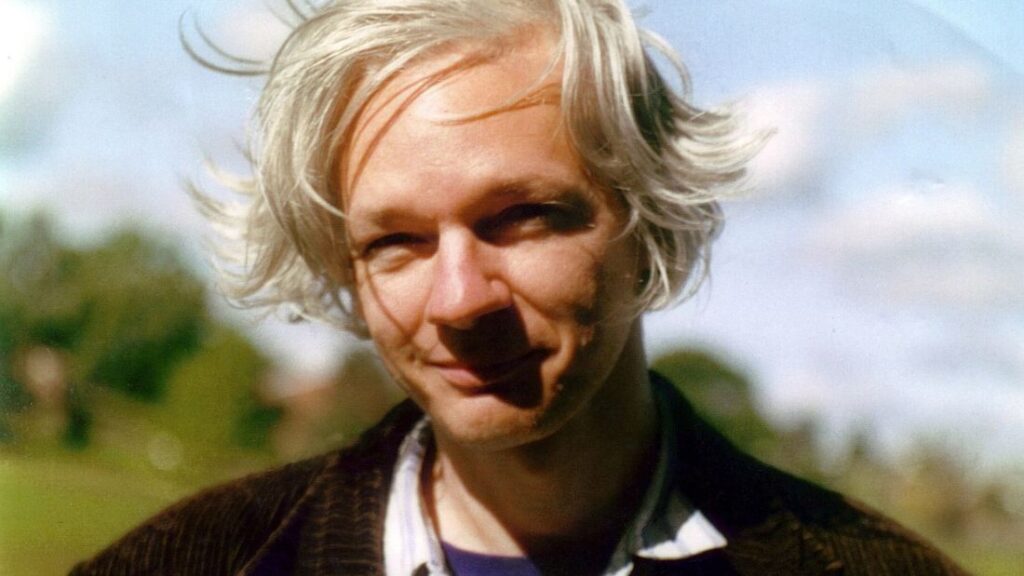di Vincenzo Vita
Si è celebrata la giornata mondiale per la libertà di stampa, promossa dalle Nazioni unite nel 1993. Si grida all’effimero successo in Italia, perché si è passati dal 77° al 52° posto nella classifica annuale di “Reporters Sans Frontières”, ma il quadro delle concentrazioni editoriali (da Mondazzoli, a Gedi: il super gruppo Repubblica, Stampa, Secolo XIX, al controllo governativo sulla Rai, al vecchio trust Mediaset, all’affare Vivendi) e del precariato dilagante non fa ben sperare. Interferenze, interventi a gamba tesa divengono regola e non eccezione. Qui lo scontro per lo meno si ferma alle parole e agli editti censori. In numerose aree del mappamondo testate indipendenti, giornalisti ed operatori dell’informazione sono a rischio anche fisico e il carcere è la pratica consueta e crudele dell’amputazione di un diritto fondamentale: a parole in cima alle convenzioni internazionali e alle Costituzioni, nei fatti negato.
Sul caso terribile della Turchia, tutt’altro che risolto dalla importante liberazione di Gabriele Del Grande, si è tenuto un riuscito sit in davanti alla Camera dei deputati, promosso da Articolo21, Amnesty Italia, Fnsi, UsigRai, Odg Lazio, Pressoing NoBavaglio, Arci, Carta di Roma, Ucsi, Adif e vari altri. Una delegazione è stata ricevuta dai presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama. La protesta (non solo a Roma) riguardava l’angosciante situazione del paese di Erdogan.
Le cifre parlano da sole: 203 tra professionisti dei media, vignettisti, scrittori e documentaristi sono detenuti, 103 ricercati, 16 a piede libero in attesa di giudizio; 150 i mezzi della carta stampata o radiotelevisivi, agenzie, siti sequestrati o costretti a chiudere. Il tutto in quadro repressivo abnorme, che tocca numerosi altri settori colpiti da un generale clima brutale.
Attenzione, però, a considerare la vicenda turca una patologia anomala ed estrema. Niente affatto. Le orde contro la libera informazione sono all’opera, a cominciare dagli Stati uniti di Trump, dalla Russia, dalla Cina, fino alle dittature del Medio Oriente o africane, alle Filippine, e così via.
In verità, la crisi in atto delle democrazie rappresentative classiche porta con sé il morbo della censura. Nella società dell’informazione e nell’economia digitale il conflitto sulle zone di autonomia e di affermazione dell’indipendenza è diventato il fulcro stesso dei nuovi equilibri, dopo che la tradizione liberale è stata travolta dalla sua bulimica filiazione liberista. Insomma, il capitolo delle libertà nell’era digitalizzata è di un’attualità stringente.
Restaurazione e dispiegamento degli apparati censori. Un altro sit-in davanti al parlamento ha voluto sollecitare l’attenzione sull’orribile storia dei 1.500 prigionieri palestinesi buttati in galera senza neppure precisi capi di accusa e in molti casi soggetti a tortura o alla violazione degli elementari diritti umani. È in corso, dal 17 aprile, lo sciopero della fame dei prigionieri, cui le associazioni promotrici della mobilitazione vorrebbero dare seguito pure in Italia.
Tra l’altro, il governo ha votato contro nelle scorse ore ad una legittima proposta in sede Unesco in merito alla sovranità di Israele su una parte di Gerusalemme. È stato rovesciato lo spirito delle pur timide posizioni precedenti. Quindi, è particolarmente urgente la discussione pubblica su ciò che sta avvenendo in quella dimenticata area della terra, dove è messa in causa la sopravvivenza stessa della Palestina, sottomessa e colonizzata da un governo che più di destra non si può.
Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano Il manifesto il 3 maggio 2017