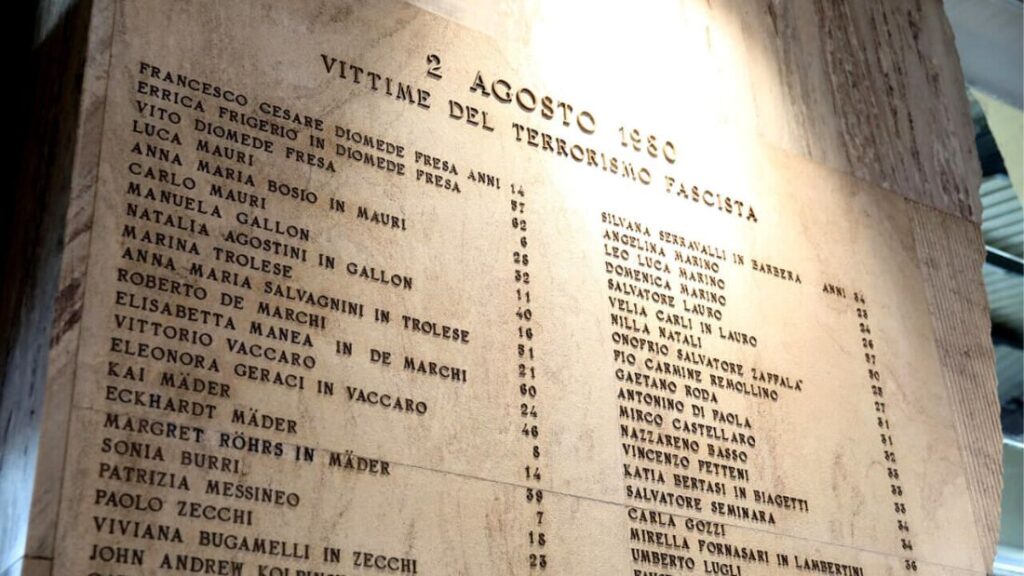di Wu Ming
«A momenti ho l’impressione che Bartleby annunci una grande e improvvisa deperibilità – qualcosa che sconvolgerà definitivamente le vecchie economie statiche, recherà l’incertezza in ogni situazione familiare, o locale, o di gruppo, o di affiliazione. Del resto lui sembra ormai lontano anni luce da situazioni del genere – presenza dispersa ‘come un relitto in mezzo all’oceano Atlantico’ – perché non è più il figlio smarrito da riscattare con la carità e qualche buona intenzione, ma l’orfano assoluto su cui carità e buone intenzioni non hanno presa».
Gianni Celati, introduzione a Bartleby lo scrivano di H. Melville
Tutti in città continuano a parlare di Bartleby. Viene da chiedersi il perché di questa attenzione per una realtà tutto sommato di piccole dimensioni e con la quale sembra che nessuno sia intenzionato a interloquire davvero. Per altro, molti commentatori prendono la parola solo per dire che quell’esperienza è ampiamente sopravvalutata. Nondimeno sono due anni che le istituzioni cittadine continuano a rimpallarsi questa patata bollente: l’Università la passa all’assessore, che la passa a un altro assessore che la ripassa all’Università, etc.; con la Questura in mezzo a seguire questo ballo della scopa, per poi murare, affibbiare qualche manganellata, raccogliere denunce.
Nel mezzo di questa tempesta in un bicchiere d’acqua, galleggia Bartleby, «l’orfano assoluto», come dice Gianni Celati parlando del personaggio letterario di Melville.
Quest’orfano l’Università proprio non lo vuole. Altrimenti non l’avrebbe sfrattato da via San Petronio Vecchio, né gli avrebbe proposto di trasferirsi in un capannone all’estrema periferia della città, in una zona industriale semidisabitata.
Neanche il Comune lo vuole. Altrimenti non solo non avrebbe assecondato la suddetta proposta, ma soprattutto avrebbe dato seguito alla precedente soluzione trovata dall’assessore alla cultura, che aveva proposto a Bartleby uno spazio seminterrato in via S. Felice e aveva già incassato l’assenso del collettivo.
Tanto meno lo vuole il partito di maggioranza. Altrimenti alcuni suoi esponenti non avrebbero ostacolato la soluzione dell’assessore alla cultura e fatto saltare l’accordo di cui sopra.
Pare che perfino i quotidiani locali avversino Bartleby. Altrimenti non si spiegherebbe la gara di provocazione in cui si sono lanciati: si va dall’inviata all’assemblea cittadina che invece di parlare dell’assemblea parla delle scritte sui muri, al commentatore che insulta e offende perfino il povero Herman Melville (colpevole di avere scritto un racconto il cui protagonista sarebbe un “idiota” e un “prepotente”); dalle frecciatine lanciate sulle rubrichette locali, ai raccontini vagamente satirici; per concludere con i titoloni sugli slogan “sanguinari” di Bartleby (perché chiamano in causa il conte Dracula!).
La giunta comunale pure non scherza quanto a paroloni che meriterebbero più giusta causa o anche solo un minimo senso delle proporzioni. Il coordinatore di giunta ha definito “gravissimo” che alcuni consiglieri comunali di SEL abbiano partecipato al corteo dopo lo sgombero di Bartleby, sfociato nell’occupazione temporanea di uno stabile chiuso da sei anni. Occupazione che ha prodotto tre giorni di assemblee e concerti, prima che le forze dell’ordine lo risigillassero senza colpo ferire. Viene da dire che se le cose gravissime sono queste, si dev’essere visto proprio un bel mondo, ma data l’età anagrafica e la provenienza di chi ha pronunciato la reprimenda, forse c’è anche poco da meravigliarsi. Per altro gli stessi consiglieri di SEL, messi sotto accusa per aver sfilato con i facinorosissimi melvilliani, hanno fatto retromarcia e qualcuno è perfino arrivato a dire che era là in qualità di “osservatore”. Come se la zona universitaria di Bologna fosse la Bosnia-Herzegovina.
I giornali hanno poi lanciato la notizia che al Rettore è stata assegnata una scorta personale dalla Digos in seguito allo sgombero di Bartleby. Al di là del colpo letale al senso del ridicolo che il fatto stesso costituisce, è da notare che in questo modo sono stati proditoriamente collegati tra loro due episodi che invece non lo sono. Il provvedimento risale infatti ai primi giorni dell’anno, quando Bartleby non era ancora stato sgomberato, ma si è voluto mettergli in carico anche questo, così, tanto per rincarare la dose.
Sulla stessa linea di confine tra il grottesco e il paradossale si colloca la lettera che una cinquantina di docenti dell’ateneo ha ritenuto di rendere pubblica per stringersi intorno al Magnifico, “aggredito” dai “toni violenti” del collettivo Bartleby in occasione dello sgombero. Per non perdere l’occasione di mostrare la propria incondizionata solerzia e devozione, questi professori non si sono fatti remore di evocare un improbabile scenario di guerra e violenza che i melvilliani sarebbero pronti a scatenare nell’università. Probabilmente si riferivano a uno degli slogan lanciati dal collettivo: «Dissotterriamo le asce di guerra», accompagnato da un libro-scudo del book bloc che richiama la copertina di un romanzo multiautore e che è stato portato in rettorato. Chiunque abbia letto il romanzo sa che si tratta di un’immagine figurata e che le “asce di guerra” da dissotterrare altro non sono che le storie sepolte da riscoprire e usare come armi. Leggere un romanzo però richiede tempo, mentre scrivere una castroneria in una lettera è questione di un attimo.
Una delle accuse più in voga tra i detrattori di Bartleby è quella di aspirare con italica furberia a un’assegnazione preferenziale, scavalcando le tante associazioni in attesa di un bando per gli spazi comunali. Difficile dire se il ribaltamento retorico della realtà rientri tra gli aspetti deteriori del carattere nazionale, ma senz’altro questo ne è un fulgido esempio. I castigatori dei costumi nostrani dimenticano infatti che prima che fosse chiuso con la forza, Bartleby uno spazio l’aveva. A dirla tutta, prima che la convenzione con l’Università scadesse, non era nemmeno una realtà “occupante”. Il progetto Bartleby non è una lista di desiderata, vanta un curriculum pluriennale, e c’è una schiera di scrittori, artisti, docenti, ricercatori, musicisti, editori, che può testimoniarlo, per essere transitata da lì insieme a migliaia di altre persone. La domanda sensata dunque non è perché Bartleby non ha partecipato a un bando d’assegnazione, ma perché si è ritenuto di sbattere in mezzo alla strada un’esperienza che l’assegnazione già ce l’aveva e la metteva a frutto. La domanda da porsi è perché le istituzioni bolognesi hanno deciso che quel progetto deve morire. Ma ci si potrebbe anche chiedere come è possibile riempirsi la bocca di parole inneggianti alla valorizzazione dell’esistente e all’autorganizzazione dal basso fin dalla campagna elettorale, e poi negare la possibilità di sopravvivenza a chi soddisfa proprio queste condizioni.
Al momento Bartleby si è ridotto a portare avanti le proprie attività in un’aula occupata della facoltà di Lettere e Filosofia. E già riceve minacce di sgombero. Cosa si vorrebbe fare? Mandare la polizia in università come nel ’68 per far sloggiare una comunità di studenti che organizza dei seminari, cioè che studia? O non si potrebbe piuttosto pensare che la soluzione più sensata è quella di dare a questa esperienza uno spazio decente dove proseguire le proprie attività aperte a tutti?
La risposta sembrerebbe davvero semplice. E in effetti lo è, ma pare che a Bologna si stia vivendo una specie di allucinazione collettiva.
Torniamo così alla domanda iniziale: perché tutto questo chiasso?
Forse i motivi del bad trip vanno ricercati nel fatto che il “caso Bartleby” rimanda da un lato alla storia di questa città, dall’altro alle scelte per il suo futuro.
Chi detiene ruoli nelle istituzioni cittadine finge di non sapere che, fin dagli anni Settanta, proprio da un certo milieu urbano, cioè dall’incontro tra giovani bolognesi e studenti “fuorisede”, è scaturita gran parte delle esperienze innovative e culturalmente interessanti. Radio libere, riviste autoprodotte, collettivi studenteschi, associazioni gay-lesbo, editoria indipendente, fumettisti, scrittori, dj, artisti, teatranti, rock band, posse, muralisti, operatori delle reti telematiche, e chi più ne ha più ne metta. Il sospetto è che certe esperienze attuali debbano essere esorcizzate perché sono lo spettro della Bologna che fu, come nel celebre Canto di Natale di Dickens. Nella generale e progressiva provincializzazione di Bologna, ciò che Bartleby si ritrova suo malgrado a rappresentare è decisamente fuori misura rispetto ai meriti o demeriti effettivi di quell’esperienza. Il piano metaforico è assai più ampio delle dimensioni o aspirazioni reali di ogni parte in causa.
Eppure, proprio per questo, la querelle è dirimente. Si tratta di capire se – fatto salvo l’attrito fisiologico con lo status quo – una certa “scena” bolognese, che in altre decadi ha contribuito a fare di questa città un luogo particolare e interessante, potrà continuare ad avere spazio o se invece sarà cancellata, espulsa dal corpo di Bologna. Inutile dire che una parte, piccola o grande, dei destini della città dipende da questo. Cioè dal fatto che si pensi lo spazio urbano come un territorio uniforme e pacificato, in cui ogni conflitto, contraddizione, attrito, viene negato, ricondotto dentro l’alveo del lecito o non lecito, secondo parametri astorici e apolitici. Questa idea della società, che ultimamente traspare dalle parole degli esponenti della maggioranza, della giunta, del sindaco stesso, fa venire in mente certi romanzi di George Orwell o di Aldous Huxley, piuttosto che i racconti di Dickens o Melville. E’ un’idea che, proprio per la sua astrattezza e astoricità, non solo è profondamente di destra (cioè vantaggiosa per i poteri politico-economici costituiti), ma soprattutto finisce per negare alla base – ovvero nascondere – il piano delle scelte politiche.
La storia però è una severa maestra e torna sempre a mordere le chiappe del governante che si pretende ecumenico, tecnico, super partes (come dimostrano anche le recenti vicende nazionali).
In città esistono svariati spazi in disuso di proprietà pubblica e la decisione su cosa farne non potrà che essere politica. In tempi di crisi, con pochi soldi e le aste che vanno deserte, con gli speculatori edilizi in attesa della svendita a prezzi ribassati, l’alternativa può soltanto essere lanciare un concorso di idee, valorizzare il sapere e le competenze diffuse, le reti di relazioni, le esperienze di attivismo dal basso, l’autorganizzazione. Qualcosa che il Comune, messo sotto pressione, annuncia di voler fare a partire dalla mappatura degli spazi dismessi di proprietà pubblica, ma di cui dovrà anche dimostrarsi all’altezza, politicamente parlando, appunto. Perché l’esigenza di nuovi spazi in città non interessa certo soltanto le produzioni culturali, ma pertiene soprattutto al dissesto sociale e all’incalzare dei bisogni primari, mano a mano che la Grande Depressione dilaga.
Questa ultima considerazione ci porta a un terzo aspetto che spinge il caso Bartleby oltre i limiti del problema specifico di un collettivo o di una comunità giovanile. E’ il fattore panico. L’evocazione della violenza di strada a cui abbiamo assistito in questi giorni da parte di giornali e istituzioni – a fronte di qualche manganellata in via San Petronio Vecchio, un paio di slogan, e un’occupazione temporanea, quasi dimostrativa – farebbe solo ridere i polli, se non rivelasse un timore inconscio in chi regge le sorti politico-economiche della città. L’aumento della precarietà esistenziale, della povertà, del disagio, di pari passo all’estendersi della crisi economica, è la grande incognita che incombe sui destini politici di molti. Si evoca ciò che si teme, come una minaccia annidata nelle feroci dinamiche sociali in corso, alle quali si sa di non avere risposte da dare. In un certo senso quasi ci si meraviglia che ancora non ci sia una canea urlante con i forconi sotto i palazzi del potere. Si resta in attesa, sbirciando da dietro le tende, e appena vola uno slogan, o un pomodoro, si grida alla violenza. Che fa rima con cattiva coscienza.
Lo scrivano protagonista di un racconto che è un vero e proprio gioiello letterario, è colui che caparbiamente rimane, che non se ne va, nonostante tutto, e che afferma la sua presenza non già per imposizione, ma per sottrazione al comando, alla routine, ai ritmi della vita economica, e lo fa con un condizionale di cortesia: “Preferirei di no”. In questo modo ci mette di fronte all’irriducibilità del reale ai parametri rassicuranti in cui vorremmo racchiuderlo.
«Più di qualsiasi altro personaggio apparso all’orizzonte dei racconti moderni, Bartleby ci fa sentire il carattere incondizionato d’uno stato di presenza», scrive Gianni Celati. Heretostay dicono quelli con la stessa stolida pazienza, mentre giornali, politici, partiti, baroni universitari, abbaiano, sfottono, insultano, minacciano, e intanto dispensano lezioni di bon ton, correttezza e democrazia.
«Il secondo giorno una vela si avvicinò, si avvicinò di più, e finalmente mi raccolse. Era la ‘Rachele’ che incrociava fuori rotta, la quale, ritornando sui suoi passi alla ricerca di un figlio perduto, trovò soltanto un altro orfano».
H. Melville, Moby Dick
Questo post è stato pubblicato su Giap della Wu Ming Foundation l’8 febbraio 2013