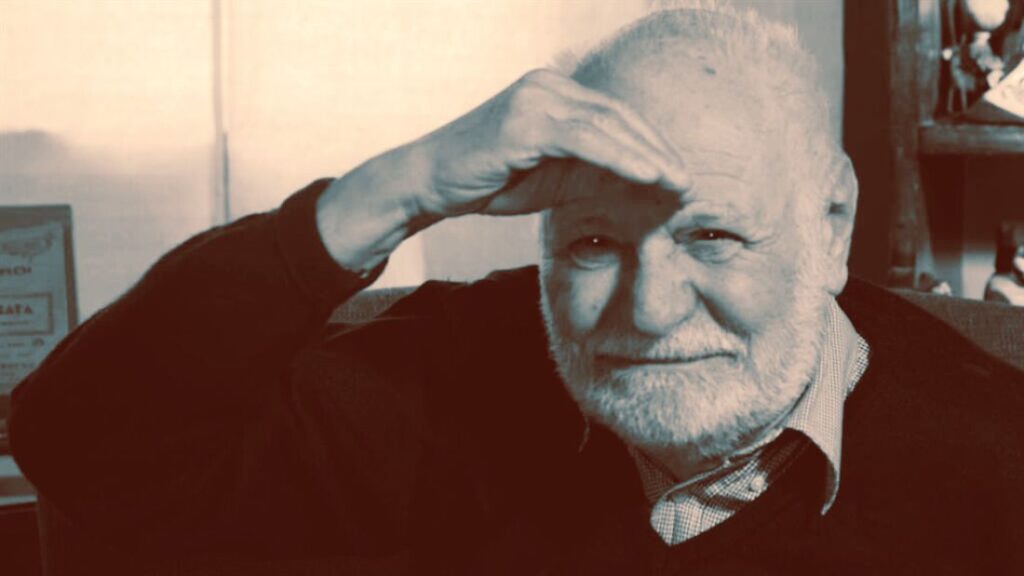In questi giorni di orrore sono venute alla luce pericolose equivalenze, sillogismi, pars pro toto: tra israeliani ed ebrei, tra palestinesi e Hamas, tra entità in “guerra”, quasi si trattasse di due Stati simmetrici, quando da una parte c’è un’organizzazione terrorista nazionalista e fondamentalista islamica sunnita con un’ala politica e una militare, e dall’altra uno Stato democratico – benché nella propria maggioranza abbia elementi che chiedono una società mono-etnica e suprematista – dotato di uno degli eserciti più potenti al mondo e di un arsenale nucleare. In mezzo, civili violati, massacrati, presi in ostaggio nel raccapricciante pogrom del 7 ottobre; civili dilaniati e chiusi in trappola a Gaza, sotto un diluvio di bombe che dura da ventotto giorni; civili israeliani condotti alla guerra e alla radicalizzazione ideologica da un governo che fa un uso sconsiderato della ferita insanabile della Shoah.
Il 17 ottobre, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiamato i miliziani di Hamas “i nuovi nazisti”; il 24 ottobre ha paragonato ad Anna Frank i bambini ebrei nascosti nelle soffitte per salvarsi dai terroristi; lo stesso giorno, ha accostato l’eccidio del 7 ottobre al massacro di Babij Yar attuato nel 1941 dalle Einsatzgruppen, le unità operative delle SS addette allo sterminio che, nell’opera di sistematica eliminazione degli ebrei di Kiev, convocarono con l’inganno 33.771 uomini e donne e li costrinsero a scendere in fondo a un burrone, sdraiarsi sui corpi dei già morti e moribondi, ed essere lì fucilati.
La “nazificazione” degli oppositori, o la reductio ad Hitlerum, per usare l’espressione coniata negli anni Cinquanta dal filosofo politico Leo Strauss, ebreo tedesco fuggito dalla Germania nazista nel 1938, è una strategia simbolica abusata da decenni per squalificare l’avversario.
Ma se la predicazione di Hamas è pervasa da un’intensa disumanizzazione degli ebrei, proprio per questo non dovrebbe trovare riscontro in parole come quelle pronunciate il 9 ottobre dal ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant: «Stiamo combattendo contro animali umani e agiremo di conseguenza», o il 10 ottobre dal generale Ghassan Alian, capo del Coordinamento delle attività governative israeliane nei Territori: «Gli animali umani devono essere trattati come tali. Non ci sarà elettricità né acqua, ci sarà solo distruzione. Volevate l’inferno, avrete l’inferno». Nel 2018, il Museo Memoriale dell’Olocausto di Washington aveva pubblicato un kit educativo dal titolo Perché le analogie con l’Olocausto sono dannose, in cui la storica Edna Friedberg scriveva, riferendosi alla situazione negli Stati Uniti: «Analogie incaute con l’Olocausto possono demonizzare, avvilire e intimidire i loro bersagli, ma hanno un costo per tutti noi, perché distraggono dai problemi reali che sfidano la nostra società, perché chiudono un discorso produttivo e ponderato. In un momento in cui il nostro Paese ha più che mai bisogno di dialogo, è particolarmente pericoloso sfruttare la memoria dell’Olocausto come arma retorica. Dobbiamo ai sopravvissuti molto di più. E lo dobbiamo anche a noi stessi».
Il rischio è che, nel tempo, l’invocazione dell’Olocausto diventi «l’Iron dome ideologico di Israele, lo scudo contro qualsiasi critica alla sua condotta», come ha affermato lo scrittore Adam Shatz sull’ultimo numero della “London Review of Books”.
Dopo che, lo scorso 31 ottobre, l’ambasciatore di Israele all’Onu Gilad Erdan si è appuntato una stella gialla al petto accusando il Consiglio di Sicurezza per la mancata risoluzione di esplicita condanna degli attacchi di Hamas, Dani Dayan, presidente dello Yad Vashem, ha condannato il gesto perché «disonora le vittime dell’Olocausto e lo Stato di Israele. La stella gialla simboleggia l’impotenza del popolo ebraico, alla mercé di altri. Oggi abbiamo un Paese indipendente e un esercito forte. Siamo padroni del nostro destino».
Del resto, lo stesso vice primo ministro di Israele Naftali Bennett – che lo scorso 12 ottobre ha dichiarato, riferendosi all’operazione militare nella Striscia di Gaza, che «è necessario schiacciare questi nazisti con una potenza di fuoco mai vista prima» – poco più di un anno fa, il 22 marzo 2022, si era espresso in modo diverso a proposito del paragone con cui Volodymyr Zelensky aveva inteso stigmatizzare l’invasione russa paragonandola alla Soluzione finale: «Personalmente credo che la Shoah non debba essere comparata a nulla. È un evento unico nella storia delle nazioni e del mondo: la sistematica distruzione di un popolo nelle camere a gas». La propensione a utilizzare la Shoah come sinonimo di eccidio e strage, a renderla insulto, accusa, anatema, paradigma che pretende di illuminare conflitti, atti di terrorismo e guerre, indebolisce la consapevolezza del genocidio categoriale, sistematico, industriale, che ha segnato per sempre il precipizio della cultura europea. Se questo corto circuito si può comprendere in Israele dove, secondo il Central Bureau of Statistics, vivono circa 165.000 sopravvissuti all’Olocausto, di cui 5.000 nella zona ora evacuata vicino a Gaza, e dove si sono inevitabilmente ridestate le memorie individuali e collettive delle persecuzioni subite dagli ebrei nel corso della storia, molto meno si può capire in Italia, dove diversi quotidiani, da giorni, evocano le Einsatzgruppen, la Notte dei Cristalli, il rastrellamento nazifascista del Ghetto di Roma per giustificare la necessità della distruzione di Gaza come risposta.
Nel Paese che ha collaborato attivamente con il nazismo senza mai affrontare le proprie responsabilità e dove oggi si intitolano vie a Giorgio Almirante, segretario di redazione della rivista “La difesa della razza” tra il 1938 e il 1943, si incita allo scontro, si irride chi chiede mediazioni di pace, si abbraccia un governo di estrema destra che in Israele in molti hanno cercato di far cadere, si inculca l’equazione per cui chi è contrario all’azione indiscriminata delle Forze di difesa israeliane è antisemita. Ma se è vero che l’antisemitismo, come il negazionismo, è un’idra le cui teste sono sempre pronte a riemergere – come dimostrano i vergognosi episodi delle stelle di David apparse sui muri di Parigi, la profanazione del cimitero ebraico di Vienna, la vandalizzazione delle pietre d’inciampo – è altrettanto vero che non si può liquidare come antisemitismo la richiesta di una risposta proporzionata, di pause umanitarie, di un cessate il fuoco che giunga il prima possibile. Né può essere tacciata di essere antisemita la critica a un governo che, brandendo la retorica del bene contro il male, ha sigillato ogni valico, messo in stato d’assedio più di due milioni di cittadini, tagliato le forniture di elettricità, acqua, cibo e medicinali – mentre l’annuncio di una risposta terribile e sempre imminente derubricava quello che accadeva a semplice prologo e trattenimento della forza, con il risultato che nei soli primi sei giorni di attacchi aerei, l’Idf ha sganciato più di seimila bombe. Il bilancio al ventinovesimo giorno dalla strage di Hamas è immane: 9.227 palestinesi morti, 2.100 dispersi, 23.000 feriti, un milione e 400mila persone ridotte a sfollati interni in fuga sotto i bombardamenti, in cerca di ripari inesistenti, costrette a vivere fra le immondizie, a bere acqua contaminata, private della possibilità di ritrovare i corpi dei propri cari sotto le macerie. Quattrocento bambini uccisi o feriti ogni giorno, secondo l’Unicef, in attacchi indiscriminati che non hanno fatto distinzione tra obiettivi civili e militari.
Il 15 ottobre, ottocento accademici di diritto internazionale e studiosi dei conflitti e del genocidio hanno sottoscritto una lettera aperta per «lanciare l’allarme sulla possibilità che le forze israeliane perpetrino il crimine di genocidio contro i palestinesi della Striscia di Gaza», e il 2 novembre un gruppo di settecentoventi accademici, scrittori, artisti e attivisti ebrei, tra cui lo storico Omer Bartov, tra i maggiori studiosi dell’Olocausto, hanno redatto un appello in cui si afferma: «Nel nostro dolore, siamo inorriditi nel vedere la lotta all’antisemitismo usata come pretesto per crimini di guerra con dichiarato intento genocida. Le nostre famiglie sono sfuggite a guerre, vessazioni, pogrom e campi di concentramento. Abbiamo studiato la lunga storia di persecuzioni e violenze contro gli ebrei e prendiamo sul serio il continuo antisemitismo che mette a rischio la sicurezza degli ebrei in tutto il mondo. Crediamo infatti che i diritti degli ebrei e dei palestinesi vadano di pari passo. La sicurezza di ciascun popolo dipende da quella dell’altro».
La Shoah ha costituito un abisso etico e politico che ci chiama in causa tutti, ma «la tragedia di Auschwitz non è avvenuta in uno spazio vuoto, bensì nei limiti della cultura e della civiltà occidentale, e questa civiltà è una sopravvissuta», come ha affermato lo scrittore ungherese Imre Kertész, internato ad Auschwitz e Buchenwald. Una cultura, una civiltà che abbiamo tentato di ricostruire sulle ceneri della Seconda guerra mondiale, dotandoci di una Dichiarazione universale dei diritti umani, di un diritto internazionale umanitario, di una base giuridica per agenzie e istituzioni che, come le Nazioni Unite, per quanto criticabili e fragili, rappresentano ciò che ci separa dall’arbitrio dei nazionalismi e dalla volontà di vendetta o di potenza degli Stati, a protezione della persona in tempo di pace e in tempo di guerra. È ad essa che dobbiamo affidarci, nella volontà di arginare le fratture, non di farle deflagrare.
Questo articolo è stato pubblicato su La Stampa il 4 novembre 2023