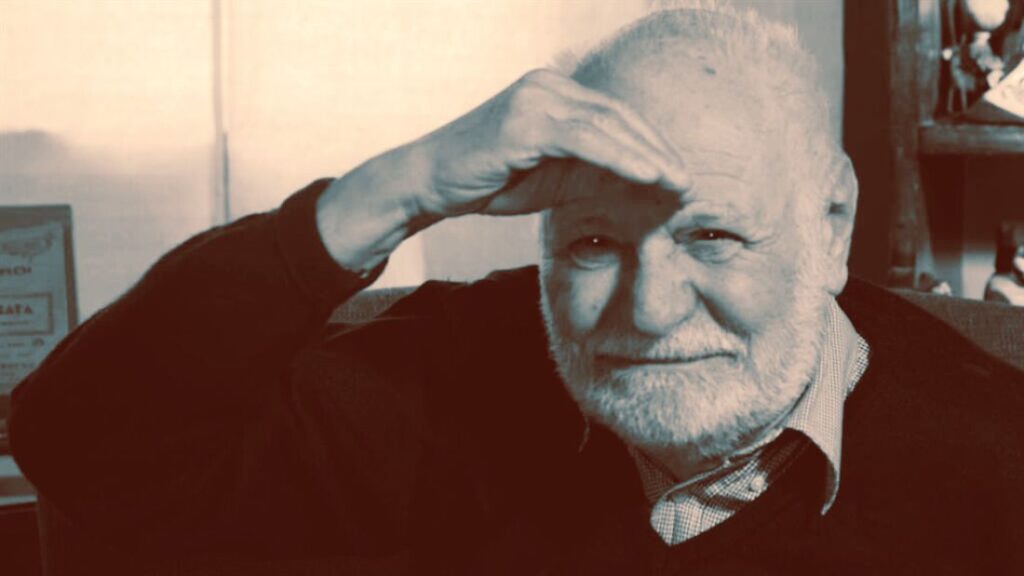L’alta velocità ha spostato milioni di viaggiatori dagli aerei ai treni, ma il trasporto locale langue. E se il sud è tagliato fuori dalla Tav le ragioni affondano nelle scelte a cavallo dell’Unità d’Italia. Tra connessioni e tangenti, ecco la storia e il perché da 160 anni le ferrovie restano una grande opera incompiuta.
Nel 1861 l’Italia era una nazione senza una rete ferroviaria adeguata alle grandi ambizioni del giovane Stato. La distanza con le altre nazioni europee, anche in questo campo, era notevole. I binari in funzione superavano di poco i 2500 chilometri (per la precisione 2523, secondo i dati ricostruiti dall’Istat). Alla stessa data nei territori che poi nel 1870 daranno formalmente vita alla Germania ne erano in funzione già 11.000, in Francia poco più di 9000, e in Inghilterra si era arrivati già a ben 14.000 chilometri. Il Piemonte possedeva la rete più estesa, ma si trattava di appena 850 chilometri, poi veniva il Lombardo-Veneto (non tutto annesso all’Italia in quell’epoca) con 610 chilometri, il Granducato di Toscana con 332, mentre nel Regno delle Due Sicilie erano in funzione appena 140 chilometri di binari, e 100 nello Stato pontificio. La dotazione preunitaria di binari, dunque, era concentrata per due terzi nel nord, anche se in Piemonte fino al 1848 non esisteva un solo binario attivo; furono poi le esigenze militari e il grande impulso dato da Cavour che cambiarono radicalmente la situazione, facendo del regno sabaudo l’avanguardia di questa nuova potente e rivoluzionaria infrastruttura.
Anche la dotazione della rete viaria era nettamente più estesa nel centro-nord con 75.000 chilometri di strade, mentre nel meridione e nelle isole invece si arrivava ad appena 14.700 chilometri. Nel 1861 ben 1431 comuni del sud peninsulare (su 1828) erano privi di strade carrozzabili, mentre in Sicilia ne erano privi 182 su 358. Ma se nel campo delle infrastrutture ferroviarie e viarie la differenza tra centro-nord e sud era notevole, nel campo marittimo il divario si ribaltava. Il regno meridionale mantenne per alcuni decenni dopo l’unità d’Italia un primato nella marineria a vela e motore, di cui la famiglia Florio in Sicilia era la più avanzata espressione. E va ricordato che la prima nave a vapore nel Mediterraneo fu prodotta sotto i Borbone.
E anche la prima ferrovia sul suolo italiano era stata inaugurata proprio nel Regno delle Due Sicilie nel 1839, la Napoli-Portici (poco più di 7 chilometri a doppio binario) che si estenderà negli anni successivi fino a toccare Salerno alla vigilia dell’Unità, ma resterà praticamente quasi l’unica esistente se si esclude un tentativo di arrivare ai confini dello Stato pontificio arrestatosi a Capua. La linea Milano-Monza di 12 chilometri fu terminata nel 1840. E cosa ancora più significativa è il fatto che la prima officina di produzione di locomotive nacque nel 1848 proprio vicino Napoli, a Pietrarsa (dove oggi c’è un bel museo delle Ferrovie dello Stato) mentre nel nord si dovrà aspettare il 1853 per la nascita a Genova dell’Ansaldo, che le produrrà negli anni successivi. Ma, nonostante questi primi successi, nel 1861 non esisteva un solo binario costruito in Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise. D’altronde anche in Sardegna, sotto il regno sabaudo, erano del tutto sconosciute le ferrovie. Solo nel 1863 si inaugurerà la Palermo-Bagheria e nel 1871 la Messina-Catania-Siracusa. E solo nel 1895 da Napoli si potrà arrivare a Reggio Calabria. Mentre il ponte sulla laguna, che permise il raggiungimento di Venezia in treno, venne realizzato nel 1846, e i valichi alpini furono scavati in pochi decenni: il traforo del Frejus, che permise il collegamento con la Francia, fu completato nel 1871; il traforo del Gottardo nel 1882; e nel 1905 si aprì quello del Sempione (con la galleria più lunga al mondo, ben 19,8 chilometri, primato detenuto fino al 1979) che collegava con la Svizzera e con la valle del Rodano. Ma ancora oggi si discute accanitamente sulla utilità del ponte sullo stretto di Messina e ci vogliono ancora 20 ore da Milano per arrivare a Palermo con un intercity, il tempo più lungo in Europa per collegare due città storiche della stessa nazione.
Nella pianura padana, dunque, esisteva un’ossatura ferroviaria, nel sud era invece quasi inesistente, esclusa un’area di 50 chilometri attorno a Napoli. Nel nord furono le esigenze militari e la necessità di collegarsi con il mare a spingere da un lato Cavour e dall’altro l’impero austro-ungarico e il Granduca di Toscana a puntare sulla rete ferroviaria: la Firenze-Livorno (detta “la Leopolda”) fu completata nel 1848, la Torino-Genova nel 1853 e il collegamento di Vienna con Trieste nel 1857. Ma in Piemonte il conte Benso fu guidato anche da una grande ammirazione per l’Inghilterra, all’avanguardia nella costruzione delle ferrovie, che si esprimerà compiutamente in questa lettera: “In Inghilterra non esistono più distanze. Le comunicazioni anche tra città lontane, come Londra e Liverpool, sono diventate più facili che tra quartieri diversi della stessa città. La posta parte da Londra due volte al giorno per quasi tutte le direzioni”. Nello Stato pontificio, invece, il papa Gregorio XVI aveva definito il treno uno strumento del diavolo e ciò aveva rallentato la realizzazione di ferrovie ampiamente progettate e ideate da tecnici di valore.
Nel Regno delle Due Sicilie, dopo la fase di avanguardia nella costruzione della rete e delle locomotive, non ci fu né la spinta militare (i Borbone non avevano mire espansionistiche verso lo Stato pontificio confinante) né quella commerciale in quanto il traffico via mare continuava ad essere preferito in un territorio bagnato da tre mari e con un primato tra tutti gli Stati preunitari nel trasporto marittimo, come abbiamo visto.
D’altra parte, la frammentazione in ben sette Stati preunitari e le condizioni fisiche del territorio italiano erano stati i principali ostacoli alla costruzione di una adeguata e razionale rete ferroviaria al pari di quelle delle altre grandi nazioni europee. Sia l’asse verticale sia quello orizzontale erano limitati dai confini ravvicinati tra i diversi piccoli Stati, e quindi la progettazione risentì del fatto che non si aveva a completa disposizione un esteso spazio territoriale per tracciare linee ferroviarie lungo l’asse nord- sud e ovest-est, il più adeguato a una nazione lunga e stretta come l’Italia.
Considerando la carta ferroviaria italiana alla fine del 1860, questo limite politico è del tutto evidente: le ferrovie lombarde erano allacciate con quelle piemontesi soltanto al ponte sul Ticino nei pressi di Magenta, mentre non vi erano contatti con l’Emilia e la Romagna. Da Torino si arrivava sì a Venezia e a Bologna, ma non a Firenze; Firenze a sua volta non era collegata con Roma, mentre Roma non aveva raccordi con Napoli. La stessa conformazione orografica della nuova nazione (fatta per il 35,2% di montagne, per il 41,6% di colline e solo del 23,2% di pianure) presentava ostacoli che sembravano insormontabili date le conoscenze tecniche dell’epoca. Con sole due grandi pianure, quella Padana e il Tavoliere delle Puglie, le Alpi alla frontiera con la Francia e al confine con le altre nazioni dell’Europa centrale, con la catena appenninica che per secoli aveva rappresentato un ostacolo nelle relazioni tra la parte adriatica e tirrenica, con fiumi dal corso impetuoso e due grandi isole, la progettazione e la realizzazione di un sistema ferroviario non era una cosa semplice. Se si guarda alla distanza tra le parti poste agli estremi delle principali nazioni europee, l’Italia è la nazione più lunga tra quelle mediterranee e centrali. Infatti, essa si estende per più di 1400 chilometri (e si allarga per 600 in pianura padana, ed è più stretta nel centro, arrivando in Calabria e nel Salento a poco più di 30 chilometri di distanza d tra due mari), mentre la Spagna è lunga 850 chilometri, la Francia 1000 (esclusa la Corsica, naturalmente), l’Inghilterra 900, e la Germania si estende per 866 chilometri da nord a sud. Per andare da Milano a Punta Secca all’estremità della Sicilia la distanza è di 1458 chilometri; dal Monte Bianco agli estremi della penisola salentina in linea d’aria si superano i 1100 chilometri.
Perciò lo sviluppo delle ferrovie in Italia venne percepito dal mondo politico risorgimentale come una spinta non solo a superare le frontiere tra gli staterelli preunitari in cui era divisa la penisola, ma in prospettiva ad essere uno dei principali mezzi per «fare gli Italiani». Uno strumento cioè di integrazione nazionale. Nella visione di Cavour le ferrovie avevano lo stesso valore delle vie consolari per la costruzione dell’Impero romano: strumento fondamentale per superare le barriere tra i popoli e per rendere più corta una nazione lunga geograficamente. L’Italia che era venuta fuori nel 1861 (al di là delle previsioni dello statista piemontese, che pensava ancora nel 1858 a una federazione di Stati settentrionali e centrali escluso il Regno delle Due Sicilie) andava da Milano a Palermo, da Torino a Lecce e le ferrovie erano, oltre all’esercito, il mezzo più importante per incontrarsi e conoscersi tra italiani separati da secoli di domini locali e stranieri.
Per tutti questi motivi la relazione al primo disegno di legge del nuovo stato unitario nel 1861 sulle ferrovie parlava della “suprema necessità della nazione di ravvicinare fra loro quanto prima si possa le varie province”. La commissione della Camera dei deputati, discutendo proprio della costruzione delle ferrovie calabro-sicule, notava che occorreva costruirle “per fare atto di giustizia distributiva nel novello consorzio delle province italiane, e per correggere rapidamente i vizi della storia e quelli della geografia”.
I vizi della storia e quelli della geografia sono stati del tutto superati dopo 160 anni di storia unitaria dell’Italia? Guardando la dotazione di binari nel 1861 e oggi una carta dell’Alta velocità, non si può non notare che l’Italia ferroviaria, se prima dell’unificazione era una nazione a metà, nel 2021 sembra essere una “nazione di tre quarti”. Certo, sono del tutto evidenti i cambiamenti epocali in tanti settori, compreso quello delle dotazioni ferroviarie, ma il problema di legare nel modo più appropriato e veloce gli estremi di un paese lungo è ancora non risolto. E per tanti versi, e in tanti settori, sembrano del tutto appropriate le parole del grande storico Gioacchino Volpe che definiva il sud “il socio di minoranza” della nuova nazione che si era costruita.
Uno Stato infatti deve provare a correggere i vizi della storia (cioè quelli dei piccoli stati precedenti e poi dei limiti dei governi locali) e i vizi della geografia (cioè superare gli ostacoli che impediscono di portare i binari in collina o in montagna, di attraversarli con gallerie o di superare l’ostacolo dei fiumi e del mare). Se il Sud non è fatto di grandi pianure, non vuol dire che deve essere per forza un’impresa (ancora oggi) arrivare con il treno a Matera, a Reggio Calabria o in Sicilia, o passare dal Tirreno all’Adriatico in tempi ragionevoli, come nel caso dei non collegamenti tra Puglia, Campania e Calabria, o tra Abruzzo, Molise e le città del Tirreno.
E quindi lo scopo delle ferrovie di rendere quanto più vicine Milano, Reggio Calabria, Lecce o Palermo, cioè le punte estreme della penisola e della nazione, non è stata raggiunta fino in fondo. Ci sono alcuni tratti tra le città italiane più importanti della sua storia che si percorrono con meno tempo in auto che in treno (Milano- Palermo, Napoli-Bari) mentre in quasi tutte le altre grandi città si arriva prima viaggiando in vagoni all’avanguardia e a velocità sostenute. In Francia si va con l’alta velocità da Lille a Marsiglia e in Spagna da Barcellona a Siviglia, mentre in Italia i vagoni veloci si fermano a Salerno.
Lo sbilanciamento della rete ferroviaria italiana rappresenterà una delle costanti più inattaccabili della storia italiana, nonostante i grandissimi cambiamenti intervenuti nel settore da allora in poi fino alla rete dell’Alta velocità di oggi. Una costante che ha attraversato tutte le diverse epoche politiche, compreso il periodo fascista, e ha riguardato anche le notevoli innovazioni tecniche che comunque le ferrovie hanno apportato al bagaglio culturale, tecnico, scientifico ed economico della nazione. Basti pensare che il fascismo investì molto sull’elettrificazione della rete ferroviaria, ma partì anch’esso dalle grandi direttrici settentrionali, così che nel 1930 la dotazione di ferrovie a scartamento ordinario ed elettrificate, in termini di chilometri per superficie, era al Sud solo il 14% della media nazionale, come riportato nel documentatissimo libro di Gianfranco Viesti, Centri e periferie. Europa, Italia, Mezzogiorno dal XX al XXI secolo (Laterza, 2021). Se si analizzano, poi, gli investimenti nel periodo 2005-2018 dei grandi gruppi industriali e dei servizi a presenza pubblica, le Ferrovie hanno la media più bassa; nel sud hanno speso solo il 22% rispetto a un territorio che rappresenta il 40% di quello nazionale e dove vi abita il 36% della popolazione, mentre l’Eni vi ha investito il 38,8%, le Poste il 33,1%, l’Enel il 33,4%, Terna il 47% e l’Anas ben il 59,1% (vi hanno inciso enormemente gli investimenti per l’ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria). La dotazione di autostrade, a partire dalla costruzione dell’Autostrada del Sole e poi il suo prolungamento fino a Reggio Calabria è stata più equa di quella ferroviaria! L’auto ha reso meno corta l’Italia di quanto abbiano fatto le ferrovie! Dispiace ammetterlo, ma i dati avvalorano questa constatazione.
Dopo il 1861 la questione ferroviaria venne affrontata in due modi diversi: come problema essenzialmente politico (avvicinare al più presto l’Italia e gli italiani) e come problema economico (costruire attraverso i binari un mercato nazionale, abbassare i costi per spostare le merci e rifornirsi di materia prima, creare le condizioni per buoni investimenti per il capitale proveniente dalla rendita agraria). È indubbio che se prima della costruzione della nazione prevalsero intenti politici, immediatamente dopo dominarono quelli economico-finanziari. Le ferrovie ne saranno la più evidente dimostrazione. A tale proposito Francesco Mercurio sulla rivista Meridiana ha scritto cose interessantissime. Cavour aveva costruito un sistema ferroviario invidiabile in Piemonte puntando in gran parte sugli investimenti dello Stato e contenendo le ambizioni e gli interessi del capitale privato in questo settore. Prevaleva nella classe dirigente piemontese l’idea che le ferrovie rappresentassero un servizio pubblico piuttosto che una attività “industriale” sottoposta perciò ad altri criteri di valutazione sulla redditività degli investimenti; mentre in altri Stati preunitari il capitale privato era dominante, con l’uso delle concessioni a imprenditori in gran parte provenienti dal mondo finanziario (italiano e soprattutto estero) che obbedivano ad altri criteri piuttosto che a quelli di rendere una nazione effettivamente unita nel sistema dei trasporti. E sarà interessante verificare come la classe dirigente liberale (che per semplificare identifichiamo nella Destra storica) alla fine sosterrà che nel settore debbono essere gli interessi pubblici a prevalere su quelli privati, mentre la cosiddetta Sinistra storica sosterrà, contrariamente ai valori declamati, gli interessi dei concessionari. E sarà proprio il dibattito e la votazione sulle concessioni ferroviarie a determinare la prima grande rivoluzione parlamentare nel 1876, facendo cadere il governo della Destra storica (che aveva dominato i primi 15 anni della storia politica unitaria) e portando alla guida della nazione Agostino Depretis, capo della Sinistra, con il sostegno dei voti in parlamento dei concessionari delle linee ferroviarie. Insomma, fu la gestione delle ferrovie a dare vita a quel trasformismo che ha caratterizzato e dominato le vicende politiche italiane fino ai giorni nostri. Il termine prende spunto proprio dalle parole di Agostino Depretis, che in un discorso nel suo collegio elettorale a Stradella ebbe a dire in risposta a coloro che criticavano gli accordi da lui stipulati con la destra del Minghetti e lo accusavano di aver così snaturato il programma della sinistra: “Se qualcheduno vuole entrare nelle nostre file, se vuole accettare il mio modesto programma, se vuole trasformarsi e diventare progressista, come posso io respingerlo?” Fu così che la parola trasformismo divenne la caratteristica di un’epoca politica. E le concessioni ferroviarie furono la prima applicazione di quel costume politico che è stato una costante della vita politica nazionale.
Il nuovo Stato non aveva le risorse per finanziare gli oltre 6.000 chilometri di ferrovie che si ritenevano indispensabili per lo spostamento delle persone, per avvicinare i luoghi più lontani e per la formazione del mercato nazionale delle merci. Non esisteva un adeguato sistema tributario in grado di finanziare le spese ingenti occorrenti per questo obiettivo, con l’esercito (per il pericolo di una nuova guerra con l’Austria) che assorbiva il 40% del bilancio pubblico. La scelta, dunque, di affidare a privati la costruzione e l’esercizio delle nuove linee ferroviarie, così come avveniva in altre grandi nazioni europee (nelle quali i costruttori delle linee si rifacevano delle spese con gli incassi dei biglietti), fu ritenuta obbligata e approvata senza sostanziali contrasti, non potendo il bilancio del nuovo Stato farsi carico della spesa prevista di un miliardo e mezzo di lire (cioè 150 milioni all’anno in dieci anni). Ma per il sud si sarebbe trovato un gruppo finanziario in grado di accollarsi la spesa e il rischio, viste le condizioni orografiche e la diffusione del brigantaggio in molte aree da attraversare? I Borbone a fine agosto del 1860 (poco prima che l’ultimo rappresentante della dinastia, Francesco II, lasciasse la capitale del suo Regno in vista dell’arrivo di Garibaldi) avevano stipulato una convenzione con un ingegnere francese, Paolino Talabot (uomo di fiducia dei Rothschild), per la realizzazione di una linea ferroviaria sul Tirreno inferiore e un’altra che portasse da Napoli all’Adriatico. Ma un mese dopo l’arrivò in città di Garibaldi (proveniente in treno da Salerno), l’accordo fu revocato e a ricevere la concessione furono due cognati banchieri livornesi, Pietro Antonio Adami e Adriano Lemmi, sponsorizzati presso Garibaldi anche da Francesco Crispi, Agostino Bertani (per il quale ci fu l’accusa di un giornale torinese di aver incassato soldi per l’operazione) e Carlo Cattaneo. Chi erano i prescelti? Entrambi erano repubblicani e appartenenti al Partito d’azione, entrambi avevano sostenuto e finanziato la spedizione dei Mille; Lemmi, che diventerà poi gran maestro della Massoneria, aveva conosciuto Mazzini a Londra e gli era stato vicino durante il periodo della Repubblica romana finanziando poi la spedizione di Sapri di Carlo Pisacane. Alla società dei due banchieri «democratici» (Società italica meridionale) fu, dunque, affidata la costruzione e la concessione delle ferrovie del sud, comprese quelle da costruire in Sicilia, con un contratto scritto da Cattaneo. In una lettera a Francesco Crispi, Giuseppe Mazzini gli chiede di sponsorizzare calorosamente presso Garibaldi l’appalto alla società dei due banchieri toscani, politicamente vicini, e sull’affidabilità di Lemmi così scrive: «Il portatore della presente, Adriano Lemmi, è nostro buonissimo amico da vent’anni e fece considerevoli sacrifici per la Causa. Ei viene a trattare cosa importante concernente la concessione per le vie ferrate. Uditelo, vi prego: spiegherà, egli, ogni cosa. Io soltanto vi dico, che, mentre altri farebbe suo prò di ogni impresa, egli mira a fondare la Cassa del partito e non la sua». L’identificazione degli interessi del proprio partito con gli interessi della nazione e dello Stato sembra trovare qui una prima teorizzazione nella storia italiana. Si tratta di una lettera di raccomandazione, ma in essa si suggerisce di preferire quel particolare imprenditore perché il raccomandato poi verserebbe una parte del suo profitto per la causa comune. Certo, siamo in un periodo storico in cui il fondatore della Giovane Italia è formalmente un fuorilegge e un ricercato, anche per il nuovo Stato che ha contribuito a suo modo a formare, e sicuramente la causa che persegue, l’instaurazione della Repubblica, ha motivazioni ideali ben diverse da tanti che nella storia d’Italia le useranno solo per giustificare le tangenti effettivamente prese. Ed è un periodo storico in cui non esistevano regole precise nell’attribuzione di appalti, tranne che valutare il maggior interesse pubblico tra varie proposte che arrivavano alle autorità che dovevano assumere una decisione.
Nel frattempo, Giuseppe La Farina scrive preoccupato a Cavour che la compagnia Adami ha già comprato quattro giornali napoletani e si appresta a fondarne due nuovi, facendo intendere che se il banchiere livornese si preoccupa di trovare consenso nell’opinione pubblica alla concessione ferroviaria data alla sua società, è bene preoccuparsi per questa espansione dei repubblicani tramite opportunità formalmente offerte da chi rappresenta il re Vittorio Emanuele II.
Cavour, appena dopo l’annessione del Mezzogiorno al nuovo Stato e alla fine della dittatura di Garibaldi, non riconobbe la convenzione con la società di Adami e Lemmi. E riprese le trattative con il francese Talabot che già aveva trattato con l’ultimo re borbonico. Il capo del governo non voleva fornire un ulteriore vantaggio ai suoi nemici repubblicani e aveva interesse a favorire la finanza francese che aveva dato una mano a realizzare l’Unità d’Italia. All’ingegnere e uomo d’affari francese Talabot furono assegnate la costruzione e la concessione delle linee da Ancona a Otranto, da Napoli a Foggia e da Ceprano a Pescara, mentre furono lasciate alla coppia Adami-Lemmi solo le ferrovie calabro-siciliane. Ma Talabot, dopo un tentativo di far cambiare alcune clausole della concessione, si tirò indietro e così il governo fu costretto a cercare un’altra soluzione. La trovò affidandosi direttamente al gruppo Rothschild di Parigi e presentò in Parlamento la nuova proposta di concessione stipulata il 15 giugno 1862. A una commissione parlamentare fu assegnato il compito di riferire in aula dopo un’attenta valutazione dell’atto stipulato dal governo. Presidente e segretario della commissione furono nominati due lombardi, rispettivamente Ambrogio Trezzi e Guido Susani. La commissione concluse i lavori il 31 luglio con un parere negativo in nome di un orgoglioso spirito nazionale: non concedere al capitale francese (che già controllava la Società delle ferrovie lombarde e dell’Italia centrale) il controllo delle ferrovie italiane. In realtà, dietro questo spirito patriottico c’erano le pressioni e le tangenti che il conte Pietro Bastogi aveva messo in piedi per indirizzare il Parlamento verso una società italiana da lui guidata. Bastogi era deputato in carica, era stato ministro delle finanze in uno dei primi governi postunitari, e senza imbarazzi per il conflitto di interessi aveva dato vita a una società a esclusivo capitale italiano per candidarsi a gestire la concessione delle ferrovie meridionali. Aveva, a tal fine, inviato una lettera al ministro dei Lavori pubblici che si chiudeva con un richiamo al comune orgoglio che una proposta del genere venisse da capitalisti italiani. Era quello un momento in cui esisteva una fortissima (e ciclica) tensione con la Francia, a proposito dell’ostilità armata dei cugini d’oltralpe all’annessione di Roma per farne la degna capitale del Regno. Sull’onda patriottica antifrancese, la proposta di Bastogi suscitò grande entusiasmo tra i parlamentari e conobbe una rapidità di approvazione incredibile anche per quei tempi. Il relatore, il già citato Ambrogio Trezzi, deputato di Milano, svolse una relazione in Parlamento così sfacciatamente favorevole al Bastogi che il presidente dell’assemblea, Urbano Rattazzi, dovette chiedergli: «Ma lei parla in nome del popolo o come relatore del signor Bastogi?» Il 9 agosto del 1862, la Camera approvò con 195 voti a favore e appena 25 contrari.
Come si era arrivati a cambiare una decisione governativa con un grande gruppo finanziario della potenza dei Rothschild? Con il potere dei soldi distribuiti a man bassa. Intanto, nel primo consiglio di amministrazione della società di Bastogi, eletto nel novembre 1862, c’erano ben 14 deputati su 22 membri e tra essi figuravano il presidente e un commissario della commissione parlamentare che aveva svolto un ruolo fondamentale a favore dell’italianità della concessione ferroviaria, cioè l’onorevole Trezzi e l’onorevole Susani. La cosa aveva molto scosso l’opinione pubblica, poi la controffensiva dei Rothschild e il contrasto tra Bastogi e alcuni azionisti costrinsero il Parlamento a istituire una commissione parlamentare d’inchiesta il 21 maggio 1864. Nonostante la reticenza di parecchi testimoni, la commissione concluse i propri lavori con alcune gravi accuse: il deputato di Sondrio, Guido Susani, aveva ricevuto la somma di 1.100.000 lire da Bastogi. L’onorevole Paolo Sinibaldi, professore al Politecnico, ammise di aver pagato 3 milioni di tangenti a più di trenta deputati per ottenerne il voto favorevole alla società del finanziere toscano. La commissione, inoltre, stigmatizzò la presenza di numerosi parlamentari nel consiglio di amministrazione e chiese al Parlamento di votare una legge sull’incompatibilità tra la carica di deputato e quella di amministratore di imprese finanziate dallo Stato. Ma la legge vide la luce solo nel 1875, undici anni dopo. Cosa ancora più singolare, gli atti della commissione d’inchiesta sparirono dall’archivio segreto della Camera. In seguito all’inchiesta, sei deputati rinunciarono all’incarico parlamentare e solo Susani dovette per sempre abbandonare la vita politica per lo scandalo. Lo stesso Bastogi, per il quale era stata provata l’ampia capacità di corruzione, rimase per anni alla guida della “Società delle Strade ferrate meridionali”, fu più volte rieletto deputato, nominato conte da Vittorio Emanuele II e addirittura senatore su proposta di Francesco Crispi, ruolo che all’epoca veniva riservato agli uomini che avevano particolarmente onorato la nazione con la loro attività. Il primo grande scandalo dell’Italia postunitaria riguardava opere pubbliche da fare al Sud ma coinvolse banchieri toscani e deputati non meridionali.
Non si pensò, quindi, da subito di unire Milano o Torino ai punti estremi del regno, in Calabria e in Sicilia, ma con la concessione a Bastogi lo scopo della costruzione delle ferrovie meridionali fu quello di unire il nord a Napoli superando l’impossibilità di attraversare il territorio di Roma non ancora appartenente alla nuova Italia. L’idea era quella di usare la litoranea adriatica da Ancona fino alla Puglia per poi attraversare Foggia ed Avellino (oltrepassando la catena appenninica con un traforo all’altezza di Conza) e arrivare a Napoli aggirando i territori del Papa in attesa di liberare Roma. Un percorso originale che consentiva di unire l’Adriatico al Tirreno, Torino a Napoli nelle condizioni politiche date. Ma se la costruzione dei binari e delle stazioni fu abbastanza facile e veloce da Ancona a Brindisi, non era conveniente per la società concessionaria attraversare gli Appennini: i costi erano alti, i territori montani impervi e i potenziali utenti scarsi tra la popolazione delle aree interne della Campania, all’epoca in condizioni assai arretrate. E così Bastogi ottenne che il percorso alternativo venisse abbandonato. La conquista di Roma nel 1870 contribuì notevolmente a favorire il l’ipotesi più naturale di raggiungere Napoli da Torino attraverso la linea tirrenica o attraverso quelle che saranno poi le due direttissime nella storia delle ferrovie italiane, cioè la Firenze-Roma e la Roma-Napoli. E così, sulla base dei calcoli e degli interessi del concessionario, si rinunciò a formare un vero e proprio ponte ferroviario tra l’Adriatico e il Tirreno che avrebbe superato i limiti storici della visione dei Borbone e avrebbe rotto l’isolamento dell’Appennino meridionale già all’indomani dell’Italia unita, mettendo in comunicazione diretta le Marche, l’Abruzzo e Molise, la Puglia e la Campania. Immaginiamo durante il terremoto del 1980 in Irpinia e Basilicata come diversamente e più rapidamente sarebbero potuti arrivare gli aiuti e i soccorsi se fosse stata in funzione una ferrovia degna di questo nome.
La direttrice adriatica fu costruita prima di quella tirrenica (ed era pronta già nel 1864) non solo per i motivi che prima abbiamo ricordato, ma anche per una strategia di valore internazionale. Era vicina l’apertura del canale di Suez (che avverrà nel 1869) e gli inglesi stavano valutando diverse modalità di trasporto per arrivare più velocemente nei loro possedimenti in India, unendo navi e treno e utilizzando una linea ferroviaria che da Londra e poi da Cascais portasse quanto più vicino a Suez, per poi continuare con altri mezzi fino all’estremo Oriente. Brindisi sembrò il porto più adatto per raggiungere Suez, e in tal senso la società concessionaria accelerò i tempi della costruzione dei binari fino a quella città. Era la prima volta che un porto meridionale veniva inserito in una rotta transoceanica e in un modello internodale di trasporti (la cosiddetta Valigia per le Indie) prima che i cinesi un secolo e mezzo dopo prospettassero la nuova “Via della seta” su cui troppo poco si è discusso in Italia.
Insomma, in quella visione del trasporto ferroviario tutte le aree più lontane del profondo Sud furono escluse dai progetti; il Mezzogiorno d’Italia finiva a Napoli nella considerazione politica dell’epoca. Esigenze economiche, come quelle legate al trasporto dello zolfo dalle aree interne della Sicilia fino alla costa (per abbattere i costi) non furono prese in nessuna considerazione. Lo stretto di Messina restò, più che un ostacolo naturale affrontabile dalle tecniche moderne, un limite invalicabile, e anche la Calabria a suo modo si trasformò in un’isola nella penisola, ancora una volta considerata nei fatti “un estremo lembo” come già lo era stato per i Borbone, mentre le aree interne dell’Appennino meridionale resteranno immobili per quasi un secolo, e fino alle opere volute dalla Cassa del Mezzogiorno relegate a un sostanziale isolamento descritto da Carlo Levi nel potente libro Cristo si è fermato a Eboli. Se lo Stato voleva realizzare le ferrovie nel Mezzogiorno doveva adeguarsi alle convenienze dei concessionari: questo dimostravano i fatti al di là delle strategie enunciate.
Quando finalmente fu decisa la nazionalizzazione delle ferrovie nel 1905 la situazione era abbastanza compromessa e in ogni caso l’idea di subordinare la resa economica delle tratte venne prima di ogni altro interesse. E quando fu varato il progetto dell’Alta velocità (dopo la trasformazione delle Ferrovie dello Stato in Società per azioni nel 1992), il più ambizioso, il più vasto, il più costoso piano di opere pubbliche di epoca contemporanea, la logica non cambierà, purtroppo. Una delle cose più singolari avvenute nel campo delle infrastrutture in Italia è che sono state costruite interamente con i soldi dello Stato, ma la scelta su dove farle è dipesa unicamente dalla resa economica delle tratte. E poiché in Calabria e in Basilicata non c’è una adeguata utenza, non vi si costruisce l’Alta velocità; la si fa invece solo laddove si prevedono più utenti. Così è il mercato a decidere le priorità nelle infrastrutture e non un interesse pubblico più generale. Una particolare modalità tutta italiana di assecondare il mercato con i soldi dello Stato, mentre dovrebbe essere il contrario: condizionare il mercato con le risorse pubbliche. Agendo in questo modo si è creata una “questione meridionale” anche all’interno delle Ferrovie dello Stato, sconvolgendo gli intenti politici e strategici che si manifestarono all’indomani dell’unità d’Italia.
È indubbio che le ferrovie sono state le imprese più innovative apparse sulla scena dell’economia dell’Ottocento. Tale ruolo nell’innovazione tecnica e scientifica si è mantenuta anche nel Novecento, e anche dopo l’invenzione dell’aereo. In Italia questa funzione fu molto evidente e si sperimentò nelle tecniche di perforazione delle gallerie sotto le Alpi e gli Appennini, nella costruzione di locomotive sempre più all’avanguardia (l’invenzione del “pendolino” fu il massimo successo della capacità inventiva in questo campo, come un secolo prima era stata la ferrovia a cremagliera), nella costruzione di ponti arditi, nell’innovazione nella trazione elettrica, ecc. ecc. La scuola ingegneristica italiana deve moltissimo alle ferrovie. Ma le innovazioni hanno riguardato anche i territori attraversati: Lucio Gambi e Italo Insolera hanno sempre ricordato nei loro scritti il ruolo svolto dalle strade ferrate nella definizione del reticolo urbano postunitario e nella ridefinizione del territorio italiano. Indubbiamente le ferrovie hanno creato nuove gerarchie e nuove opportunità insediative, spostando molta popolazione dalle aree interne a quelle provviste di stazioni, consolidando il sistema delle città medie in pianura padana e lungo le direttrici costiere.
Questa funzione di permanente innovazione tecnica ha trovato nella costruzione della rete ad Alta velocità una significativa conferma. Chi vuole approfondire i vari aspetti di tali radicali innovazioni, compresa la costruzione di nuove spettacolari stazioni che hanno richiamato in Italia i più grandi architetti del mondo, può leggere il prezioso libro di Enzo Cascetta, Perché Tav. Risultati, prospettive e rischi di un Progetto Paese ( Il Sole 24 ore, 2019). In particolare, va segnalato il contributo dal punto di vista ambientale: l’Alta velocità, entrata in funzione nel 2008, ha spostato da allora al 2019 ben 10 milioni di passeggeri dall’aereo al treno e comportato una riduzione di otre tre milioni di vetture chilometro all’anno: una straordinaria ricaduta ambientale per il sistema dei trasporti nel nostro paese. Perciò completare la Tav fino a Palermo, andando oltre Salerno e consentendo all’estremo sud di completare il congiungimento con il resto d’Italia, è una “scelta di equità” e una grande opportunità. Così come passare dall’Adriatico al Tirreno attraversando l’Appennino meridionale con tempi veloci di percorrenza, è un altro obiettivo di lungo corso nella storia italiana. Strategie che potevano essere realizzate molto tempo fa, ma che siamo ancora in tempo a rendere operative in tempi brevi. Purtroppo, il trasporto aereo non ha risolto fino in fondo i problemi della distanza e della frequenza dei collegamenti tra aree lontane della penisola e delle isole, almeno della Calabria e della Sicilia. Nel sistema aeroportuale del Sud si sono ricreate le stesse disparità territoriali presenti in altri settori dei trasporti, se si escludono i voli low cost, che però hanno riguardato solo alcune città meridionali.
In conclusione, l’idea dei collegamenti ferroviari nata nel Risorgimento come processo di integrazione della nazione italiana, non si è completamente realizzata. E resta questa ancora oggi una questione aperta. L’alta velocità, che ha prodotto tante innovazioni e ridefinito radicalmente il sistema di spostamenti nel nostro paese, ha finora determinato anche un’alta disparità: un sistema ferroviario di serie B, quello che riguarda i pendolari in ogni parte d’Italia, e il deserto dei binari veloci dopo Salerno.
La realizzazione del Piano nazionale di rinascita e resilienza (PNRR) potrebbe essere l’occasione di chiudere questa pagina negativa, a condizione di non ripetere alcuni errori già fatti nella costruzione della rete ad Alta velocità. Un esperto come Pietro Spirito ha richiamato più volte nei suoi scritti questi pericoli. Per esempio, evitare nella progettazione dell’Alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria percorsi totalmente nuovi e che comporterebbero tempi di realizzazione lunghi; non pensare di far viaggiare sulla stessa rete anche treni addetti al trasporto merci: da Torino a Salerno, passando per Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, finora non si è visto un solo treno-merci transitare. Eppure, per permettere anche il passaggio dei treni merci sulla linea veloce i costi di costruzione sono aumentati di un terzo!
Certo, sono problemi tecnici; sul piano politico è importante riprendere l’idea delle ferrovie come mezzo potente per unire gli italiani. Tutti. Essere figliastri può capitare in una famiglia ma non deve avvenire in una nazione.
Questo articolo è stato pubblicato su Repubblica l’8 agosto 2021