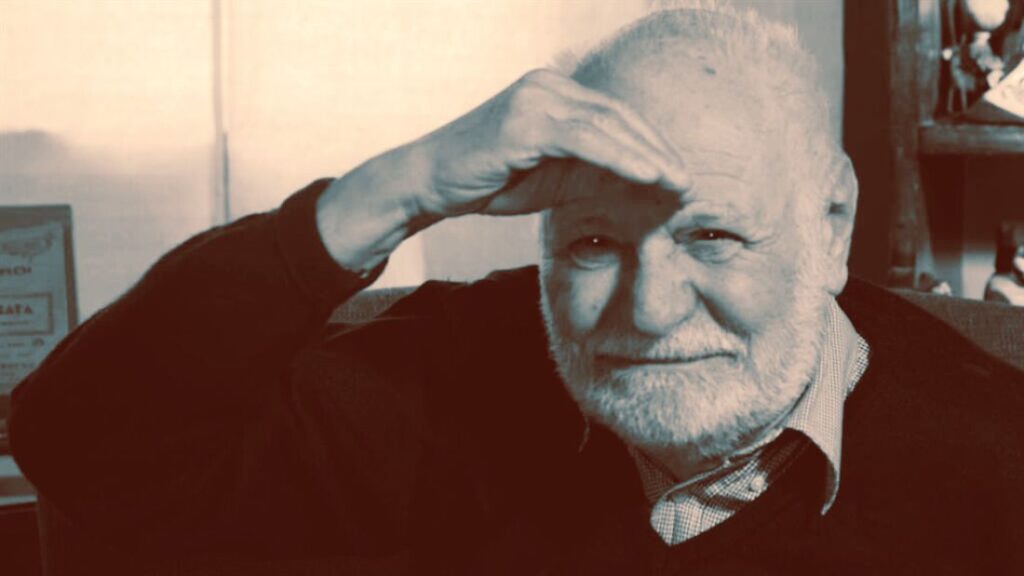Troppa «normalità». Il Documentone di Draghi ignora cos’è la biodiversità, che il consumo di suolo è dannoso, che per adottare nuove tecnologie bisogna gettarne via altre e non perché lo decide il mercato. E si affida ai privati. Lo Stato imprenditore e innovatore non c’è. Sugli investimenti pubblici l’Italia retrocede nell’Ue. La futura generazione chiederà il conto.
Nel presentare il suo Piano, Mario Draghi aveva detto che è il momento di essere «radicali». Doveva, allora, esserlo già nel titolo: perché Piano nazionale «di ripresa e resilienza»?
Se è chiaro per molti di noi che «non vogliamo tornare alla normalità perché era la normalità il problema» e che se ci siamo infilati in questo tunnel è perché quella era la nostra «normalità», ebbene, non dovremmo parlare di «ripresa» ma di «cambiamento»: un piano nazionale di cambiamento e resilienza, di questo avremmo bisogno, questo sarebbe «radicale».
E invece no: stiamo proprio parlando di «riprendere» (le vecchie abitudini), come se non avessero nulla a che fare con lo stato in cui ci troviamo.
Il documentone è stato presentato al Parlamento, discusso (per così dire) enunciando princìpi, poi inviato a Bruxelles con le sue migliaia di pagine. Mancano i decreti attuativi, si discute di «cabina di regia», di grandi linee. Quale disegno di paese, di economia, di società soggiace a quel Piano?
L’idea generale che emerge dalla defatigante lettura e dalle vulgate circolate sui «media mainstream» è che non si è dato vita ad un’idea (nuova) del mondo – una «visione», come si usa dire oggi – ma si è soltanto insistito su un concetto: «tenete duro». Il mondo è ingiusto, lo abbiamo guastato, ma forse potremo farcela (mantenendolo ineguale).
L’orizzonte del Piano (quinquennale!) è il 2026 ma qui non si tratta di socialismo. Tutt’altro. Si basa su quell’altro piano – il «Next Generation Eu» – che ne fornisce le risorse. Ma se c’è una cosa che la« next generation» dovrà fare, da subito, è tirare le orecchie ai governanti e tenere gli occhi ben aperti.
Il Piano pare non sapere cos’è la biodiversità, che il consumo di suolo è dannoso, che per adottare nuove tecnologie bisognerà gettarne via altre ex imperio, non perché lo decide il mercato. Greenwashing è il termine che gli ecologisti usano per deridere l’ipocrisia con la quale governi e imprese stanno affrontando, spesso, il tema della «transizione ecologica».
Non basta affibbiare un 4.0 per cambiare strada: in Italia non abbiamo bisogno di nuove autostrade, di nuovi treni ad alta velocità, di allargare aree metropolitane e periferie fagocitando terreni agricoli e naturali. C’è forse qualcosa di «ecologico» in una linea Tav, definita «sostenibile»? E nella sua costruzione, con le devastazioni che i cantieri si portano? (visitate la Val di Setta tra Bologna e Firenze per credere).
Dobbiamo recuperare le aree interne (la «Missione 5» vi destina appena 600 milioni di euro), ripopolare le vaste zone di suolo erose, disboscate, abbandonate, perché non succeda che ad ogni acquazzone un paese frani.
Abbiamo bisogno di più lentezza, non di velocità, di treni e trasporti locali collettivi, di meno automobili private, di centomila piccole opere, non di sei grandi opere.
Il Piano ha alcuni vizi di fondo su cui bisognerà tornare e insistere, visto il mutismo dei partiti di governo, dei loro parlamentari e dei loro apparati.
In primis, il Piano si affida ai privati, al mercato. Lo Stato imprenditore, lo Stato innovatore, lo Stato promotore non c’è, forse perché ritenuto incapace. E gli investimenti pubblici? Sono anni che l’Italia è retrocessa, su questo, nelle graduatorie europee. Più degli altri, il nostro Stato ha rinunciato a investire in istruzione, ricerca, innovazione, opere pubbliche, assetto del territorio.
La valutazione d’impatto dei progetti viene considerata un fastidio (oltre alla scandalosa intenzione, che è stata stigmatizzata, di aggirare il codice degli appalti, tanto «la mafia non esiste»).
Il dottor Draghi, che pure è stato allievo di Federico Caffè, sa che una maggiore produttività non è solo ottenibile risparmiando sui costi.
Sono venticinque anni, ormai, che la produttività in Italia non cresce: non quella del lavoro, che continua anche se lentamente a migliorare (ma forse, anche lì, si è raschiato il fondo del barile); non quella del capitale, che comunque importiamo dall’estero, ma quella dei fattori, totale.
Certo, si dice, il Piano stabilisce le coordinate: saranno poi le spese correnti ad aggiungere (e allora vedremo la prossima legge di bilancio). Ma le riforme auspicate – tutte essenziali e giustissime – come quelle della Pubblica amministrazione e della Giustizia lasciano pensare che si ha in mente la vecchia ricetta: più flessibilità, più incentivi al profitto.
Ma il mercato, se lo seguiamo fino in fondo, ci porterà alla catastrofe. Fino a che non considereremo il capitale naturale nei nostri conti (e in quelli delle imprese), l’ideologia della crescita (anche se «sostenibile») produrrà solo danni.
Forse dovremmo essere apertamente anti-capitalisti, come suggerisce Piero Bevilacqua. Per il momento, basterebbe obbligare imprese e capitalisti a metter in conto, nei loro piani, il concetto che la natura non è a nostra disposizione per essere sfruttata ad libitum. Perché ci sta già presentando il conto che, come sempre, saranno i meno attrezzati, i più disuguali, a pagare. Come i maiali di Orwell.
Questo articolo è stato pubblicato su Il manifesto il 15 giugno 2021