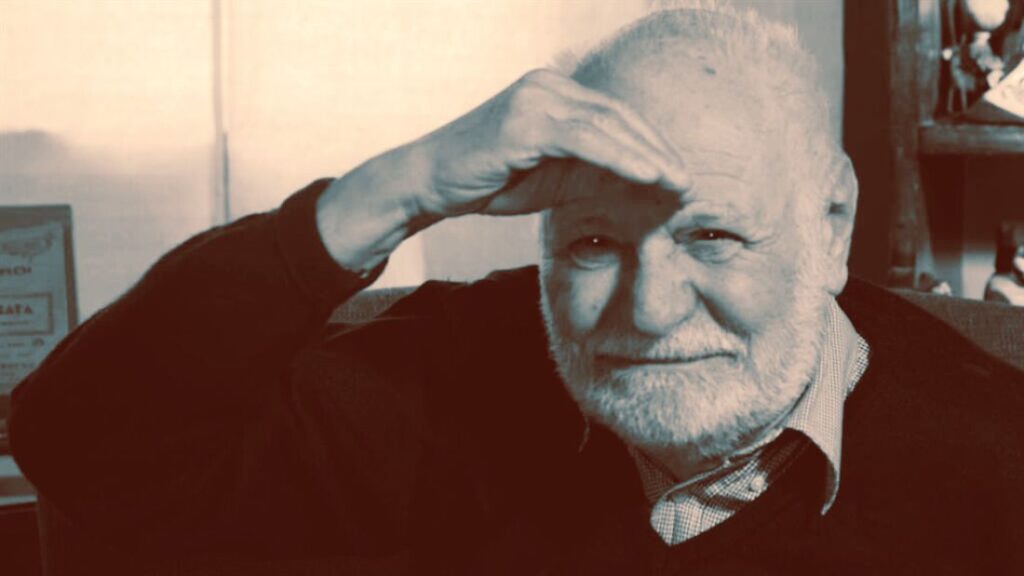Diritti. Uno tra gli scopi principali della nuova normativa, non sia da rinvenire nella repressione dei comportamenti di discriminazione, che pure non devono essere tollerati, ma ancor più nel suo carattere di contrasto culturale.
Critiche al ddl Zan sono state espresse non solo da omofobi o intolleranti, ma anche da esponenti del mondo cattolico e liberale, nonché da una parte della cultura femminista. Da un lato, si è manifestato il timore che si possa limitare il libero dissenso nei confronti di pratiche e tipi di relazione contrari alle proprie ideologie, dall’altro è stata contestata l’introduzione di una formulazione che tende a dare rilievo all’identità percepita rispetto al sesso biologico. Vediamo di prendere sul serio queste obiezioni e valutarne il fondamento.
Per quanto riguarda la questione dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, essa non può essere posta in astratto. Certamente la democrazia pluralista si qualifica per le garanzie prestate alle opinioni espressa dai consociati, soprattutto a quelle meno condivisibili, sicché i reati d’opinione dovrebbero essere esclusi (non sempre è così nel nostro ordinamento, ma questo è un altro problema). Ciò però non vuol dire che non vi siano limiti alle modalità di “manifestazione” delle opinioni: oltre al “buon costume”, che è espressamente indicato in costituzione, essenzialmente quando queste ledono altri principi fondamentali del vivere civile, quello della dignità sociale delle persone in particolare. È per questo che un’opinione ingiuriosa, non veritiera, diffamatoria provoca responsabilità penali ovvero civili per chi le divulga.
Nel caso del ddl Zan si ha poi una particolarità. Esso tende a prevenire e contrastare una serie specifica di discriminazioni, quelle collegate al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e alle disabilità, ritenute particolarmente odiose, che vanno ad aggiungersi a quelle già previste nel nostro ordinamento e relative alla razza, all’etnia e alla religione. In tutti questi casi si vieta la “propaganda e istigazione a delinquere”, nonché si stabilisce un’aggravante “fino alla metà” della pena qualora un reato sia commesso per finalità di discriminazione nei confronti dei soggetti indicati.
Ciò limita la libertà di manifestare opinioni radicalmente contrarie – chessò – alla parità di genere, ovvero ai rapporti omosessuali, magari rozzamente espresse? Può certamente escludersi nel caso dell’aggravante: qui il reato è autonomo (si pensi all’aggressione di un transessuale o ad una coppia gay) e non ha nulla a che fare con le opinioni, ciò che viene in evidenza è la motivazione “spregevole” che ha portato a compiere il fatto. Nel caso di “propaganda e istigazione” la questione si può porre, ma tre considerazioni fanno ritenere che in questo caso si sia ben al di sotto della soglia di allarme.
In primo luogo, la previsione espressa nello stesso disegno di legge. Su iniziativa dell’onorevole Costa, che si è fatto interprete dei dubbi del mondo liberale e cattolico, è stata approvato un articolo per assicurare il pluralismo delle idee e la libertà delle scelte. Con una formulazione, in realtà mal scritta, si è voluto espressamente indicare che sono fatte comunque salve le opinioni se queste non sono idonee a determinare il concreto pericolo di atti discriminatori o violenti. In tal modo, si sono fatte rientrare le previsioni del più ambiguo divieto di “propaganda” in quelle più specifiche dell’“istigazione”. Era questa una precisazione di cui, peraltro, non vi era neppure bisogno, poiché già chiarita dalla Corte costituzionale (ma poi anche dalla Cassazione), in tempi assolutamente non sospetti.
È questa la seconda e più importante ragione che porta a escludere che la libertà di manifestare un pensiero (anche il più avverso) sia in pericolo. Da sempre – una prima significativa sentenza è del lontano 1957 – la Consulta ha tenuto a precisare che nei reati di opinione elemento decisivo è da ritenersi l’effettiva “offensività”, ovvero il pericolo concreto che la propaganda ovvero l’apologia siano in grado di produrre conseguenze delittuose. In sostanza, la propaganda si deve esprimere come una “istigazione indiretta” e costituire un “apprezzabile pericolo” del prodursi di eventi criminosi. È certo vero che tali circostanze dovranno, in ultima istanza, essere apprezzate dal giudice e, dunque, si può temere una valutazione non così rigorosa, che possa portare a condanne anche in assenza di un pericolo immediato.
Se si valuta però alla luce dell’esperienza – e questo è il terzo motivo da considerare – non credo si possa temere più di tanto: sino ad ora i reati di propaganda e istigazione al razzismo su cui si va ad innestare la nuova normativa non hanno prodotto molte condanne. Anzi il rischio è che anche nei casi collegati all’omofobia le nuove norme producano scarsi effetti concreti.
Proprio questo mi porta a dire che uno tra gli scopi principali della nuova normativa, non sia da rinvenire nella repressione dei comportamenti di discriminazione, che pure non devono essere tollerati, ma ancor più nel suo carattere di contrasto culturale. I discorsi d’odio, così come i crimini d’odio, non si combattono solo nelle aule dei tribunali, quanto soprattutto sul piano educativo, promovendo le ragioni del rispetto e dell’inclusione, opponendosi alle discriminazioni e ai pregiudizi. Vi sono alcune norme nel ddl Zan che provano a contrastare le discriminazioni su questo specifico piano. Perché oltre a tutelare la sacrosanta libertà d’opinione di tutti (persino degli omofobi e degli intolleranti) c’è grande bisogno di provare a far valere il valore delle differenze.
È qui che si innesta la polemica di parte del movimento femminista che inizialmente richiamavo. Entrare nel merito delle questioni sollevate è necessario, ma non può essere risolto con poche battute, poiché siamo di fronte a problematiche vivacemente discusse, che dividono trasversalmente le culture femministe, LGBT, della sinistra, che coinvolgono la visione di sé e la percezione dell’io: il corpo come accidente solo biologico ovvero come espressione di una diversità da cui partire. Questione esistenziale e antropologica.
Quel che solo mi voglio qui domandare è se la legge debba prendere posizione su queste questioni. In fondo per conseguire le sue finalità, ovvero la tutela della dignità sociale di tutti i soggetti cui si rivolge, tra loro assai diversi, non sarebbe stato meglio utilizzare una locuzione altrettanto precisa – anzi con un tasso minore di indeterminatezza semantica – evitando un glossario iniziale che non solo divide, ma può persino generare confusioni applicative. Bastava in fondo scrivere che la legge riguardava le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e di genere, oltre che sulle disabilità. Non spetta poi alla legge stabilire cos’è un corpo, né distinguere tra genere e sua identità.
Questo articolo è stato pubblicato su Il Manifesto il 26 maggio 2021