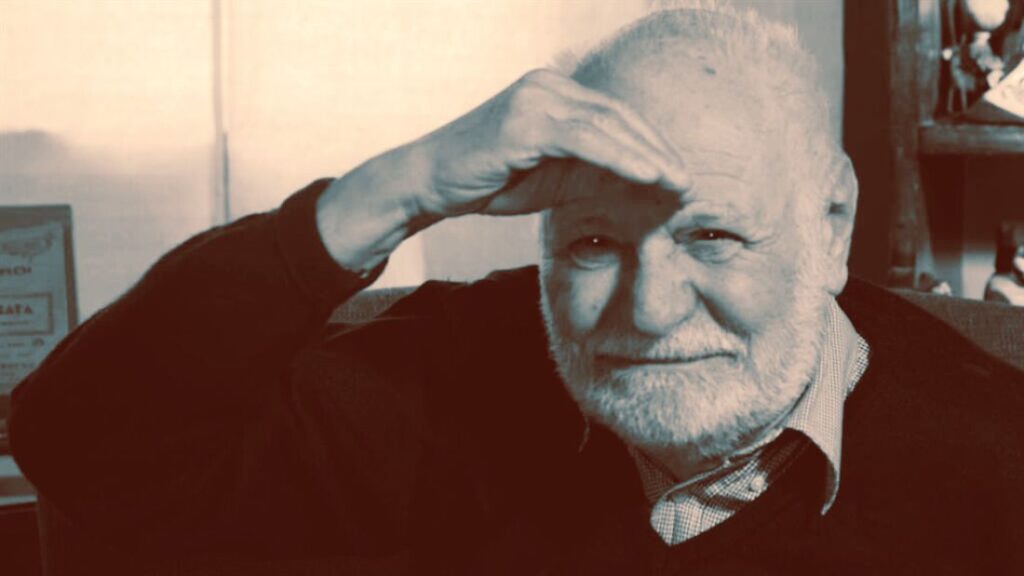La lotta all’omobitransfobia ha ottenuto visibilità mediatica ma non altrettanto la voce di chi subisce direttamente violenze e discriminazioni. Il Ddl Zan è necessario ma serve un cambiamento sociale e culturale senza compromessi al ribasso.
Capita spesso che in un’assemblea d’istituto sulla sessualità in cui si è appena parlato di stereotipi e ruoli come cardine della violenza di genere sorga a qualche studente spontanea la domanda: «Ma scusa, se ci hai appena detto che le etichette sono la causa delle discriminazioni, perché si continua ad aggiungere lettere alla sigla Lgbtq+? Non crea ulteriori discriminazioni?».
La domanda è legittima, non solo perché in Italia non esiste un’educazione sessuale che non sia eteronormata, ma perché la storia stessa del movimento Lgbtq+ è una storia invisibilizzata. Alla risposta però giungono spesso i ragazzi stessi: gli stereotipi non sono altro che etichette imposte dall’alto, costrutti culturali che creano aspettative basate unicamente sull’organo genitale, stabilendo così ciò che è «normale». Se hai un pene, sarebbe «normale» che fossi maschio, e se sei maschio devi essere sicuro e forte; se mostri fragilità o sensibilità sei fuori dalla norma e la società ti chiama frocio – a prescindere dal tuo orientamento sessuale. Quella sigla è nata però perché una sessualità o un’identità diversa dalla norma non esisteva nemmeno nel discorso comune, perché un tempo per poter amare ed essere chi si vuole era necessario farlo di nascosto, rischiando l’esclusione e il linciaggio da parte di chi ti stava attorno o direttamente dalla polizia. Quella sigla nasce come ribellione a un’invisibilità imposta, non solo culturale ma fatta anche di calci e manganelli. E dunque il coming out al mondo di una gamma di identità è a tutti gli effetti una conquista: quelle lettere mettono in discussione la «norma» e aggiungendo parole nuove al discorso permettono anche a noi di dire che ci siamo.
Le «tematiche Lgbtq+» sono entrate nel discorso comune come denuncia di una condizione di subalternità, ma mentre quella subalternità stentava a essere risolta il neoliberismo è stato più veloce nella sua contromossa: una volta che la comunità Lgbtq+ è riuscita a rompere il muro dell’invisibilità, diventando impossibile da ignorare e interrogando la società occidentale sulla sua presunta superiorità in ambito civile, il mercato vi ha subito visto un’occasione di profitto. Il fenomeno va sotto il nome di pink e rainbow washing e si manifesta ad esempio nella colonizzazione dei Pride da parte di grosse multinazionali che tingono di arcobaleno il loro logo, trasformando in parata quello che un tempo era un momento di lotta, in favore di immensi guadagni economici e dello svuotamento di contenuti rivendicativi.
Se sul versante economico la contraddizione è più leggibile, su quello politico, in un momento in cui tutto ciò che viene discusso dal basso fatica ad accedere al dibattito pubblico, tra i partiti e le attuali forme di rappresentanza c’è il vuoto. È quel vuoto che fa risaltare a tal punto l’intervento di Fedez a favore di una legge contro l’omofobia. Senza entrare nel merito delle intenzioni o contraddizioni del personaggio – e di quelle di un palco per la festa dei lavoratori finanziato da banche ed Eni – è importante sottolineare che se oggi un cantante famoso, benestante, etero e cisgender decide di usare la propria posizione di privilegio sociale ed economico per prendere una posizione contro le discriminazioni, che sia per convenienza o convinzione, è grazie a una battaglia culturale in parte vinta per la conquista di visibilità. D’altro canto però la percezione di forte discontinuità che ha sortito l’intervento di Fedez rende evidente in maniera allarmante la mancanza di spazio dato a voci subalterne che parlino in prima persona.
Infatti iniziative dal basso come la piazza di sabato scorso a Roma con più di 10 mila persone, in cui a prendere parola non sono stati artisti famosi ma collettivi Lgbtq+ locali, chi subisce la violenza e lotta contro di questa tutti i giorni, non hanno avuto alcuno spazio mediatico sulle testate nazionali. Forse perché la piazza non si limitava a raccontare l’orrore dell’omofobia esprimendo un generico sostegno alla legge Zan, ma rivendicandone l’urgenza spiegava anche perché non basta.
All’invisibilizzazione di quella e tutte le altre piazze costruite in queste settimane si accompagna l’eco del luogo in cui i movimenti e la voce dei subalterni viene interpellata ancor meno, quasi mai, anche quando si parla di loro: il Parlamento. Negli ultimi dieci anni le quattro leggi che in qualche modo riguardavano la comunità Lgbtq+ hanno avuto la stessa identica contrattazione a ribasso da parte del centrosinistra:
1) il Ddl Scalfarotto del 2013, primo tentativo di una legge contro l’omofobia, non era altro che l’estensione della legge Reale-Mancino contro i crimini d’odio. Durante la discussione parlamentare il Pd vota a favore di un emendamento della destra in cambio della tenuta della maggioranza. Il cosiddetto subemendamento Gitti che aggiungeva: «Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all’odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero assunte all’interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all’attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni». Modificando così il testo, una legge contro l’omofobia garantiva immunità a partiti come Forza Nuova o a organizzazioni come Militia Christi, che in quello stesso anno aveva minacciato pubblicamente di pestaggio un collettivo Lgbtq+ dell’Università Statale di Milano per aver pubblicato una locandina con il Papa truccato. Fortunatamente la legge venne insabbiata, ma il risultato fu che non si parlò più di legge contro l’omofobia per sette anni.
2) Il Ddl Fedeli del 2015, un timido disegno di legge sull’educazione «di genere», non vide mai l’approvazione per questioni interne alla maggioranza.
3) Il Ddl Cirinnà è è forse il caso più emblematico: se inizialmente il testo attribuiva alle unioni civili «gli stessi diritti e doveri del matrimonio», gli alleati di governo del Pd del Nuovo Centro Destra di Angelino Alfano e la fronda Cattolica dello stesso Pd pretesero che venisse eliminato ogni riferimento al matrimonio, facendone una questione semantica e simbolica. In questo modo la seconda stesura vide costretta la relatrice a dover elencare i diritti civili e sociali derivanti dall’istituto del matrimonio, rendendoli dunque più emendabili e aggredibili dagli emendamenti della Lega per cui la legge in aula approdò monca di una serie di diritti come la Stepchild Adoption. Ma la questione è ancora più emblematica: se in Italia vige un welfare tutt’altro che universale, in quanto è definibile residuale, particolaristico e spiccatamente familistico e se la famiglia è definita come «società naturale fondata sul matrimonio», togliere ogni riferimento al matrimonio dalle unioni civili significa spogliare la legge del suo potenziale trasformativo, lasciandola al mero piano dei diritti civili.
4) Anche sul Ddl Zan il baratto politico a ribasso in Parlamento procede senza troppi intoppi: rimane l’estensione della legge Reale-Mancino, aggiungendo all’aggravante penale per discriminazione razziale ed etnica anche quella per omobitransfobia e misoginia. Ma i finanziamenti a centri antiviolenza per soggetti discriminati sono stati approvati fuori dalla legge, impedendone uno stanziamento strutturale. È stata inserita una clausola «salva idee» che tuteli «la libertà e la pluralità di espressione» che seppur meno mostruosa dell’emendamento Gitti rimane una contrattazione al ribasso. E, per non farsi sfuggire nulla, all’articolo che prevede di istituire una giornata dedicata alla lotta contro l’omobitransfobia il 17 maggio, già giornata internazionale per il medesimo tema, è stato tolto il riferimento ad attività connesse nelle scuole. La destra ancora una volta approfitta dell’approccio strumentale e di facciata alle tematiche Lgbtq+ da parte del centrosinistra per blindare ogni possibilità che un intervento a riguardo possa intaccare l’impianto culturale o economico della società.
Se oggi risulta importante visibilizzare la violenza omobitransfobica e patriarcale davanti alla giustizia e alla giurisprudenza, l’aggravarsi delle pene per i crimini di odio non fermerà le aggressioni, i pestaggi, le forme di mobbing e i licenziamenti per discriminazione sessuale. Questa volta però sappiamo come andare avanti. Se riconosciamo l’omobitransfobia come un’espressione dell’eteropatriarcato, un orizzonte rivendicativo esiste già ed è quello del movimento globale transfemminista Non Una Di Meno e del piano contro la violenza di genere scritto dal basso.
Sconfiggere l’omofobia è una battaglia sociale e culturale oltre che civile: sociale perché senza reddito universale una ragazza o ragazzo non etero e non cis sarà sempre economicamente dipendente dalla famiglia maltrattante, senza misure strutturali sui percorsi di fuoriuscita dalla violenza legati al diritto all’abitare difficilmente potrà andare via di casa, senza una giustizia riparativa e non punitiva quella famiglia non comprenderà mai il male procurato. Culturale perché senza un’educazione sessuale (nelle scuole e nei luoghi di lavoro) non eteronormata e non binaria al piacere e al consenso, le scuole continueranno a essere anche spazi di violenza, le giovani generazioni continueranno a pagare il conto della mancanza di anticorpi culturali contro il fascismo e il bigottismo che troppo spesso condiziona la gestione dei luoghi della formazione. La destra conosce bene il ruolo della scuola come unico accesso universale al sapere e ci tiene a difenderne il controllo, basta vedere che al minimo discorso sull’educazione sessuale spuntano le Sentinelle in Piedi, si costruiscono ad arte narrazioni complottistiche sulla «Teoria Gender» insieme a operazioni ben più strutturali come quella della Curia di Milano che, nel 2014, invitava gli insegnanti di religione a segnalare le scuole in cui si svolgevano progetti di educazione sessuale per contrastare il pericolo di «propaganda omosessualista».
Il percorso di lotta che ci aspetta a partire ma anche oltre il Ddl Zan deve trasformare in pratica lo slogan «non lasciare indietro nessuno», con la capacità di arrivare non solo ai centri delle grandi città ma anche nelle province e nelle periferie, dove non tutte e tutti hanno avuto le possibilità economiche e culturali per compiere determinati percorsi. E bisogna farlo dal basso, costruendo alleanze tra corpi ed esperienze in grado di approfondire un processo di trasformazione sociale. Per questo, nella giornata internazionale contro l’omobitransfobia, dobbiamo dire che vogliamo tutto, molto più di Zan.
Questo articolo è stato pubblicato su Jacobin il 17 maggio 2021