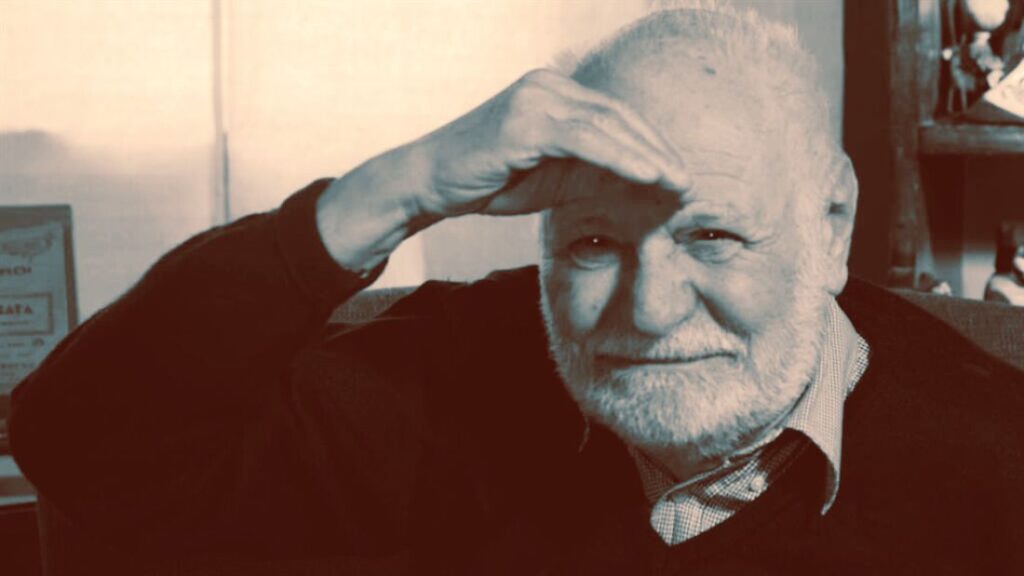Condividiamo da Ribalta la prefazione, scritta da Sara R. Farris, al libro Manifesto della cura, di The Care Collective (Alegre, 2021).
Di cosa parliamo, quando parliamo di cura? Cosa vuol dire avere cura degli altri? E chi sono questi altri? Come fare in modo che prendersi cura degli altri non sia solo un’attitudine individuale, da filantropi, ma un imperativo etico e una responsabilità politica?
Queste sono le domande che guidano il Manifesto della cura, un testo che – come scrivono le autrici e gli autori – pone la cura al centro del dibattito sulle crisi del presente: dalla pandemia da Covid‑19, alla crisi economica e finanziaria, alla crisi ambientale.
Quasi a sottolineare che discutere di cura, così come prendersi cura, non può essere un processo individuale ma collettivo, il Manifesto della cura è stato scritto a dieci mani. Autrici e autori sono cinque accademici e attivisti di varie nazionalità (Grecia, Australia, Stati Uniti, Regno Unito) tutti residenti a Londra e riuniti sotto il nome di Care Collective (Collettivo per la cura). Il contesto in cui il collettivo si riunisce non è casuale. Da più di vent’anni Londra (e il Regno Unito) è non solo crogiuolo di nazionalità e culture diverse che trovano spazio di espressione dentro le università – in modi ancora impensabili in Europa continentale dove le università continuano a operare secondo regole feudali e scioviniste – ma è anche laboratorio avanzato di processi contradditori che hanno al centro la cura. Da una parte il Regno Unito è lo stato europeo in cui il processo di mercificazione e privatizzazione della cura è tra i più avanzati. È normale così che asili nido e scuole materne, case di riposo per anziani e disabili, ospedali e cure mediche, siano largamente in mano a compagnie private e a multinazionali, che hanno ridotto la cura a merce ad alto costo. Dall’altra parte anche qui si moltiplicano iniziative di mutuo soccorso e reti di solidarietà che continuano a concepire il prendersi cura degli altri come un bene comune, un obbligo morale e un processo collettivo. In questo contesto di ombre e luci prende forma una delle riflessioni più attuali sui danni dell’incuria e sulla necessità del prendersi cura.
La consapevolezza della nostra dipendenza e interdipendenza dagli altri – si legge nel Manifesto – è il primo passo per rimettere la cura al centro dell’agenda politica e sociale. Sono quarant’anni ormai che i sostenitori del capitalismo neoliberista cercano di convincerci che non siamo esseri sociali ma monadi indipendenti le une dalle altre. La cura neoliberista è una questione di preferenze individuali da scegliere sul mercato, un po’ come si sceglie una macchina o una maglietta. È questa ideologia individualista che, anche in Italia, ha guidato la riorganizzazione dei servizi di cura verso una progressiva mercificazione, secondo l’idea che il privato sia meglio del pubblico. Che si tratti della scelta della casa di riposo, della badante, dell’asilo nido o di cure mediche specialistiche, si fa sempre più strada l’idea (e la pratica) non solo che la cura si debba scegliere all’interno di un ventaglio di opzioni a pagamento, ma anche che la sua qualità e il suo valore di mercato coincidano: più paghi, più mi prendo cura di te.
Il Care Collective identifica proprio nella logica e nelle politiche neoliberiste la causa dell’incuria generalizzata delle nostre società, una situazione che la pandemia da Covid‑19 ha messo drammaticamente in luce. Abbiamo visto gli effetti devastanti dell’incuria neoliberista quando i medici che curavano i malati di Covid‑19 dovevano scegliere chi salvare perché decenni di tagli ai servizi sanitari avevano decimato posti letto e personale. E se è vero che il Coronavirus non discrimina tra ricchi e poveri, o tra persone bianche e non, le possibilità di cura discriminano eccome. Mentre Boris Johnson, Donald Trump e Silvio Berlusconi venivano curati per tempo nei migliori ospedali con terapie innovative e seguiti da equipe di medici di fama, i lavoratori precari o sottopagati e le persone non bianche morivano (e continuano a morire) come mosche. Il rapporto Istat del luglio 2020 non lascia adito a dubbi: i poveri sono stati le vittime principali del Coronavirus in Italia. Ma si tratta di un dato globale. A ogni latitudine sono state le fasce della popolazione più svantaggiate (all’interno delle quali si ritrovano la maggior parte dei migranti e dei non bianchi) a essere più colpite dalla pandemia. Questo si è verificato non solo per via di condizioni abitative sovraffollate, o di occupazioni che li costringono a lavorare fuori casa spesso a diretto contatto con il virus, ma anche perché i poveri, i migranti e le persone non bianche hanno meno accesso a cure di qualità, oppure si rivolgono ai medici quando è già tardi, magari perché non hanno le ferie pagate o perché non parlano bene la lingua del paese in cui vivono, oppure perché non vengono presi sul serio da medici e personale ridotto allo stremo. Se già non fosse stato chiaro dopo decenni di crisi economiche cicliche, guerre imperialiste e catastrofi climatiche globali, il neoliberismo uccide, e uccide soprattutto «i dannati della terra», per dirla con Frantz Fanon, le cui vite sembrano più sacrificabili delle altre.
Il Manifesto della cura denuncia con chiarezza e durezza l’incuria neoliberista e capitalista, tracciandone a tinte fosche le conseguenze più devastanti; ma offre anche idee, pratiche e soluzioni per come uscirne, dal livello interpersonale a quello di vicinato, urbano e statale. Per cominciare, la cura di cui abbiamo bisogno, dice il Care Collective, è una cura promiscua. Prendendo come spunto le pratiche di promiscuità della comunità gay negli anni Ottanta, durante la crisi dell’Aids, il Manifesto propone di sperimentare forme di cura nuove e allargate. Il concetto di promiscuità perciò non fa riferimento a un modo di concepire la cura come «casuale o indifferente», ma esattamente l’opposto. La cura promiscua si pratica al di fuori delle reti familiari e delle logiche di mercato. È cura «indiscriminata», appunto perché non discrimina nessuno. «Cura promiscua», continuano gli autori,
«non significa relazioni effimere tra estranei. Significa invece riconoscere che la cura può mettere in relazione persone non necessariamente vicine. Alle volte anzi la cura è addirittura più efficace, oppure non può che essere prestata da estranei».
Stando ai dati Eurostat 2015 l’Italia è il paese europeo con la maggior percentuale di persone che dichiarano di non avere nessuno a cui rivolgersi – che siano parenti, amici, vicini di casa o conoscenti – per chiedere aiuto di tipo morale o materiale in caso di bisogno [ne abbiamo parlato qui su Ribalta, ndr]. Le ragioni – storiche e culturali – di questo infelice primato sono tante. Promuovere la promiscuità come modello di cura indiscriminata, allora, ci permetterebbe magari di iniziare una discussione franca sul tabù della cura solidale nel nostro paese. Si tratta di un tabù legato, almeno in parte, all’idea di cura come beneficienza e all’avversione per il bisogno di cura come dipendenza. Anche qui il Manifesto ci offre alcune chiavi di comprensione importanti. L’ideologia individualista propria del capitalismo (neoliberista e non) ha patologizzato la dipendenza dalla cura, invece di riconoscerla come parte integrante della condizione umana. La situazione è particolarmente paradossale quando pensiamo che mentre la povertà è stigmatizzata come colpa individuale, e i poveri sono indotti a vergognarsi della loro fragilità e dipendenza, sono proprio i ricchi a essere quelli che dipendono di più dalla cura altrui. «Il loro status e il loro benessere», nota il Care Collective, «sono in parte segnalati dal numero di persone a cui si affidano per ricevere sostegno e attenzione, dalle tate alle domestiche, dalle cuoche ai maggiordomi, fino ai giardinieri e alla vasta gamma di lavoratori e lavoratrici che, al di fuori della famiglia in senso stretto, forniscono risposte ai loro bisogni e desideri quotidiani».
Ma se i ricchi possono dissimulare la loro dipendenza grazie all’accesso facile a una cura sempre più mercificata, come possiamo dare vita a sistemi di cura in cui l’interdipendenza sia accettata come «naturale» e la cura non sia a pagamento? Se la cura promiscua è un’attitudine e una filosofia dello stare insieme, si struttura e si organizza in maniera collettiva all’interno di comunità di cura. Il Manifesto individua quattro elementi fondamentali per dare vita a una comunità di cura: il mutuo soccorso, lo spazio pubblico, la condivisione di risorse e la democrazia di prossimità.
Durante la pandemia anche in Italia ci sono state diverse iniziative che hanno provato a costruire delle vere e proprie comunità di cura. Il centro sociale milanese Ri‑Make ne è un esempio emblematico. Con la campagna NonSeiSola/Solo i giovani attivisti e attiviste hanno organizzato la consegna della spesa per coloro che non potevano uscire di casa, attività doposcuola gratuite per i bambini del quartiere e incontri per discutere la riconversione di spazi pubblici in beni comuni accessibili a tutti.
Se la promiscuità e la costruzione di comunità di cura sono esempi illuminanti di come si possa rispondere alla crisi che attraversiamo riscoprendo il valore della solidarietà indiscriminata, essi non sono sufficienti. Perché la cura universale, non‑mercificata e solidale diventi il «principio organizzativo» delle nostre società, è necessario che lo stato se ne faccia carico. Lo stato neoliberale che amministra le nostre vite è uno stato che dipinge la cura come fardello. I tagli alla spesa pubblica e ai servizi di cura vengono presentati come necessari alle politiche di bilancio e perciò inevitabili. Lo stato neoliberale è uno stato privatizzato, soggiogato agli interessi del profitto, che rinuncia alla politica per seguire i diktat economici dei vari istituti finanziari internazionali.
Per le autrici e gli autori del Manifesto della cura è necessario soppiantare lo stato neoliberale e promuovere uno stato di cura. Quest’ultimo è uno stato che orienta il suo agire sulla base dei bisogni collettivi. Tuttavia non è uno stato che si basa sul principio di cittadinanza e àncora i diritti alla nazionalità, ma uno stato cosmopolita che assicura a chiunque ne abbia bisogno una cura versatile, di alta qualità e gratuita in tutti gli stadi della vita, dall’infanzia alla vecchiaia.
Uno stato di cura è anche uno stato ambientalista. Il riscaldamento del pianeta, l’ecatombe di milioni di esseri viventi (siano essi piante o animali), sta mostrando in maniera incontrovertibile che le nostre vite dipendono non solo dagli altri umani, ma dal mondo organico più in generale. Prendersi cura allora vuol dire anche sentirsi in relazione di interdipendenza con la natura e imporre agli stati l’applicazione di tanti Green New Deal che affrontino seriamente il collasso del pianeta. La cura universale di cui parla il Manifesto è incompatibile con il capitalismo. Ha ragione Naomi Klein: la cura è il concetto e la pratica più radicale che abbiamo oggi a disposizione.