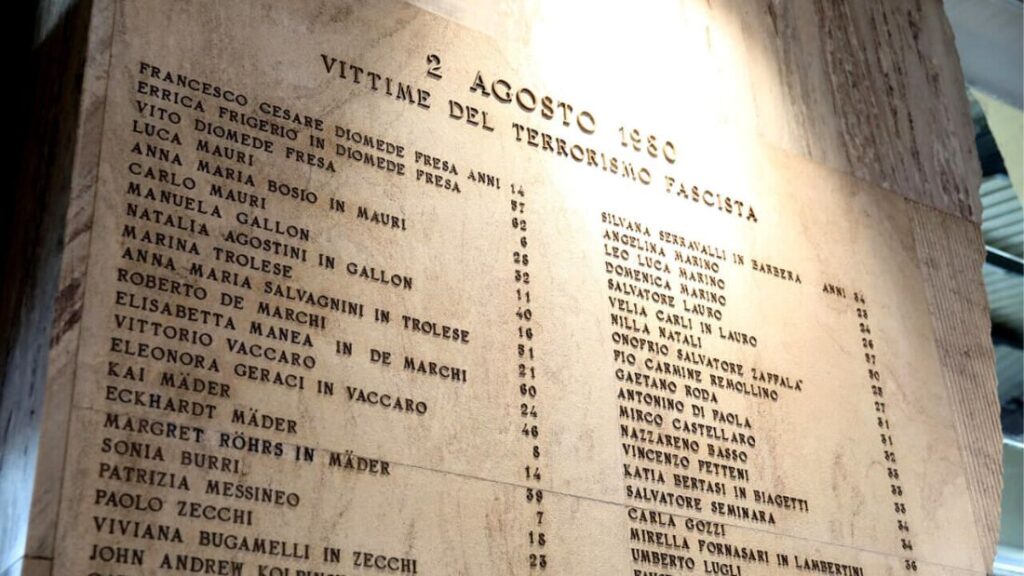‘Meticcio’ è una parola antica utilizzata originariamente per classificare i nati dall’incrocio tra conquistatori spagnoli e portoghesi e le popolazioni native, ai tempi in cui la chiesa cattolica sosteneva che i “selvaggi” del Nuovo continente fossero privi di anima. Poi il significato del termine meticcio si è esteso fino a comprendere in generale i nati dagli incroci tra razze diverse. Anche noi italiani abbiamo generato meticci al tempo in cui sognavamo l’impero e per conquistarlo gasavamo e massacravamo i popoli africani. A cercare un posto al sole abbiamo iniziato a fine Ottocento, quando l’unità d’Italia era solo sulla carta ma già ci agitavamo alla ricerca di una collocazione adeguata all’altezza degli altri stati, quelli più potenti e coloniali di noi. Poi, da Giolitti a Mussolini il sogno dell’impero è cresciuto, e con esso sono aumentati i meticci, figli di soldati coloni e giovani donne – a volte bambine – africane, comprate come cammelli. Nel ’36 Indro Montanelli ne acquistò una di dodici anni insieme a un cavallo e un fucile per 500 lire dal capo di un villaggio. Forse si chiamava Destà e forse no, probabilmente il giornalista neppure se lo ricordava al momento in cui decise di raccontare le sue epiche gesta in Abissinia. La definiva “animalino docile”, tantopiù che “con i negri non si fraternizza. Non si può, non si deve. Almeno fino a quando non si sia data loro una civiltà”. Erano i tempi in cui si cantava “Faccetta nera/ bell’abissina/ aspetta e spera che già l’ora s’avvicina”. Non restò molto a lungo in Africa, Montanelli e quando tornò in Italia neanche ci pensò a portarla con quella bambina, del resto “non si sarebbe trovata bene”, ebbe a dire successivamente. Tanti di questi “animalini” finirono in mano ai soldati e ai colonizzatori italiani che, sia chiaro, non erano tutti razzisti e fascisti, qualcuno cercò anche di dare il proprio cognome ai bambini nati dalla relazione con le donne – bambine – africane, ma con la promulgazione delle leggi razziali di Mussolini venne vietato ogni rapporto carnale con “altre razze”, figuriamoci il riconoscimento dei bambini meticci. In gran parte, così, le mamme e i loro bambini vennero abbandonati dai colonizzatori italiani. Macché colonizzatori, “civilizzatori”.

Dalla prima storia coloniale italiana, a fine Ottocento, parte il memoir di Vittorio Longhi Il colore del nome, sottotitolo Storia della mia famiglia. Cent’anni di razzismo coloniale e identità negate (Solferino editore, 280 pagine, 17,50 euro). Tutto inizia nel 1890 con l’arrivo in Eritrea di Giacomo, bisnonno di Vittorio, al seguito del regio esercito. Ha due figli con una donna-bambina e abbandona tutti e tre. Uno dei due figli, Vittorio, attivista meticcio, verrà ucciso in circostanze tragiche, vittima perché colpevole del colore incerto della sua pelle. Quelli come lui, i meticci, sono rifiutati, rimossi, cancellati dal mondo ex coloniale, cioè dagli italiani e odiati dagli africani che li vivono come traditori, ascari loro malgrado. Vittorio “lascia vedova e orfani a fare i conti con l’eredità delle violenze fasciste”. Uno dei figli di Vittorio, Pietro, fugge in Italia dove si sposa e ha un figlio; ecco dunque l’altro Vittorio, l’autore del libro. Anche lui come il nonno dimenticato dal padre che ha avuto un’altra donna e un’altra figlia. Vittorio ha incontrato suo padre Pietro una sola volta, alla stazione di Milano. Una sola volta, più che sufficiente.
L’identità può essere rimossa e accantonata ma non troppo a lungo, prima o poi vuoi conoscere le tue radici. Le radici servono a resistere alle intemperie e agli smottamenti del terreno su cui cammini, conoscerle significa conoscersi. Ma le radici sono anche catene e le catene vanno spezzate. Un giorno, il messaggio di una cugina con la pelle del suo stesso colore spinge Vittorio Longhi, inizialmente riluttante, a ripercorre a ritroso quel viaggio iniziato oltre un secolo prima dal bisnonno Giacomo. E così, eccolo in Eritrea a incrociare storie e volti, luoghi e persone con il suo stesso sangue, li guarda con gli stessi occhi con cui a Lampedusa Vittorio guardava altri eritrei, quelli salvati dalla violenza del mare e del razzismo e quelli racchiusi in tante bare di chi non ce l’aveva fatta ad attraversare il “mare nostrum”. Insegue le tracce lasciate dal padre Pietro che infine si perdono, dalle parti della Tunisia, dove vive l’altra sua figlia con cui Vittorio riesce a entrare in comunicazione. Tracce perdute forse per sempre. Forse lo erano già perdute, quel giorno lontano alla stazione di Milano. Oppure, o per questo, Vittorio sceglie di mettere in esergo a Il colore del nome, le parole di Omero, Odissea Libro XVI: “Se ai mortali fosse possibile scegliere tutto da sé, sceglieremmo per primo il dì del ritorno del padre”.
Vittorio Longhi è un giornalista con gli occhi aperti sul mondo, sulle gabbie dello sfruttamento nel lavoro, sui tentativi di fuga dalla miseria e dalle dittature e sulla violenza che i migranti subiscono dopo lo sbarco generata dall’egoismo dell’Europa. Violenza figlia del colonialismo, peccato originale rimosso che continuiamo a chiamare razzismo. Ancora oggi ci nascondiamo dietro la menzogna degli “italiani brava gente”, ancora oggi neghiamo il riconoscimento agli italo-eritrei, ancora oggi perseveriamo nel non chiedere scusa ai popoli che abbiamo sopraffatto in nome di una supremazia bianca. Persino il Belgio, ci ricorda lo stesso Longhi, ha chiesto scusa per le discriminazioni imposte ai meticci del Congo, del Ruanda e del Burundi. L’Italia no. Del resto, neanche ai bambini nati in Italia da genitori migranti riconosciamo la nazionalità. Al massimo un codice fiscale per pagare le tasse da grandi.
Il colore del nome è un libro molto bello, delicato, avvincente nella ricerca delle radici del nome e del colore della pelle all’interno di una storia tragica, quel peccato originale che ancora oggi continua a sfornare i frutti avvelenati del razzismo. Il memoir di Vittorio Longhi aiuta a guardare con occhi diversi al mondo, alle vittime, al diverso da noi. Vittorio si è inventato una rubrica sul manifesto sul lavoro e i conflitti nel mondo per la conquista di diritti e dignità, è andato avanti scrivendo per il Guardian, l’ International New York Times, Repubblica. Per conto dell’Onu ha formato e continua a formare giornalisti in giro per il mondo.