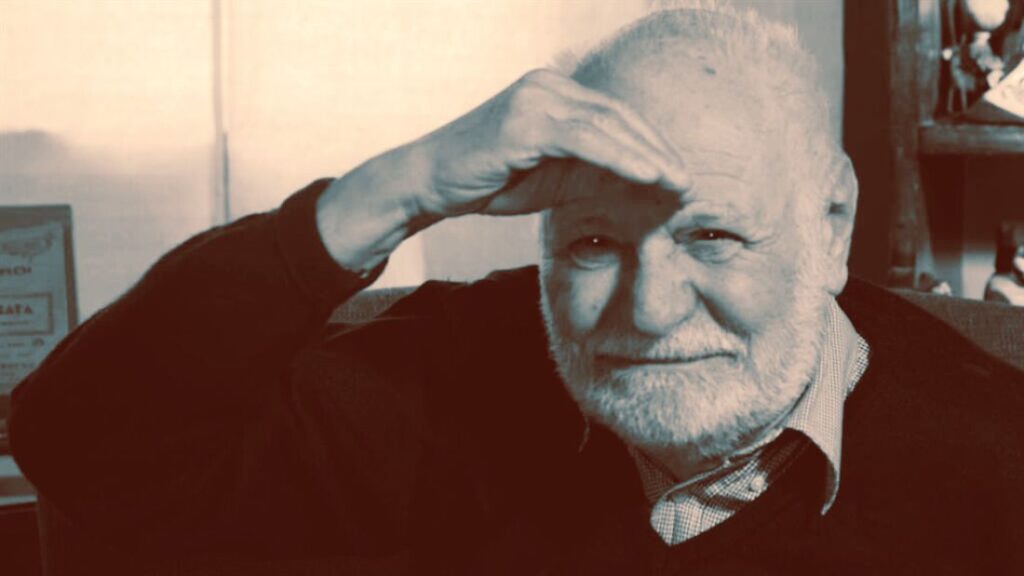Dal periodo di riflessione e quiete sul piano dell’azione dei movimenti climatici, causa pandemia, arriva il nuovo libro di Andreas Malm, How to Blow Up a Pipeline (2021, Verso). A dispetto del titolo incendiario (come far esplodere un oleodotto), questo conciso pamphlet non è un manuale pratico su come smantellare infrastrutture ma un trattato di strategia e filosofia politica per attivisti climatici, che parla al momento attuale e al vicino futuro. Malm è un professore svedese di ecologia umana all’università di Lund e uno storico marxista, autore di una dozzina di libri, sia accademici che popolari, che vanno dalla storia dell’uso capitalista dei combustibili fossili (la sua magnum opus è Fossil Capital), alle rivoluzioni arabe e alla geoingegneria. Milita nel movimento per la giustizia climatica ed è una voce influente dalla sinistra internazionale. Anche se le idee di Malm sono ancora poco dicusse in Italia, il suo ultimo libro impone un confronto per chiunque condivida le battaglie per il clima. In duecento pagine di ritmo serrato e tono polemico, Malm disseziona le strategie del movimento climatico di massa evidenziando le sfide di cui dovrebbe farsi carico e criticando la scarsa consapevolezza storica e politica di alcune sue manifestazioni. Su questa base, dispiega il suo contributo: un’articolata difesa dell’azione diretta contro un tipo specifico di proprietà, quella irresponsabilmente implicata nella combustione del mondo.
Che l’uso indefesso dei combustibili fossili rischi di costare la Terra all’umanità è un dato acquisito. La crisi climatica è uscita da tempo dagli studi scientifici manifestandosi in eventi atmosferici estremi ai quattro angoli del pianeta. Le famigerate emissioni di CO2 devono improrogabilmente diminiuire fino allo zero così da rimuovere il carburante che alimenta gli sconvoglimenti climatici. Occorre entrare nell’ordine di idee che l’output di gas serra delle attività che attualmente bruciano carbone, gas e petrolio è direttamente collegato all’aumento di intensità e frequenza dei prossimi uragani, delle prossime siccità, delle prossime ondate di calore e di gelo. Il riscaldamento antropogenico dell’atmosfera è un processo pressochè lineare, per il quale ogni unità di gas serra aggiunta al bilancio corrisponde a un aumento della temperatura media terrestre. Il suo carattere cumulativo significa in sostanza che ogni tonnellata di CO2 in più o in meno ne determina la severità: la totalità del riscaldamento globale sarà sempre una funzione della totalità delle emissioni. Di conseguenza, non sarà mai troppo tardi per intervenire al fine di contenere la sofferenza dei prossimi dieci o cento anni.
Il movimento climatico si erge su queste evidenze già dai tempi della COP1 di Berlino nel 1995. Malm ne traccia l’evoluzione attraverso tre cicli di lotte, ognuno maggiore del precendente. Il primo, tra il 2006 e il 2009, con la proliferazione dei campeggi climatici in Inghilterra e le prime azioni di massa contro le sorgenti di emissioni, dagli aeroporti ai distretti finanziari. Quel ciclo culminò con la COP15 di Copenhagen nel 2009, una debacle nonostante la mobilitazione di più di centomila persone e le promesse di accordi stringenti poi fallite miseramente. Il secondo, a partire dal 2011 negli Stati Uniti di Obama, dove il focus era sugli oleodotti in costruzione, affrontati sul campo dall’alleanza di ambientalisti e nazioni indiane, e che condusse all’immensa People’s Climate March di New York del 2014 per poi naufragare dinanzi all’elezione di Trump. Infine, il ciclo attuale, innescato dall’ondata di calore che ha cinto l’emisfero settentrionale nel 2018, quando Greta Thunberg ha iniziato i suoi scioperi del venerdì e Extinction Rebellion ha inaugurato la sollevazione bloccando Londra. La curva di crescita è stata ben visibile nei numeri, dalle migliaia ai milioni di partecipanti. Le mobilitazioni per il clima sono diventate un fenomeno di massa.
Ma a parte un aumento di consapevolezza e le promesse strappate con i denti ai governi, le emissioni aggregate non sono diminuite, al contrario. Attualmente, le emissioni di gas serra sono circa il 57% in più rispetto al 1990 e il 43% in più rispetto al 2000. Ancora nel 2018, due terzi di tutti gli investimenti di capitale in produzione di energia sono andati verso nuovi progetti di estrazione e combustione di petrolio, gas e carbone. Le multinazionali del fossile proiettano nei loro report una continua crescita del settore e dei relativi profitti. Sembra proprio che la forza di persuasione delle evidenze evapori davanti alla protervia del business-as-usual. Risulta palese che investitori e baroni del fossile non credono che il loro modello economico sia realmente in pericolo. Non temono le politiche climatiche degli stati o le rivolte al loro potere. Il movimento climatico ha elaborato un repertorio di azioni formidabile ma a parte piccole vittorie, niente sembra smuovere le politiche globali verso risposte all’altezza della crisi. Che sia arrivato il momento di osare di più? Forse, Malm ci invita a riflettere, è ora di passare all’offensiva.
IL DOGMA NON-VIOLENTO
Uno dei punti fermi del movimento climatico per come si è manifestato nelle ultime due decadi è la pratica della disobbedienza civile non-violenta. Dalle colline di carbone attraversate dagli attivisti di Ende Gelände all’asfalto dei terminal di gas di Göteborg, fino ai blocchi urbani di mezza Europa, la costante del movimento è stata la rivolta pacifica. Nelle piattaforme consensuali che i partecipanti sottoscrivono si specifica che non saranno inflitti danni alle infrastrutture, che non si risponderà alla violenza della polizia, che ci si comporterà “in maniera calma e misurata”. Tale autodisciplina ha contribuito senza dubbio alla crescita esponenziale del movimento. E continuare su questa strada, con blocchi pacifici da parte di masse sempre più grandi, magari decise a occupazioni semi-permanenti, ha un suo valore intrinseco e strategico che non va sottovalutato.
Eppure, se l’assoluta non-violenza viene accettata come unica via per abolire i combustibili fossili, e il mondo che vorremmo comunque non si materializza, come sta accadendo, bisognerebbe avere il coraggio e la lucidità di ripensare le strategie e di alzare il livello dello scontro. Il movimento che più di altri ha codificato in dogma la non-violenza è Extinction Rebellion. Non sulla base di un precetto morale: secondo i fondatori di XR, la non-violenza è la migliore strategia per rovesciare l’ordine delle cose, lo dicono la scienza (sociale) e la storia. Ciò li rende, nella definizione di Malm, dei pacifisti strategici. Parte dell’attrazione di XR è basata sul fatto che afferma di incarnare un attivismo scientifico. La sua autorevolezza discenderebbe dall’aver studiato tutti i metodi utilizzati nella lunga storia delle rivolte sociali, concludendo che solo la non-violenza funziona. Dall’abolizione della schiavitù, al movimento per i diritti civili americano guidato da Martin Luther King, alle suffraggette britanniche fino alla lotta contro l’apartheid in Sud Africa, passando naturalmente per Gandhi, secondo XR queste lotte epocali hanno avuto successo perché basate sulla scelta consapevole di non esercitare violenza verso cose e persone, per quanto odiosi fossero i poteri che combattevano. Tuttavia, il problema di questa narrazione è che non corrisponde alla verità.
Malm è uno storico e non può sottrarsi dal dedicare una parte consistente del suo libro alla decostruzione del mito della non-violenza come motore delle conquiste sociali. In tutte le lotte citate da XR, quei movimenti espressero in realtà delle ali radicali (radical flank) organicamente collegate alle masse pacifiche. Istruttivo in tal senso è il rapporto del movimento guidato da King con i gruppi militanti del nazionalismo nero, dai quali ci teneva a distinguersi pur se li considerava alleati. Oltre a fornire protezione contro gli attacchi del Ku Klux Klan, l’ala più agguerrita ebbe il compito cruciale di far apparire le richieste del movimento pacifico per i diritti civili il “male minore” agli occhi del governo americano, che infatti all’apice dei riot e dell’autodifesa armata dei neri si affrettò a fare delle concessioni per evitare un riflusso di attivisti pacifici ormai frustrati verso la militanza violenta. Se King negli anni Cinquanta appariva un radicale agli occhi dell’opinione pubblica americana, alla metà dei Sessanta era diventato il moderato che bisognava ascoltare per evitare la discesa nel caos. L’ala radicale aveva smosso lo stallo. Qualcosa di simile avvenne nella lotta dell’African National Congress contro l’apartheid in Sudafrica. La disobbedienza civile non-violenta era stata utilizzata per anni come tattica, con una sua propria funzione. Nel momento in cui la spinta civile non portava risultati, lo stesso Mandela contribuì a riorientare gli sforzi dell’ANC verso pratiche di sabotaggio dell’infrastruttura economica e militare dello stato bianco. Il movimento di massa crebbe galvanizzato da quegli attacchi, finché non si arrivò a una transizione pacifica.
Secondo Malm, la vera lezione della storia è che una diversità di tattiche, sinergiche e complementari, ha più opportunità di successo di un’unico metodo assunto per principio come un feticcio. Soprattutto, la storia ci invita a sfatare il mito del pacifismo strategico come sempre valido ed efficace. Le analogie hanno certo dei limiti, e la crisi climatica una portata e una temporalità peculiari, ma nulla impedisce di estrarre elementi dal passato utili a ricalibrare le strategie del movimento climatico, purchè lo si faccia onestamente.
TEMPO DI SABOTARE
Il tempo è la variable determinante dell’attuale congiuntura. Per avere una chance ragionevole di restare entro 1,5 gradi di riscaldamento come da accordi di Parigi, secondo i risultati di alcuni studi le società umane dovrebbero istituire da subito una proibizione globale per tutti i nuovi emettitori di CO2 e una moratoria sull’estrazione di combustibili fossili. Tale conversione dei governi e della finanza sembra attualmente impensabile, a dispetto dei patti e della prospettiva catastrofica in caso di falimento. Allora, propone Malm, è arrivanto il momento per il movimento climatico di prendere in carico questo compito, annunciando e attuando la proibizione. Questo sarebbe solo l’inizio: oltre alla proibizone, gli attuali grandi emettitori di CO2 (soprattutto industria e trasporti) dovrebbero essere decomissionati (almeno un quinto secondo un calcolo del 2018). Anche su questo, gli stati arrancano poichè, secondo Malm, “la proprietà capitalista ha assunto uno status di sacralità”. È questo l’incatesimo che va rotto. “La proprietà non esiste al di sopra della terra, e non ci sono ragioni tecniche, naturali o divine che la rendono inviolabile in questa emergenza”.
Nel concreto, sostiene Malm, gli oleodotti e i gasdotti vanno bucati, le centrali a carbone manomesse, la sabbia deve ingolfare i motori delle scavatrici che costruiscono il prossimo terminal di energia fossile, le fabbriche di fertilizzanti, di plastica, di auto vanno messe fuori uso, i prossimi aeroporti impediti. Una campagna di sabotaggio contro la proprietà implicata nelle emissioni fossili avrebbe due obiettivi: stabilire un disincentivo a ulteriori investimenti, e dimostrare che è possibile dismettere dal basso gli impianti. Lo scopo ultimo sarebbe forzare gli stati a proclamare il divieto e iniziare a chiudere lo stock esistente. Per Malm, la presa in carico da parte degli stati degli obiettivi del movimento climatico è imprenscindible: solo il potere statale può sradicare un sistema di produzione di energia innestato così in profondità nel corpo tecnico e sociale. Certo non un manipolo di sabotatori.
Un motto di Ende Gelände recita “siamo il rischio d’investimento”, ma pochi tra gli attivisti credono che un blocco pacifico di uno o due giorni, annunciato con largo anticipo, possa davvero scalfire l’apparato fossile. Il proliferare negli ultimi anni di climate camp con annessi blocchi alle infrastrutture è la fase più avanzata del movimento, la punta di lancia di campagne che durano anni e che testano tutti i terreni legali di lotta. Il campeggio climatico e i blocchi rivestono un valore simbolico innegabile nell’orientare il dibattito, come accaduto in Germania, e hanno un ruolo formativo nell’addestrare la prossima generazione di attivisti. Ma anche in Germania, quasi una decade di Ende Gelände è riuscita a strappare dal governo la promessa di fine del carbone solo entro il 2038.
La questione non è se un’ala militante del movimento climatico possa risolvere la crisi, ma se la spinta per alterare lo status quo del dominio fossile possa avvenire senza di essa. Il sabotaggio e la distruzione degli impianti emettitori di CO2 servirebbe a rendere fisicamente tangibile la minaccia dell’azione militante nell’assenza di politiche all’altezza della crisi. Tecnicamente, è già possibile. Il sabotaggio dell’industria fossile è stato centrale nella resistenza del MEND in Nigeria, degli Houti contro l’Arabia Saudita, degli iracheni contro l’occupazione americana, degli stessi egiziani contro il regime di Mubarak. Sono almeno due secoli che gli emettitori di CO2 sono attaccati e manomessi, ma è accaduto solo in rari casi che lo fossero in quanto tali, per il loro ruolo nel riscaldamento globale.
Attualmente, una forma di violenza politica particolarmente ripugnante è appanaggio delle destre xenofobe, dai killer suprematisti bianchi agli attacchi ai centri rifugiati e alle barche di migranti. Ma non deve essere così, e soprattutto la violenza, rigorosamente contro le cose, potrebbe essere messa al servizio di più nobili cause. È anche una questione di immaginazione. Malm racconta degli indiani metropolitani di cui ha fatto parte che scelsero come obiettivo i Suv delle aree ricche di Stoccolma. In una notte, ne riuscivano a mettere fuori uso una cinquantina. Poco efficienti, pericolosi e senza senso in città, questi mostri da strada sono stati indicati dalla ricerca come il secondo maggior contributore all’aumento delle emissioni globali di carbonio dal 2010 al 2018. Le vendite di Suv negli ultimi anni non hanno fatto che salire. Pochi obiettivi sono così chiaramente superflui, simbolicamente rilevanti e facili da sabotare.
Attaccare i simboli delle emissioni superflue si innesta in un’altro compito che secondo Malm spetta al movimento: rendere il consumo dei ricchi un elemento cruciale del problema climatico. Una minuscola parte della popolazione globale è responsabile della maggior parte delle emissioni dai consumi. I loro Suv, aerei privati e yatch sono delle fornaci di gas serra il cui scopo è segnalare lo status del possessore. E con l’inasprirsi delle condizioni climatiche, l’assottigliarsi del tempo utile e dei budget di carbonio, il consumo di lusso ad alte emissioni non ha più alcuna giustificazione. Non solo: il consumo superfluo e senza limiti costituisce anche il supporto ideologico dell’attuale assetto economico, è pubblicizzato senza ritegno, invocato come obiettivo personale e collettivo. “Un crimine spacciato per vita ideale”, ci dice Malm. Se bisogna iniziare a tagliare le emissioni personali, come si incita da più parti, i consumi di lusso sono i primi a dover sparire. Per le tonnellate di gas serra che comportano, ma soprattutto per il fatto di essere demoralizzanti nei confronti degli sforzi di mitigazione. Come possono gli stati chiedere sacrifici alle classi lavoratrici in nome della transizione verde quando si lascia che il segmento più ricco di popolazione si appropri del sempre più saturo spazio atmosferico collettivo? Ancora una volta, sembra difficile che gli stati capitalisti inizino a regolare il consumo dei ricchi. Più probabilmente, essi faranno ricadere l’ineludibilità dei tagli e dei costi per la transizione sulle classi lavoratrici. Esattamente quello che ha fatto Macron, proponendo una tassa sulle emissioni di carbonio che pesava cinque volte di più sul 10% più povero della popolazione francese rispetto alla sommità più ricca. Una tassa regressiva alle emissioni di sussistenza, che è impattata contro la furia dei gilet jaune in una delle sollevazioni di massa più intense e longeve della recente storia francese.
Quando ci libereremo del dogma, così laboriosamente inculcato e naturalizzato, che la proprietà è intoccabile? Rimane intoccabile quando esercita violenza verso le generazioni presenti e future, quando è abuso puro e semplice, quando impedisce il cambiamento? Maneggiare la violenza per obiettivi politici è estremamente controverso. La violenza dei subalterni nel discorso pubblico del tardo capitalismo in occidente è condannata senza appello. Malm lo sa bene. Per questo, occorre sgomberare il campo da qualsiasi equivoco potenziale: la violenza offensiva per avanzare la causa climatica deve essere esclusivamente contro gli oggetti e gli impianti, mai le persone. Colpire gli individui sarebbe l’inizio delle fine per il movimento. Allo stesso tempo, va anche rigettata l’equivalenza tra violenza contro le cose e violenza contro le persone, per la quale spaccare una vetrina o abbattere una recinzione viene giudicato alla stregua del terrorismo, in certi luoghi anche dalla legge oltre che dal senso comune. Ma un’auto o una centrale a carbone non soffrono, non vi è crudeltà implicata. Inoltre, il sabotaggio climatico non sarebbe orientato verso le condizioni materiali di sussitenza, la cui distruzione potrebbe mettere in pericolo delle vite. Lo status quasi trascendentale degli oggetti e della proprietà nella società capitalista ha innalzato un muro ideologico contro la possibilità di intervenire energicamente contro di essi. Ma nel vicino futuro, con il clima fuori controllo, questa cautela potrebbe essere vista come miopia, codardia e sconfitta.
Come, allora, declinare sabotaggio e vandalismo all’interno del movimento climatico? Malm propone un piano d’azione, con relativi paletti, obiettivi e modalità. “L’arte raffinata da dispiegare è quella della violenza politica controllata”. Primo, rifuggire da qualsiasi atto che metta in pericolo delle persone o che sia assimilabile a forme di terrorismo. Il capitale morale del movimento ne uscirebbe polverizzato. Secondo, sabotaggio e vandalismo non dovrebbero sostituire le manifestazioni di massa, la disobbedienza pacifica e in generale tutte le tecniche legali di protesta, resistenza e incitamento al cambiamento. Ne dovrebbe essere un prolungamento, un complemento, frutto della divisione del lavoro politico. La mobilitazione di massa non-violenta dovrebbe sempre essere la prima scelta, e non essere sospesa quando si ricorre a metodi di azione diretta contro le cose. Terzo, dovrebbe prendere in considerazione il livello di accettabilità da parte dell’opinione pubblica verso forme di violenza, ma non soccombere a esso. Tali livelli di recettività sono contingenti e relativi al contesto e alla situazione: in un mondo due o tre gradi più caldo, la percezione generale del sabotaggio potrebbe decisamente cambiare. In ogni caso, “il compito degli attivisti climatici non può essere quello di prendere un determinato livello di coscienza come dato, ma piuttosto di estenderlo. Dovrebbero avanzare davanti ma non troppo lontani dalle masse, il che li porterebbe all’isolamento; ma nemmeno in mezzo o indietro, il che precluderebbe la loro missione”. Quarto, questa avanguardia deve prepararsi a essere calunniata e sconfessata, anche dai propri alleati. Che il movimento pacifico prenda le distanze da atti di violenza e accusi i militanti di minare i propri sforzi è strategicamente necessario, poiché solo così potrà presentarsi al potere di turno come la parte rispettabile con cui negoziare. L’ala radicale dovrebbe agire non per sé, ma per far invitare i rappresentanti del movimento moderato al tavolo di discussione. È questa la divisione del lavoro: l’ala radicale porta la crisi a un punto di rottura, il movimento moderato offre una via d’uscita. Quinto, qualsiasi azione dovrebbe essere sabotaggio intelligente, cioè facilmente spiegabile e accettabile al maggior numero possibile di persone. La responsabilità dell’avanguardia è verso la propria comunità d’opinione, più vasta del movimento stesso che rappresentano. Il dovere è avanzare, non ritardare, la causa. Quindi determinati piani vanno estromessi quando diventa chiaro che si attirerà una rappresaglia o un imbarazzo insostenibili nei confronti di tutto il movimento.
La repressione attende questo tipo di azioni. Ma sarebbe un rischio diverso dal lanciarsi nelle braccia della polizia, come da piattaforma di XR. Una certa componente di sacrificio è inerente a tale progetto. Accettarlo anche a costo della libertà segnala che questa lotta vale la pena di combatterla nonostante tutto. A differenza di XR, bisogna chiamare il nemico chiaramente, far emergere la connotazione di classe del conflitto climatico, ammettere e difendere la scelta di voler cambiare lo stato di cose presenti. Il successo non è certo né probabile, ma possibile, e tanto basta per non abbandonarsi al fatalismo.
Sarà allora il sabotaggio a cambiare lo squilibrio di forze attuali? La lettura di How to blow up a pipeline è rinvigorente per il suo declinare la speranza nella forma di un calcio che sfondi la porta piuttosto che in educate richieste al potere. È un testo di cui si sentiva il bisogno, se non altro per suscitare discussioni strategiche interne al movimento climatico e per riesumare un’eredità del Novecento che sembrava seppellita: la teoria e la prassi rivoluzionarie. Ma non appena si volge lo sguardo dal piano generale ai contesti concreti in cui il sabotaggio dovrebbe darsi, non si può fare a meno di misurarne l’eccessiva fiducia nella sua efficacia e i potenziali effetti deleteri, politici e individuali.
IL RUOLO DEGLI STATI
Abbattere il fossile significa anche lottare per una diversa politica industriale: cancellare i sussidi alle attività ad alte emissioni, riorganizzare l’approvvigionamento energetico, allargare il controllo pubblico su produzione e consumi per realizzare la transizione verso emissioni zero. La controparte dei movimenti climatici che chiedono, o provano a imporre, tale transizione dal basso non può che essere lo stato. Ma cosa è rimasto del potere dell’apparato statale sulle dinamiche economiche dopo l’erosione di quarant’anni di neoliberismo? Cosa resta fuori dal comando dei capitali finanziari, per i quali si apparecchiano beni e diritti collettivi in cambio di briciole di lavoro? La pandemia ha mostrato chiaramente questo conflitto di priorità in seno agli stati capitalisti, che hanno pagato il ritardo nell’affrontare il virus con milioni di morti in più, nonostante abbiano poi interferito, quando la situazione si faceva critica, con le libertà personali e con la proprietà privata. Dopo i lockdown imposti per preservare la salute, non dovrebbero esserci più scuse per ritardare azioni decisive per preservare la vita in generale. Ma se non è bastata la pandemia per liberare gli stati dal controllo delle elite, allo stesso modo sembra arduo che questi stati possano concretizzare la resistenza al potere dei capitali fossili.
Guardando alle esperienze recenti che hanno cercato di rinsaldare la catena di trasmissione tra movimenti di base e rappresentanza politica, esemplificate da Bernie Sanders negli USA e da Jeremy Corbin nel Regno Unito, non si può che constatarne il fallimento contro la resilienza sia del liberalismo democratico che del populismo di destra, entrambi gli schieramenti ben voluti e finanziati dai capitali del fossile. Dove sarebbero le controparti che trasferirebbero i programmi dei movimenti climatici radicali sul piano dell’azione dei governi? Una lotta climatica che punti a catturare e guidare lo stato ha necessariamente bisogno di coordinare i conflitti ben oltre il clima, puntando alla ricomposizione dei fronti del lavoro, della sanità, dei diritti, sotto insegne abbastanza larghe da poter convogliare desideri e speranze collettive e abbastanza focalizzate da non perdere di vista gli obiettivi e la rapidità necessaria.
Anche se in Italia il movimento climatico appare meno strutturato che altrove, pur se altrettanto agguerrito, molto si può imparare dal radicato paesaggio di conflitti ambientali che attraversano il paese. Il sabotaggio e l’attacco a impianti e macchinari sono tattiche emerse in conflitti da nord a sud, ma sono state espressioni di lotte vertenziali e locali piuttosto che di un movimento globale. Due esempi vengono mente. In Campania, durante gli anni delle guerre dei rifiuti, dove la distruzione di macchinari e compattatori è stata un effetto dell’esasperazione popolare in contesti dove lo stato veniva solo ad aggiungere ulteriore inquinamento a condizioni sistemiche di povertà e marginalizzazione. Certe vittorie sono arrivate, in particolare a Pianura e Terzigno, quando si è riusciti a imporre tavoli di contrattazione (l’ala radicale creò effettivamente le condizioni per l’ascolto dei moderati) o anche a impedire progetti con la minaccia di sollevazioni violente. E la Val Susa, in cui il movimento No Tav rallenta da anni il progetto dell’Alta Velocità tramite azioni di sabotaggio mirate. In entrambi i casi, la repressione è stata durissima. In Campania i siti del ciclo dei rifiuti vennero militarizzati; in Val Susa e Piemonte, la digos si è distinta per arresti all’alba e misure di sorveglianza coatta. Ne è valsa la pena? Difficile dirlo, se si sconta il sacrificio personale dei militanti forse la risposta è che l’azione diretta ha sì avuto una funzione di difesa momentanea ma non è stata né risolutiva né dirimente. È mancato in questi casi un volano con un movimento di largo respiro capace di sfruttare gli spazi aperti dal sabotaggio? Siamo sicuri che il sabotaggio climatico non farebbe altro che suscitare forme ancora più perniciose di repressione? La questione è aperta.
Ma la critica più rilevante all’approccio di Malm affonda in una questione di carattere sociologico e storico. Nelle lotte epocali del passato dove la militanza violenta (verso le cose) ha avuto un peso fondamentale, i fautori dell’azione diretta vivevano sulla propria pelle le discriminazioni, le ingustizie e le sofferenze dei poteri che combattevano. Al contrario, gli attivisti climatici in occidente sono mossi dalla scienza, dalla consapevolezza e dall’opinione, non vivono (per ora) nel quotidiano gli effetti devastanti degli eventi meterologici estremi causati dal riscaldamento globale. Questi effetti sono già realtà nel sud del mondo, dove la questione della giustizia climatica è intrecciata alla lotta per i bisogni fondamentali necessari alla sopravvivenza. Pur se si assiste all’articolazione di campagne comuni, un fronte globale necessario a smuovere gli equilibri sembra ancora tutto da costruire. E proprio qui – nel lavoro politico che costruisca quella forza sociale che giustifichi l’intervento diretto e militante – ci sembra che vadano concentrati gli sforzi prima di alzare il livello dello scontro.
Siamo ancora nel mezzo di una pandemia di cui non si vede la fine. Allo stesso tempo, siamo ben dentro una crisi climatica per la quale le misure straordinarie necessarie a evitare la catastrofe sono ancora insufficienti. Se l’abusata metafora della guerra contro il Covid fosse filtrata da basi scientifiche più rigorose e applicata al clima, sarebbe chiaro che la vera battaglia planetaria riguarda il mantenimento di condizioni adatte alla vita e all’integrità della biosfera. Nella guerra contro i cambiamenti climatici, il virus rappresenta un mero proiettile e nemmeno il più pericoloso. Un effetto tra gli altri dello sfruttamento ecologico e atmosferico. Il merito del libro di Malm in questa congiuntura non è di offrirci un metodo risolutivo e definitivo, ma di espandere la nostra immaginazione politica e rinsaldare la memoria storica delle dinamiche del conflitto. Anche questa volta, come sempre, è nella pratica che la teoria sarà verificata o rigettata, e dalla pratica emergerà la strategia necessaria per il poco tempo che ci rimane. La disperazione non è un’opzione, anche se dovremo reimparare a lottare sotto un cielo che cade.
Questo articolo è stato pubblicato su Napoli Monitor il 22 febbraio 2021