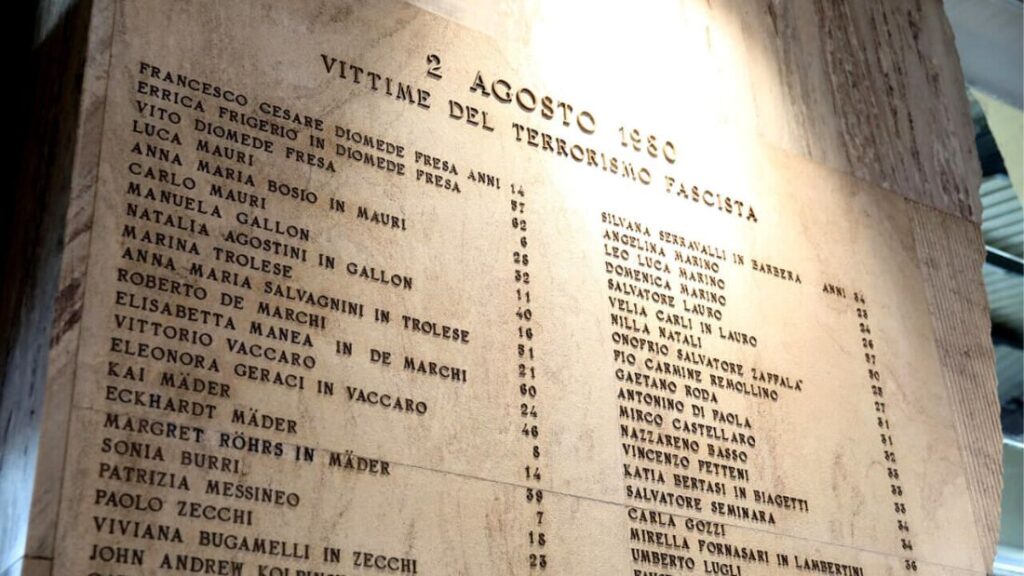Dieci anni dopo Monti, con Mario Draghi torna il «governo tecnico», una specialità italiana che segna l’ennesima morte della politica. L’élite economica prova così ad apparecchiare la tavola per gestire in modo diretto i soldi in arrivo dall’Ue
Il due febbraio è il giorno della Candelora, quando per tradizione si dovrebbe poter prevedere la fine dell’inverno. È il «giorno della marmotta» in cui è ambientato Ricomincio da capo, film del 1993 in cui il personaggio interpretato da Bill Murray è condannato a rivivere all’infinito la stessa giornata. Ed è parso a molti di rivivere le giornate dell’autunno 2011 – quelle dell’incarico conferito a Mario Monti dal Presidente Giorgio Napolitano – quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prendendo atto del fallimento del tentativo di ricomporre l’alleanza di governo tra Pd, M5S, Leu e IV, ha annunciato il varo di «un governo di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica», e dato l’incarico di formare il nuovo governo a Mario Draghi, ex governatore della Banca d’Italia ed ex presidente della Banca centrale europea.
Si prospetta all’orizzonte un nuovo governo tecnico, a dieci anni dall’esecutivo guidato da Mario Monti. Il clima mediatico è sorprendentemente simile: a due ore dall’annuncio di Mattarella, già si leggevano e si sentivano lodi sperticate all’«uomo che ha salvato l’Europa e ora salverà l’Italia» e si agitavano scenari apocalittici in caso di fallimento dell’operazione, dal ritiro dei 209 miliardi di Next Generation Eu al ritorno del rischio di default. Con ogni probabilità nelle prossime ore la pressione dei mercati e delle cancellerie europee si farà sentire con forza, magari attraverso il solito meccanismo dello spread, in modo da convincere anche i renitenti, nell’opinione pubblica e in parlamento, ad appoggiare Draghi. Tra i partiti, si fanno avanti con entusiasmo i centristi liberali, da Iv a +Europa passando per Azione di Carlo Calenda, mentre il Pd si affida a Mattarella, preparandosi di fatto ad appoggiare Draghi pur controvoglia, Fratelli d’Italia e M5S annunciano la loro contrarietà e Salvini dice tutto e il contrario di tutto per prendere tempo.
Il ritorno dei tecnici segna l’ennesima, periodica, «morte della politica» a cui l’Italia ci ha abituato nel corso degli ultimi decenni. Il meccanismo della rappresentanza resta inceppato, chi ha consenso non riesce a governare e viceversa, e il nodo si scioglie tagliandolo di netto, mandando al potere una squadra di autorevoli plenipotenziari priva di qualsiasi accountability democratica. Vedremo se riuscirà, nel frattempo l’esperimento del nuovo centrosinistra Pd-M5S è almeno temporaneamente fallito, e rischia di uscire triturato dall’esperienza di un nuovo governo tecnico. E l’élite economica apparecchia la tavola per gestire direttamente i soldi in arrivo dall’Ue, senza alcuna mediazione.
Il ritorno dei tecnici
«Un governo di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica». Le parole di Mattarella sono chiarissime. Ci vuole un governo tecnico, che, per quanto sostenuto formalmente da un voto di fiducia parlamentare per motivi costituzionali, non sia di fatto espressione di una maggioranza politica. Si tratterebbe del quarto governo tecnico della storia della Repubblica, dopo quelli guidati da Carlo Azeglio Ciampi (1993-1994), Lamberto Dini (1995-1996) e Mario Monti (2011-2013). Ancora una volta, come nel caso di Ciampi e Dini, sarebbe la Banca d’Italia a fornirne la guida.
Quella dei governi tecnici è una specialità tutta italiana. L’idea di un governo «che non debba identificarsi con alcuna formula politica» è impensabile in qualsiasi democrazia occidentale. Altrove esistono i governi «di grande coalizione», in cui forze politiche anche diverse trovano un compromesso e collaborano, come avviene tuttora in Germania ed è avvenuto in passato in vari paesi europei. Ma l’idea di un governo estraneo ai giochi della politica, e al principale tra essi, cioè la rappresentanza democratica, per quanto pienamente legittima sul piano costituzionale una volta che il parlamento attribuisce la fiducia, è aliena a qualsiasi normalità democratica.
In Italia, invece, si può fare, almeno nella Seconda Repubblica. Fu proprio un governo tecnico, quello guidato da Ciampi 28 anni fa, a mettere fine alla Prima. Il sistema dei partiti uscito dalla Seconda guerra mondiale era crollato, e ai tecnici fu chiesto di mettere al sicuro i conti pubblici e tenere in piedi la baracca mentre si preparava un nuovo assetto. Sono passati quasi tre decenni, ed evidentemente la transizione non è ancora compiuta: un meccanismo di rappresentanza democratica stabile nel tempo ancora non è all’orizzonte. La crescente tensione tra responsabilità e rappresentanza che caratterizza le democrazie liberali da ormai un decennio, secondo la celebre analisi di Peter Mair, da noi è rottura totale, ancora una volta. Non c’è una formula politica che riesca a conquistare il consenso e a governare.
Anche l’ultimo tentativo di ricostruire un assetto, quello del nuovo bipolarismo tra la destra salviniana e il nuovo centrosinistra Pd-M5S contiano, è andato a sbattere, e vediamo se sopravviverà a questa ennesima forzatura. In termini di salubrità democratica, non avevamo ancora smaltito del tutto le scorie del governo Monti, il cui principale risultato fu l’esplosione elettorale del M5S e, poi, della Lega. Se lo rifanno, come sembra, i danni rischiano di essere ben peggiori.
I primi elementi già si vedono, in termini di deterioramento del dibattito pubblico. Il coro mediatico è già partito nella santificazione tecnocratico-patriottica dell’eroe che torna dall’estero per salvarci, «l’italiano più famoso del mondo», una personalità a cui non è possibile dire di no. E il ritorno della retorica montiana si è portato dietro tutto il corollario: la tenuta dei conti pubblici come stella polare, il welfare definito «sussidi e mancette», la necessità di «fare le riforme di cui il paese ha bisogno», la fiducia dei mercati, lo spread, il rischio dell’insolvenza. Tutti temi che non erano all’ordine del giorno quando a essere in discussione era il governo Conte II, che poteva essere criticato e attaccato come qualsiasi esecutivo al mondo, e che riemergono ora, a proteggere da ogni accenno di dissenso il governo Draghi che ancora non c’è.
A spaventare è soprattutto questo: non tanto la sostituzione di un governo moderatamente di centrosinistra e strutturalmente non in grado di imprimere la svolta radicale che la fase richiederebbe, bensì il ritorno indietro al 2011, alla negazione di ogni spazio per il dibattito politico, al pensiero unico neoliberista nella sua versione più assoluta e opprimente. Non ci siamo mai illusi che Pd, M5S o lo stesso Giuseppe Conte fossero punti di riferimento della sinistra – basta vedere del resto l’endorsement del presidente di Confindustria Carlo Bonomi al ministro dell’economia uscente Gualtieri – ma su temi come il blocco dei licenziamenti, pezzi di welfare universale, una riforma fiscale in senso progressivo, negli ultimi anni in Italia si era iniziata a respirare un’aria diversa, che quantomeno stava iniziando a riaprire spiragli nel dibattito pubblico per un’opzione progressista. Il ritorno al passato, da questo punto di vista, sarebbe devastante.
«L’italiano più famoso del mondo»
Chiaramente Mario Draghi non è Mario Monti. Non è il commissario che arriva in Italia per implementare senza ostacoli la fase più violenta dell’austerità, dei tagli alla spesa pubblica, dall’attacco a pensioni e diritti del lavoro. Da presidente della Bce, anzi, si è conquistato una popolarità e una credibilità indiscutibili come protagonista di una politica monetaria espansiva, il programma di Quantitative Easing a sostegno del debito dei paesi dell’Eurozona. Nel marzo scorso, pubblicò sul Financial Times un articolo a supporto della necessità di fare debito pubblico per sostenere l’economia durante la pandemia. Posizioni che gli hanno permesso di essere spesso rappresentato come la «colomba» italiana che si contrappone ai «falchi» tedeschi nella governance finanziaria dell’Ue. Un ritratto che però collide con quello tratteggiato da Yanis Varoufakis nel suo libro Adulti nella stanza che ricostruisce il negoziato sul debito greco del 2015: ne esce un Draghi protagonista in negativo della gestione della vicenda greca.
Ci si può illudere che, una volta a Palazzo Chigi, ricordi gli insegnamenti del suo maestro Federico Caffè, che citava alla Sapienza nel 2010 assediato dagli studenti dell’Onda, ma appare improbabile. Del resto, Draghi fu anche il firmatario, insieme al suo predecessore alla Bce Jean Claude Trichet, della celebre lettera del 5 agosto 2011 in cui Francoforte dettava le condizioni al governo italiano: aumento della la concorrenza attraverso nuove privatizzazioni, contrattazione collettiva relegata a livello aziendale, facilitazione dei licenziamenti, pareggio di bilancio, aumento dell’età pensionabile, blocco del turnover e taglio degli stipendi nel pubblico impiego, spending review… Una «colomba» col becco affilato, insomma, se si parla di austerità.
A essere cambiato rispetto al 2011 è il ruolo dell’Ue: dieci anni fa, il quadro dominante era quello dell’austerità, e Monti arrivava per tagliare, mentre oltre siamo nella fase del Recovery Fund, e Draghi arriva per spendere 209 miliardi di euro, tra finanziamenti diretti e prestiti. Mentre la popolarità di Monti si andò rapidamente a schiantare contro misure come la riforma Fornero delle pensioni, Draghi potrebbe avere margini per costruire consenso intorno a politiche di investimento se non di redistribuzione. Tecnico non deve per forza significare macelleria sociale, quantomeno non in partenza. Le risorse del Next Generation Eu, d’altra parte, non vanno ingigantite, e andranno principalmente a sostenere spese che sarebbero state fatte comunque, seppure a debito.
In ogni caso, un governo privo di accountability democratica, un governo che non deve rispondere a nessuno se non a un parlamento apertamente delegittimato dalla scelta stessa di affidare l’esecutivo a personaggi esterni alla politica, resta un governo potenzialmente molto pericoloso per le classi popolari. La logica del «coraggio di fare le riforme impopolari che i politici non possono fare» è strutturalmente autoritaria e classista: presuppone che il consenso popolare, in particolare dei settori sociali non abbastanza «illuminati» da saper riconoscere il bene economico supremo, sia un fattore di corruzione e distorsione delle decisioni politiche, e non, invece, l’elemento fondamentale di una politica democratica.
In questo, va detto, l’annuncio dell’incarico a Draghi è una vittoria di Matteo Renzi e del pezzo di establishment economico e mediatico che ha sostenuto la sua offensiva delle ultime settimane. Il «governo dei migliori» tante volte evocato da Carlo Calenda sembra in arrivo. Ancora una volta, come già avvenuto nel 2011, l’élite economica, infastidita dalla presenza di una mediazione politica tra i propri desideri e le necessità della maggioranza delle persone, passa all’offensiva. Non è che con Conte fossero fuori dai giochi: tutt’altro, come dimostra la gestione della seconda ondata della pandemia. Ma la politica genera strutturalmente attrito, e proposte come il salario minimo o la patrimoniale, per quanto ben lontane dall’essere concretizzate, continuavano ad aleggiare, per non parlare del blocco dei licenziamenti. La tentazione di saltare la mediazione normalmente affidata a personaggi più o meno carismatici, da Silvio Berlusconi a Giuseppe Conte passando per Matteo Renzi, e prendere direttamente il potere, è sempre in agguato. Vedremo se il governo Draghi nascerà e quale sarà la sua composizione, ma di certo un’interlocuzione privilegiata, per il mondo della grande finanza, è assicurata: del resto, tra il 2002 e il 2005 Draghi è stato dirigente e azionista di Goldman Sachs, una delle più importanti banche d’affari al mondo.
L’impotenza della politica, la politica dell’impotenza
Dei tre maggiori partiti italiani, solo uno, il Movimento Cinque Stelle, per bocca del capo politico Vito Crimi, si è espresso in modo nettamente contrario alla formazione del governo Draghi. Il segretario del Pd Zingaretti ha ringraziato il Quirinale per un’iniziativa che «ha posto rimedio al disastro provocato dall’irresponsabile scelta della crisi» e ha annunciato che i dem saranno «pronti al confronto per garantire l’affermazione del bene comune del Paese». Ancora più ambigue le parole del leader della Lega Matteo Salvini, che in una lunga diretta Facebook ha continuato a chiedere le elezioni ma allo stesso tempo si è dichiarato disponibile a un governo Draghi, seppure di breve durata e lasciando libera la Lega di portare avanti le proprie battaglie.
L’impressione è che Pd e Lega sappiano bene che dire di no a Draghi significa lanciare un messaggio di ostilità alle istituzioni Ue, ai governi europei e al mondo della finanza. Entrambi danno l’impressione di non volere questo governo ma di non aver alcuna intenzione di opporvisi apertamente. Il Pd, in particolare, pare tornato vittima della sua storica sindrome da «responsabilità istituzionale» che già lo portò a un crollo di consensi senza precedenti negli anni di Monti. Da una parte c’è la difficoltà di sottrarsi a un tentativo accompagnato da un alone di inevitabilità come quello di Draghi, dall’altra il timore che, come avvenuto dieci anni fa, possa essere l’opposizione, incarnata in questo caso dalla destra di Giorgia Meloni, se non di Salvini, a capitalizzare la futura impopolarità del governo tecnico. L’impressione è che nessuno voglia questo governo ma che in fondo possa fare un po’ comodo a tutti non assumersi direttamente la responsabilità dell’esecutivo in questa fase.
Il Movimento Cinque Stelle è particolarmente sotto pressione: per il partito uscito vincitore dalle elezioni del 2018, lasciare il governo, dopo esserci stato sia con la Lega sia con il Pd, sarebbe una sconfitta. Ma, per quanto trasformato in senso governista, può il M5S populista nato dal V-Day ed esploso nell’opposizione a Monti sostenere un governo tecnico guidato da Draghi? In un senso o nell’altro, ogni scelta sarà dolorosa e sancirà di fatto la sconfitta dal tentativo della scalata grillina alle istituzioni.
A sinistra, non si registrano per ora prese di posizione né del gruppo parlamentare di Liberi e Uguali, né dei due partiti (Sinistra Italiana e Articolo1-Mdp) che lo compongono, e c’è da scommettere che l’eventualità di sostenere o meno il governo sarà un elemento di divisione interna, soprattutto se Pd e M5S dovessero prendere strade diverse. E questo è forse il punto politico più evidente di queste ore: se lo scopo di Renzi era far saltare il governo Conte per far saltare il nuovo centrosinistra che a suo sostegno si stava costruendo come unica alternativa credibile alla destra salviniana, va detto che è stato raggiunto. Se il Pd sostenesse Draghi e il M5S no, Renzi avrebbe fatto esplodere la coalizione e potrebbe ora portare avanti liberamente il suo tentativo di costruzione di un polo liberista macroniano, verso cui attrarre vasti settori del Pd come di Forza Italia, per diventare nel tempo l’unica alternativa alla destra reazionaria.
Uno scenario tutt’altro che concreto, ma che il governo tecnico senza dubbio avvicinerebbe. Una politica impotente e sotto ricatto, pesantemente delegittimata, si trova un’altra volta a subire scelte fatte altrove e a sostenere un governo non espressione di alcuna rappresentanza democratica e nessun radicamento sociale. Ma se ciò avviene, non si può non ricordarlo, è perché questo nuovo centrosinistra si è sciolto come neve al sole di fronte all’attacco renziano e confindustriale, non essendosi costruito nessuna reale base sociale di consenso nelle classi popolari. In tanti hanno twittato contro Renzi, ma nessuno è sceso in piazza per Conte. Esattamente come dieci anni fa, l’offensiva della tecnocrazia liberista non si trova di fronte organizzazioni democratiche di massa, profondamente radicate nella società e forti della popolarità di un programma di avanzamento sociale chiaro e credibile (redistribuzione fiscale, welfare universale, riduzione dell’orario di lavoro, conversione ecologica dell’economia, parità salariale, congedo parentale universale, matrimonio egualitario), bensì un centrosinistra impegnato a mediare sulla gestione dell’austerità.
Sappiamo come finì allora. Dal crollo di quel centrosinistra nacque l’esplosione elettorale del M5S: non si intravedono, oggi, forze organizzate in grado di giocare un simile ruolo. Le opportunità per la mobilitazione sociale e la sua verticalizzazione politica non mancheranno: la marmotta, per ora, si limita a indicare che l’inverno sarà ancora lungo.
Questo articolo è stato pubblicato su Jacobin Italia il 3 febbraio 2021