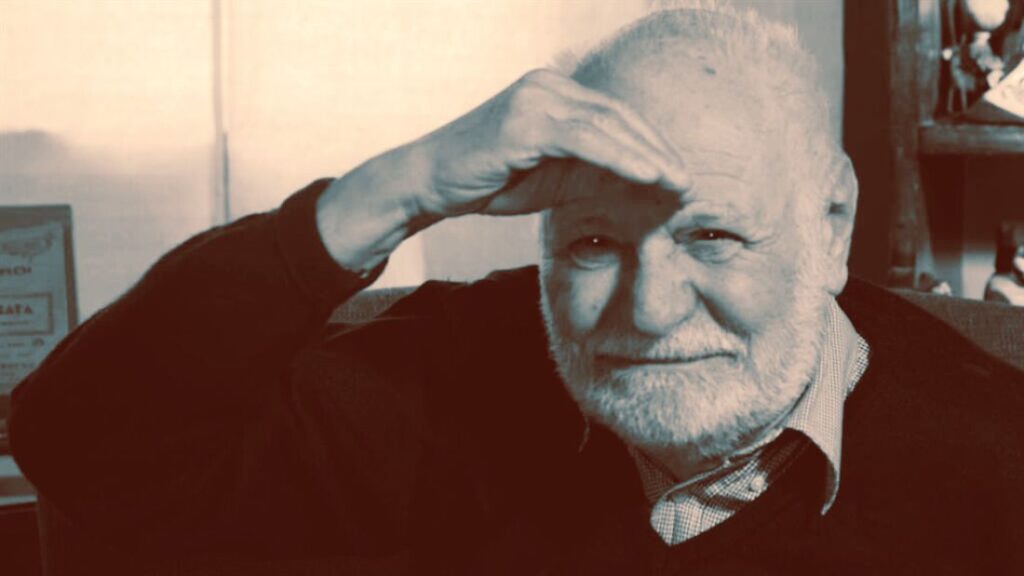“La democrazia è preziosa e fragile, ma qui, in questo luogo sacro che hanno cercato di colpire al cuore, la democrazia ha prevalso”, anche se “c’è tanto da riparare e da guarire”. Preziosa e fragile, dice Joe Biden. Mai data una volta per tutte, aveva detto Kamala Harris la sera della vittoria: dipende da noi, sempre e ogni giorno; è una cosa che si fa nel farsi. Finalmente insediato nell’assenza belligerante del suo predecessore, Biden poteva scegliere toni più trionfali per rinverdire il mito della democrazia americana a pochi giorni dall’assalto trumpista a Capitol Hill. Ma non li sceglie e fa bene: mostra la ferita, dice che va curata e che non sarà facile, nomina uno a uno i pericoli incombenti – il suprematismo bianco e il terrorismo interno, il razzismo sistemico e il falso sistematico – che bisognerà combattere e sconfiggere. Qualcuno prevede anni di piombo, i commentatori li chiamano proprio così appropriandosi del copyright italiano. E perfino lo spettro della guerra civile viene evocato due volte durante la cerimonia di Washington, quando prima Amy Klobuchar poi lo stesso Biden ricordano che la cupola del Campidoglio fu voluta da Lincoln proprio durante la guerra civile, “e anche allora alla fine abbiamo avuto la meglio”.
Ne aleggia un altro, di fantasma, quello del presidente uscente che con la sua assenza fora la sequenza degli ex presenti – Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama con relative first ladies – come a porsi esplicitamente fuori da una genealogia istituzionale bipartisan. Il populista antisistema si chiama fuori dal sistema, ma prima di salire per l’ultima volta sull’air force one in direzione Florida promette di tornare in qualche modo e annuncia che il suo movimento è solo agli inizi. Suona come l’ennesima bugia, perché quando i capi populisti cadono solitamente crollano; ma crollando possono fare ancora molto male. E lasciano effettivamente “tanto da riparare e da guarire”. Chi rompe non sempre paga, e i cocci non sempre sono suoi.
Kamala Harris però, che la notte della vittoria era vestita di bianco che è il colore delle lotte femministe, stavolta è in monocolore viola, perché il viola condensa il rosso e il blu e sta lì a significare che bisogna riunire e ricucire quello che Trump ha diviso e strappato. L’omaggio alla genealogia femminile stavolta è affidato a un filo di perle, citazione da quello che portava sempre Shirley Chisholm, la prima donna nera eletta al congresso; e poi alla presenza di per sé eloquente di sette donne di etnie diverse che salgono sul palco prima di lei, comprese Lady Gaga che canta statuaria l’inno nazionale, Jennifer Lopez – stavolta è lei in total white – che canta in spagnolo libertà e giustizia, Amanda Gorman, 23 anni e già un mito vivente, che porta sul palco in diretta con i suoi versi l’impronta politica di black lives matter. Più di così è difficile esplicitare la simbologia dell’America che riparte dalla pluralità e dalle lotte per i diritti, e investe senza se e senza ma sulla rivoluzione femminile come coronamento e compimento della fondazione democratica. Barack e Michelle (total red) assistono discreti in prima fila e non si può non pensare al sentiero interrotto del sogno del 2008 che dopo l’incubo che ne è seguito si dà oggi una seconda chance. Dove che vada, l’America corre sempre veloce: sogno o incubo, si sveglia in fretta e cambia ciclo politico. Vista dall’Europa lenta e sonnolenta, fa sempre un certo effetto.
Stavolta però non ci sarà l’indimenticabile ballo pieno di erotismo della coppia presidenziale che suggellò la festa del 2008, perché l’erotismo è stato tacitato da un virus che ci distanzia e la sigla dell’epoca sono le mascherine incollate sul viso. Vuota di popolo, presidiata da 26mila soldati sotto un cielo livido e un freddo polare Washington ha l’aspetto metafisico di tutte le città svuotate dalla pandemia che ci siamo abituati ad abitare con mestizia. Eugene Goodman, l’agente afroamericano che durante l’adunata sediziosa dell’Epifania ha depistato gli aggressori e preservato i senatori, scorta sul palco Kamala Harris come l’angelo vendicatore di George Floyd, terzo fantasma che aleggia e domanda giustizia e redenzione. Forse a questo serve stavolta la pur consueta ritualità religiosa della cerimonia dell’insediamento: a far affiorare i sensi di colpa – perché l’innominato non sarebbe potuto arrivare alla Casa Bianca senza le colpe e i peccati dei democratici – e a cercare la strada della redenzione politica.
Anni interessanti
Per questo gli anni di Biden non potranno essere un semplice ritorno a com’eravamo, come lui stesso li aveva prefigurati all’inizio della sua corsa elettorale: le ferite intercorse sono troppo profonde e i segni troppo allarmanti per poter essere coperti dal velo rassicurante di una normalità ritrovata. E quei nativi bianchi arrivati a Capitol Hill da ogni dove, il giorno dell’epifania della crisi della democrazia occidentale, a imporre la loro legge suprematista contro la legalità costituzionale, restano in giro per il paese come mine vaganti mentre il loro capo si gode al sole a Mar-a-Lago lo spettacolo della prima cerimonia d’insediamento da 152 anni in qua senza il galateo istituzionale del passaggio del testimone tra i presidenti e tra le first lady. Biden lo sa ed è per questo che firma executive order a raffica immediatamente dopo il giuramento, a dimostrazione dell’urgenza di una discontinuità esplicita e polemica. Che non mancherà di essere divisiva, a dispetto dei proponimenti unitari su cui il nuovo presidente torna e ritorna nel suo discorso. Il moderato Biden, “sleepy Joe”, potrebbe trovarsi trascinato dal vento della storia a scelte più radicali di quanto i suoi fan centristi sparsi nel mondo, Italia compresa, si aspettano da lui.
Si annunciano anni poco prevedibili e pochissimo normali. Ma intanto, il ciclo del populismo di governo negli Stati Uniti è finito. È stato un incubo, ma è durato solo quattro anni. In Italia, in variegate versioni, dura da più di venticinque.
Questo articolo è stato pubblicato su Internazionale il 22 gennaio 2021