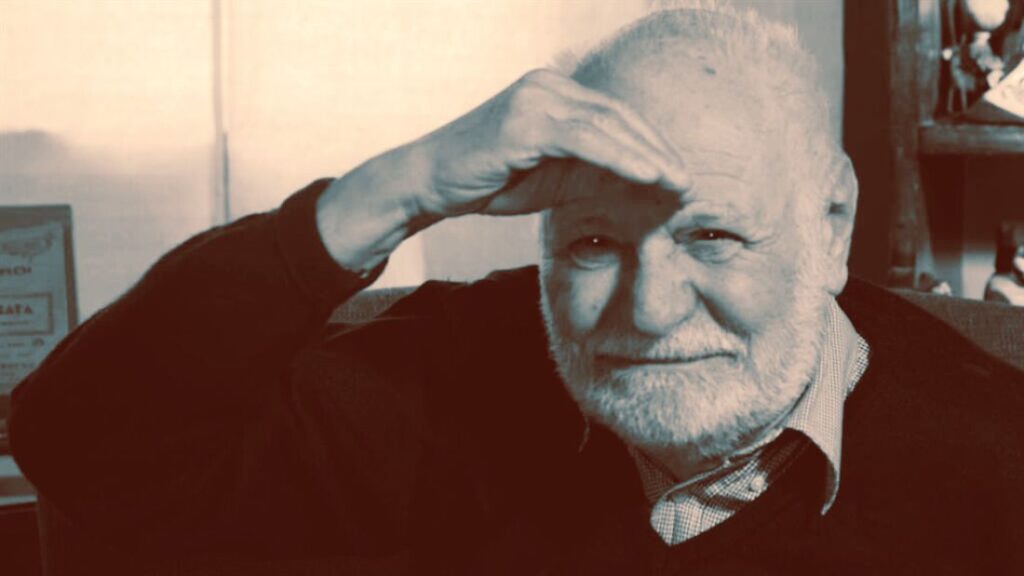Questo diario di viaggio, iniziato in Chiapas nell’estate del 2017 e portato a compimento due anni più tardi nell’appennino bolognese, rappresenta la rivisitazione narrativa e divulgativa di una tesi magistrale che ha interrogato i rapporti di mutua determinazione tra paradigma socioeconomico e sistema educativo. Focalizzato sulle implicazioni in campo formativo del cammino zapatista verso l’autonomia, intende condividere – attraverso l’approfondimento in una prospettiva soggettiva di alcuni esempi concreti – spunti teorici e pratici per la realizzazione di esperienze di apprendimento inerenti a una forma di vita e organizzazione sociale post-capitaliste. Qui l’episodio I.
Episodio II – Hacia la esperanza
Per 7 pesos uno scalcinato furgoncino collettivo, sfrecciando tra le bancarelle e i venditori ambulanti al ritmo della miglior cumbia villera, mi porta dal mercato di San Cristóbal al CIDECI. Un ragazzino corre ad aprirmi il cancello, per poi tornare dagli amici raccolti intorno a un fuoco e a una sigaretta. Nel cortile due ragazze tengono un banchetto con dei libri, un altro serve caffè e pane dolce dietro a una cassetta delle offerte. Un impianto acustico diffonde nell’aria un sottofondo di musica classica, creando un’atmosfera di ovattato raccoglimento. Al centro della sala in cui si svolgono i seminari campeggia un’imponente tavola di legno, intagliata con motivi maya e circondata da sedie modello Santa Inquisizione – di quelle che ti costringono ad assumere un’aria grave e una seduta composta. Fortunatamente, lungo le pareti corrono panche più sobrie (e comode) su cui mi affretto a prendere posto. Oltre a me, i presenti sono una quarantina: alcuni chiacchierano amabilmente, altri ripassano in silenzio quaderni zeppi di appunti. Scorro lo sguardo sulle pile di volumi che affollano le pareti, lascito dell’antropologo francese Andrés Aubry dopo una vita dedicata allo studio della cultura e della resistenza dei popoli indigeni del Chiapas. Fondatore su invito di don Samuel dell’Istituto di Consulenza Antropologica per la Regione Maya (INAREMAC), Andrés criticò aspramente la fissazione dei ricercatori sui propri oggetti di studio, così come una certa attitudine “estrattiva” alla costruzione del sapere, rea di aver allontanato gli studiosi dalle problematiche reali facendo della finalità del loro lavoro un prodotto individuale, in luogo di una trasformazione della coscienza collettiva e del sistema sociale. Solidale con le istanze della lotta zapatista, tanto da figurare tra gli intellettuali che presero posizione al fianco dell’EZLN nel corso dei negoziati con il governo, Andrés sostenne fermamente la necessità di reintegrare la dimensione etica all’interno delle pratiche scientifiche: «Ciencia sin conciencia no es ciencia», affermò fino alla fine. Nel 2007 perse la vita in un incidente d’auto, proprio nell’atto di recarsi a uno di questi seminari. A riprova dell’impegno riversato sul campo e dell’affetto che nutriva presso la comunità, in un angolo spicca un enorme manifesto con una nomina a dottore “liberationis conatus causa” intestata a suo nome, sottoscritta da centinaia di firme in rappresentanza del CIDECI e dell’EZLN.
Il seminario ha inizio con una breve presentazione dell’esperienza dell’UniTierra, cammino di pensiero critico e antisistemico iniziato nel marzo 2006. Nell’introduzione non si manca di menzionare l’imminente anniversario della scomparsa dei 43 studenti della scuola rurale di Ayotzinapa, bloccati dalla polizia mentre cercavano di raggiungere una manifestazione e fatti sparire in circostanze mai chiarite. La vicenda, continuamente insabbiata dalle autorità governative, ha suscitato numerose controversie e mobilitazioni in tutto il mondo.
Miguel, che coordina l’incontro, riassume in tzotzil e castigliano gli articoli in discussione. Dà quindi il via a un primo giro di interventi, ponendo a conclusione di ciascuno di essi un sentito «Gracias, companer@». I discorsi vanno concentrandosi sul concetto di “indigenizzarsi” proposto in un articolo apparso su “La Jornada” da Gustavo Esteva. Quest’ultimo, intellettuale radicale di Oaxaca che suole definirsi “de-professionalizzato” in onore dell’amico e maestro Ivan Illich, invita a sentirsi tutti coinvolti dalla decisione del CNI di partecipare alle prossime elezioni presidenziali, contrapponendo all’idea violenta e possessiva di patria il sentimento elettivo e amorevole per una matria. Baschet, un allampanato professore che scopro aver scritto di iconografia medievale e alternative al capitalismo, solleva qualche perplessità in merito a siffatta proposta: a suo avviso corre il rischio di scadere in un’impostazione da “selvaggio west”, per cui chiunque dichiari la propria appartenenza a un lembo di terra può arrogarsi il diritto di difenderla da presunti invasori… Raymundo, in segno di approvazione, applaude vigorosamente.
Quando nessuno di nuovo sembra più intenzionato a intervenire, si procede con un secondo giro di considerazioni. È a quel punto che un’anziana abbigliata con abiti tradizionali indigeni, i capelli raccolti in due lunghe trecce d’argento, prende parola: a gran voce, afferma di non vergognarsi di quello che è, della sua identità e delle sue radici, nonostante le umiliazioni puntualmente subite «dai grandi imprenditori, dai grandi capitalisti, da los que estudiaron»… Quest’ultima invettiva riecheggia nell’aria, colpendomi dritto al cuore. Nel silenzio che segue, il frinire dei grilli annuncia la venuta della notte. «Se non ci sono altri interventi, possiamo salutarci», conclude lapidario Miguel.
In verità, le discussioni proseguiranno due giorni dopo: è il primo sabato del mese, giorno del seminario “Wallerstein”, basato sulla lettura e sul commento condiviso di un libro proposto il mese precedente da uno dei partecipanti. Il nome omaggia lo studioso statunitense celebre per aver adottato un approccio interscientifico e contribuito allo sviluppo dell’analisi dei sistemi mondo, che indaga il funzionamento dell’economia globale secondo una complessa rete di rapporti tra centri e periferie. A lui si deve un’acuta critica dei fondamenti ideologici della civiltà capitalista: da un lato il razzismo/sessismo, che nell’ancorare a determinate categorie di persone una posizione sociale svantaggiata giustifica un bilancio peggiore per la maggioranza; dall’altro l’universalismo, che con l’appoggio della cultura scientifica e dell’illusione meritocratica ha esteso il capitalismo su scala globale e giustificato un bilancio migliore per la minoranza. Apparentemente indifferente a tutto ciò, un bambino esibisce con orgoglio i suoi pochi giocattoli ai più e meno adulti presenti in sala. «Ma non si fracasserà le palle?», non posso fare a meno di pensare; tanto più che al seminario di oggi si discutono due testi parecchio impegnativi, assemblati e stampati in un libro per l’occasione dalla tipografia del CIDECI. Il primo, uno scritto di Rubel su Marx teorico dell’anarchismo, riflette lo spirito eclettico che ha contraddistinto fin dagli albori il movimento neozapatista, originato dall’incontro tra uno sparuto gruppo di guerriglieri di ispirazione guevarista, provenienti dalle sbandate Fuerzas de Liberación Nacional, e i popoli indigeni del Chiapas, con la loro storia secolare di oppressione e ribellione. Il secondo invece consiste nell’epilogo del volume di Agamben L’uso dei corpi, intitolato Per una teoria della potenza destituente. A partire dalle categorie formulate in tale contributo filosofico, ci si interroga sulla candidatura della “vocera” Marichuy ad opera del CNI: tale operazione rappresenta una pericolosa forma di cooptazione istituzionale – un’eccezione includente, appunto – o può qualificarsi come dispositivo destituente, potenzialmente in grado di inceppare la macchina ontologico-politica dell’Occidente?
«Staremo a vedere», risponde calmo Estéban, il responsabile della nostra permanenza al municipio ribelle autonomo de La Realidad, quando gli chiediamo cosa ne pensi della partecipazione del CNI alle elezioni proposta e appoggiata dall’EZLN. Qui, nel cuore dei territori autonomi zapatisti, sono ben distanti dalle sofisticate elucubrazioni cittadine: le considerazioni che avanzano riflettono umiltà e senso pratico. Eppure, durante il discorso tenuto lo scorso 1° gennaio nell’anniversario della insurrezione zapatista, il subcomandante Moisés ha presentato questa mossa come «última esperanza» per il riconoscimento dei diritti dei popoli originari a livello nazionale e globale. Dopo la deriva degli accordi di San Andrés, mai ratificati dal Congresso Messicano, gli zapatisti reagirono al voltafaccia interrompendo ogni contatto con il governo per applicare unilateralmente i principi dell’autonomia. Assunsero così la gestione dell’educazione, della salute, della giustizia, della produzione e della distribuzione delle risorse. Con il progressivo trasferimento dei poteri dalle autorità militari a quelle civili, nell’agosto del 2003 diedero vita a 5 caracoles, centri intermunicipali di autogoverno. In essi si riunisce la giunta di buon governo, un’autorità collegiale, revocabile e rotativa chiamata ad esprimersi sulle principali questioni di interesse pubblico. L’immagine del “caracol”, la chiocciola, rimanda al punto di unione delle comunità autonome con il mondo: dall’interno verso l’esterno e dall’esterno verso l’interno, in uno scambio continuo che vuole simboleggiare la relazione ideale dei popoli zapatisti con il Messico e con il mondo.
Nonostante i notevoli traguardi ottenuti sulla strada dell’autonomia, inimmaginabili e presi da esempio da tanta parte dei movimenti sociali globali, al villaggio si respira parecchia amarezza. Di 210 famiglie, solo un terzo sono rimaste zapatiste; le altre hanno via via ceduto alle pressioni dei paramilitari o alle lusinghe dei programmi di sussidio governativo, che distribuiscono beni di consumo, materiali edili e scolastici esclusivamente a quanti appoggiano le formazioni partitiche. «Ancora non siamo riusciti nel nostro compito», dichiara Estéban sconfortato. Quando suo figlio gli domanda perché i ragazzi dell’altra scuola hanno la camicia e i pantaloncini, risponde: «Perché usano i soldi del governo per comprarsi le scarpe e i vestiti, e sono tutti uguali perché sono tutti ugualmente sotto controllo».
Con la sollevazione in armi e l’allontanamento dei maestri federali, nelle comunità zapatiste si è assistito a un processo di riappropriazione e reinvenzione dello spazio scolastico e della funzione docente. Le comunità cercarono al proprio interno le risorse per provvedere all’educazione dei giovani, così da superare la differenziazione sociale che aveva caratterizzato fino a quel momento i maestri ufficiali, poco interessati e rispettosi dello stile di vita indigeno. Si decise quindi di nominare e capacitare dei “promotores de educación” che operassero su mandato della comunità, in linea con i principi da essa stabiliti. Per supportarne l’operato vennero istituite delle apposite commissioni, con il compito di fornire supervisione educativa, una formazione adeguata, guide per orientare il lavoro e proposte per le nomine dei promotori. Questi, a riconoscimento dei servizi prestati alla comunità, ricevono annualmente un dato quantitativo di viveri (per esempio, 16 zontes di mais – circa 400 pannocchie – e 12 latte da 16kg di fagioli), nonché appoggio economico nei momenti di capacitazione.
Nel rispetto dell’idea di autonomia, ogni comunità è rimasta libera di adottare le soluzioni ritenute più congeniali dal punto di vista didattico ed educativo, ragion per cui nei territori zapatisti si riscontrano varie differenze nella maniera di impostare e gestire la scuola. Generalmente, le materie di studio sono state riorganizzate in quattro “aree di conoscenza”: Lingue, Matematica, Storia, Vita e ambiente. All’insegnamento del castigliano si affiancò e rinforzò quello delle lingue native, Storia fu integrata dallo studio delle vicissitudini del movimento zapatista, Vita e ambiente si arricchì degli elementi propri della cosmovisione indigena. Spesso le lezioni oltrepassano le pareti delle aule per svolgersi nel contesto della vita comunitaria: i nonni diventano maestri di storia condividendo leggende e aneddoti locali, la stagione della semina mette alla prova le nozioni di algebra e geometria.
Il calendario scolastico varia in funzione della disponibilità dei promotori, del calendario agricolo e delle festività locali, spesso animate dagli stessi alunni con balli e spettacoli. A La Realidad si fanno tre giorni di lezione a settimana, gli altri servono ai promotori per lavorare i propri campi e ai ragazzi per aiutare i genitori a fare lo stesso. Questa impostazione risponde, prima che a lungimiranti intuizioni pedagogiche, alle concrete leggi delle necessità materiali: l’alimentazione si basa quasi esclusivamente su fagioli, mais e riso; si cucina sul focolare, si dorme in capanne di legno e lamiera e ci si lava al fiume. La baracca in cui siamo ospitati è uno dei pochi luoghi dotati di corrente, tanto che Estéban a ogni visita ci chiede gentilmente il permesso di ricaricare la torcia elettrica.
Mi torna in mente la mia visita alla comunità di appoggio zapatista di San Isidro… Dopo un viaggio accidentato sul retro di un autocarro sopra le foreste nebulari di Los Altos, accolto dagli abitanti del villaggio mi sentii dire: «Grazie per lo sforzo di venire fin qui. Per noialtri è impossibile raggiungerti là dove stai!». L’abuelita Caterina mi aveva poi condotto a spasso tra i campi, mostrandomi la differenza tra il loro mais, con la sua molteplice e disordinata esuberanza, e quello OGM dei vicini, tanto perfetto quanto seriale. Giunti a casa sua, un’abitazione spartana con poco più che un giaciglio e un focolare, aveva sentito il bisogno di scusarsi: «Non è molto, soy pobre». «Quello che avete può non sembrare molto, ma è molto poiché è tutto ciò che vi occorre per essere liberi», avevo risposto con una retorica un po’ stucchevole, ma nutrita di sincera ammirazione. Per l’occasione avevano cucinato brodo di pollo selvatico, che ovviamente non avevo potuto rifiutare. Le mie difese erano crollate quando, dopo aver espresso un apprezzamento per l’aspetto di un gallo selvatico, avevano esclamato compiaciuti: «Ya està listo por el plato!».
Al villaggio raccontano che, ai tempi del levantamiento in armi, la vita di un indigeno in Chiapas valesse meno di quella di una vacca. Per certi versi è ancora così, considerato che il possesso di un animale continua a rappresentare una delle forme più solide di investimento economico. Tuttavia, quando nel 2014 i paramilitari ammazzarono il maestro Galeano, una figura portante della comunità e dell’esperienza dell’escuelita zapatista, l’eco dell’accaduto si riverberò in tutto il mondo. Al grido di «giustizia e non vendetta» il subcomandante Marcos aveva dismesso per sempre il suo nome e l’alone leggendario che l’aveva ammantato per assumere quello del compianto compañero. La lotta zapatista non aveva più bisogno di fare affidamento su un leader carismatico, nient’altro che un ologramma utile a catturare l’attenzione mediatica e le simpatie occidentali. Da quell’episodio, in collaborazione con l’organizzazione per la difesa dei diritti umani “Fray Bartolomé de Las Casas”, il caracol della Realidad accoglie al suo interno degli osservatori internazionali. È in questa veste che io e una simpatica coppia argentina di Rosario siamo arrivati qui. Visto che per evitare di turbare gli equilibri del paese ci hanno raccomandato di non lasciare l’appartamento a noi riservato, inganniamo il tempo giocando a carte e raccontandoci storie.
Oggi, a scuola, i bambini non vanno. Sono tutti impegnati nei lavori collettivi per ospitare il prossimo incontro del Concejo Indígena de Gobierno. Nell’attesa che spiova, Estéban si intrattiene con noi, snocciolando un aneddoto dietro l’altro sui tanti stranieri passati di qua… come Angelo, il cuoco italiano con cui andava a raccogliere caracoles al fiume, che si era fermato all’accampamento un anno e a cui si era tanto affezionato. Al momento di ripartire, Angelo gli aveva proposto di seguirlo in Italia, ma Estéban, che era già impegnato come promotore e lo sarebbe stato per altri 8 anni, rifiutò. «Ora un po’ me ne pento, ma non me ne andai… Yo no me fui», ripete, lo sguardo perso in un orizzonte che forse aveva sognato più luminoso.
“Hacia la esperanza”, è il nome che il caracol della Realidad ha significativamente scelto di darsi. Ricordo che all’UniTierra, mentre si ragionava sul recente terremoto distinguendo tra l’orrore per la catastrofe naturale e il terrore come macchina di governo, avevo pensato che la paura è un po’ come il rovescio della speranza: temere che succeda qualcosa di brutto, piuttosto che confidare nella possibilità di qualcosa di bello. Entrambi i principi, nei loro effetti, sono estremamente potenti… «La paura», ammoniva il Maestro Yoda, «è la via per il lato oscuro»; viceversa, la giovane Jyn Erso esortava i compagni sfiancati dalla lotta contro l’Impero affermando che è sulla speranza che si fondano le ribellioni! Ne deduco che aver visto Star Wars in aereo deve avermi suggestionato troppo. Tuttavia, lo stesso Illich aveva sostenuto che, contro una logica “prometeica” basata su aspettative, pianificazioni e risultati controllati, la sopravvivenza della specie umana sarebbe dipesa in gran parte dalla riscoperta della speranza come forza sociale.
«Le feste che celebriamo qui – mi aveva anticipato il doc. Yoda, facendo eco a questo pensiero – sono feste di memoria e di speranza». È il 15 di settembre e in tutto il Messico si celebra il giorno dell’indipendenza. Al CIDECI si uniscono ai festeggiamenti a modo loro: commemorano il giorno in cui installarono il generatore che, dopo un lungo contenzioso con le autorità federali, permise di rendersi indipendenti sul piano energetico. La scena ha un che di comico, con tutti i ragazzi in processione verso la baracca che alloggia il generatore ronzante, agghindata di palloncini per l’occasione. Ormai, la familiarità maturata con il luogo mi consente di scambiare qualche sguardo amico. In questo istante, sento la rivoluzione più viva e promettente che mai. In lontananza i musicisti strimpellano i primi accordi del ballo che presto avrà inizio. È giunto il momento di andare. Non vorrei venir meno a quanto Estéban ci aveva confidato prima di congedarci: «Così viviamo noi, come zapatisti che siamo: quando c’è da lavorare si lavora, quando c’è da lottare si lotta, quando c’è da ballare… si balla!».
Questo articolo è stato pubblicato su l’America latina il 28 dicembre 2020