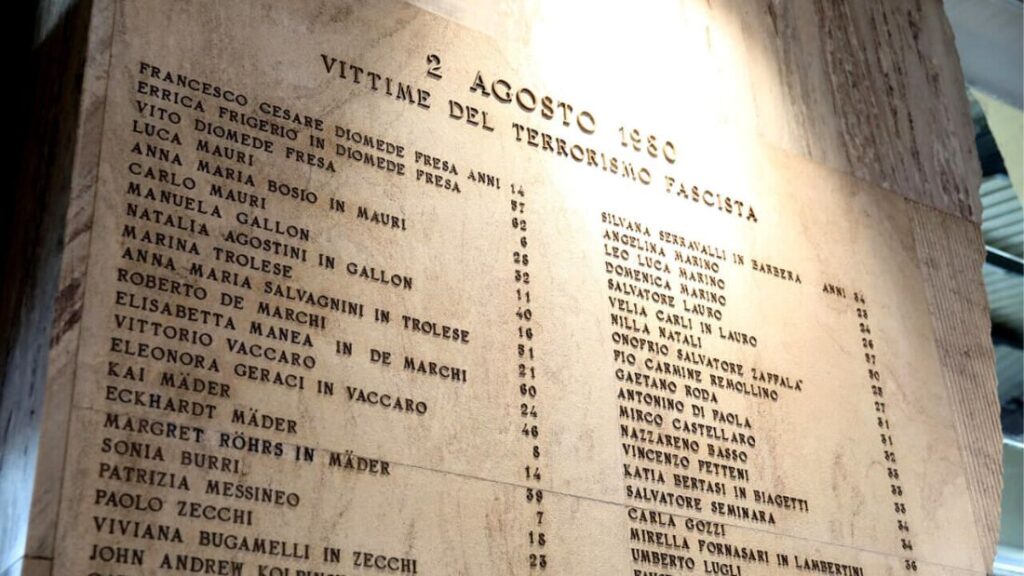A parte la breve parentesi estiva, concerti e rappresentazioni teatrali sono stati sacrificati sull’altare della crisi sanitaria. Tra soluzioni tecnologiche e sussidi insufficienti, bisogna rivendicare la cultura della socialità
Il 25 ottobre al Monk, locale romano lungo la via Tiburtina, c’è un’aria strana. Non perché la satira di Saverio Raimondo non faccia ridere, dipende piuttosto dal fatto che il governo ha appena sancito la chiusura degli spettacoli dal vivo, alla vigilia della seconda ondata del Coronavirus. L’atmosfera è da «giorno prima della fine». Il retrogusto amaro si accompagna alle risate soffocate dalle mascherine. Lo stesso artista appare spaesato. Lo spettacolo è graffiante: si ride del Covid, delle nostre paure pandemiche, a volte sembra più un gruppo di autoanalisi. Ma qualcosa comunque non torna.
Il giorno dopo è lo stesso Saverio Raimondo a palesare il proprio disagio su Facebook. «Mi ritiro dalle scene live per un po’: al netto del Dpcm, così non si può. Voi non potete ridere con una mascherina in faccia (lo avete fatto e pure tanto, ma io soffrivo per voi), io non posso esibirmi con una frequenza così discontinua e occasionale (la stand-up comedy ha bisogno di rodaggio costante)». Da marzo a oggi gli spettacoli dal vivo – da intendersi nell’accezione più ampia possibile che comprende concerti, esibizioni teatrali, arti di strada, performance, danza, circhi – sono stati quasi del tutto cancellati, a parte la breve parentesi da maggio a settembre. Parentesi che in ogni caso ha dovuto fare i conti con le note limitazioni, dal massimo di spettatori consentito alla distanza di un metro da garantire, e che ha notevolmente ridotto la possibilità di spettacoli dal vivo. Si tratta di un vuoto che, a parere di chi scrive, è stato del tutto ignorato e, quando è andata bene, raccontato poco e male.
La prima reazione, lo ricorderete, è stata quella di travasare lo spettacolo dal vivo in forma digitale. Siamo stati inondati di concertini e performance improvvisate, fatte in casa, di pessima resa sonora e ancor peggiore qualità artistica che ci invitavano a restare a casa. Non poteva durare, e per fortuna non è durata.
Stretti i denti e passata la prima paura del contagio, è arrivata l’ansia. Alcune domande hanno preso il sopravvento: come sopravviverà il settore? Quanto durerà questa vita senza contatti ed emozioni live? Non è che ci abitueremo anche a questo? Dalle istituzioni l’unica risposta, parziale e inefficace, è stata finora quella dei contributi a pioggia. Sono nate forme spontanee di aggregazione, come l’associazione Unita (l’Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo), il coordinamento nazionale Professionisti spettacolo e cultura – Emergenza continua e la rete Risp, il gruppo intersindacale che da mesi si sta districando nel complesso ginepraio dei bonus Covid.
Questi ultimi, nel denunciare le distribuzioni del ministero dei beni culturali dei fondi ai teatri per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, hanno fatto una buona sintesi della situazione con un post su Facebook dello scorso 19 novembre: «I lavoratori dello spettacolo sono alla fame e disorientati, in balia dei ritardi da parte dell’Inps per i dovuti ristori, che se va bene ammontano a 2800 euro in 9 mesi di quasi totale inattività, sono senza prospettive per il futuro e senza poter fare il proprio lavoro, mentre l’intero settore si sta sgretolando e chissà chi e quando potrà riaprire, se mai ce la farà».
Con notevoli mesi di ritardo, in ogni caso, il ministro Dario Franceschini ha scelto di realizzare un tavolo permanente per lo spettacolo dal vivo, presieduto dal direttore generale Onofrio Cutaia. Escludendo però sia il coordinamento dei professionisti che la rete intersindacale dal primo incontro del 25 novembre. C’è poi chi con gli spettacoli dal vivo lavora in maniera collaterale, nel senso che li ospita e promuove. E che è stato altrettanto penalizzato. Con forme, però, molto diverse da caso a caso. In estate la pressione delle discoteche è stata talmente forte da permettere un’apertura quasi totale, come ha svelato Report col caso emblematico della Sardegna. La musica dal vivo, vale a dire la forma di fruizione che più può essere associata alla discoteca, ha continuato invece a rimanere monca, tra grandi concerti saltati, interi festival annullati o rimodulati (come la Biennale del Cinema di Venezia) e raduni all’aperto molto limitati. «I più colpiti – scriveva nello scorso mese di luglio Il Post – sono stati i locali di musica dal vivo che hanno spazi soltanto al chiuso, spesso sono più piccoli e ospitano solitamente band emergenti: posti in cui peraltro prima dell’epidemia gran parte delle entrate arrivava dalle consumazioni al bar dei clienti, limitate dal divieto di assembramento al bancone».
L’esperienza delle migliaia di circoli Arci sparsi in tutta Italia in questo senso è un esempio notevole. Soltanto a novembre i soci e le socie della più nota associazione di promozione sociale hanno cominciato a far sentire la propria voce, partecipando alla manifestazione romana A noi gli occhi, please del 7 novembre scorso. Come mai questo ritardo nella rivendicazione? Davvero può valere la giustificazione della mancata e rapida capacità di reazione a quella che sembrava un’emergenza e che invece rischia di diventare situazione duratura? «I ristori del governo sono un tampone e, così come per la crisi sanitaria in atto, noi invece vorremmo non ammalarci – osserva Rita Cantalino, del direttivo del circolo Arci Sparwasser di Roma – Con la società in cui viviamo ci stiamo comportando come coi malati, preferendo soluzioni personalizzate invece che delineare una visione di sistema. Il problema non è se la singola categoria più o meno forte riesce a farsi sentire, come ora è, almeno nel dibattito pubblico, per quella legata al settore sciistico. Ciascuno difende i propri interessi, è chiaro. Ma noi dobbiamo chiederci: in che tipo di società vogliamo vivere? In una dove ciascuno vive a casa propria e si gode la cultura a modo suo e a proprio piacimento o in una dove favorire scambi e interazioni?».
Il circolo Sparwasser, come tante altre realtà similari nella Capitale, vive un momento di estrema difficoltà senza gli spettacoli dal vivo che ne costituivano l’essenza. «Da noi non vieni perché la birra è particolarmente buona, ma perché c’è sempre qualcosa da fare – dice ancora Rita – Le nostre attività erano tutte serali, visto che il nostro gruppo è costituito da volontari. Essendo lavoratori altrove, dunque, non siamo riusciti a convertirci in circolo diurno, come hanno fatto altri. Restano in questo momento le attività di supporto alle persone, come lo sportello psicologico e quello al lavoro».
C’è chi ha provato altre strade, come la raccolta fondi e lo spostamento in altre sedi. È il caso di Pierrout Le Fou, minuscolo localino, sempre al Pigneto, che negli anni si è fatto apprezzare per aver dato spazio alla stand-up comedy e che d’estate ha gestito invece uno spazio enorme come l’Eur Social Park, registrando più di un pienone. C’è chi, come Ascanio Celestini, ha proposto a il manifesto un «Piano regolatore culturale» che parta dai territori e definisca domande e bisogni «altrimenti, si danno risposte a caso o, peggio, non se ne danno». Nell’immediato dovremo certamente rinunciare agli spettacoli dal vivo, almeno per qualche altro mese. Dall’altra, però, viene facile convergere con ciò che scrive Andrea Minconi nel bel libro Epidemie e controllo sociale, ovvero che di questi tempi si finisce per «concedere allo Stato quello che non accetteremmo da nessuno, e in nessun altro campo dell’esistenza: giustificare una mancanza con le proprie precedenti mancanze».
Così non sorprende l’appello a cercare un’alternativa, avanzata dal direttore di Rai Radio3 Mario Sinibaldi su Internazionale. Un invito che però non si rivolge allo Stato, cioè a chi decide, ma a chi quelle decisioni le subisce e nel quale si legge non a caso che «la mobilitazione degli operatori culturali e di tanti cittadini e cittadine che hanno a cuore il futuro dell’arte come quello della propria esistenza andrebbe indirizzata in un’altra direzione». Quale? «Reinventare modalità materiali e digitali, luoghi reali e virtuali, nei quali continuare a praticare arte, intelligenza, bellezza. Studiare (e pretendere) incentivi da usare in questa direzione: progettare piattaforme e tecnologie capaci di scavalcare ogni isolamento, ogni separazione (che saranno comunque necessari nel mondo che sta nascendo dalla pandemia)». Sembra un assist alla cosiddetta Netflix della cultura. E non è il primo della serie. Il web è pieno di apologie del concerto streaming di Billie Eilish, il primo in grande stile da parte, per giunta, di una giovanissima cantante che il giornalismo mainstream definirebbe «nativa digitale”.
Non vogliamo cadere nella nostalgia dei «concerti, quelli belli», però non possiamo più permetterci osanna acritici della tecnologia che risolverà tutti i mali. Anche perché, banalmente, i cortocircuiti si trovano facilmente nelle stesse recensioni di queste «nuove» forme d’arte. «La cantante – scrive Rolling Stone – ha invitato un paio di volte il pubblico a casa a battere le mani: sono stati gli unici momenti di vago imbarazzo. Il pubblico c’era, eccome, e Eilish l’ha portato in scena, sui ledwall, e ha cantato circondata dalle facce dei fan collegati in diretta da casa». Proiettare i volti dei fan su uno schermo, durante un evento live, per simulare la presenza degli spettatori è un tentativo simile a quello portato avanti per prima volta dalla Nba, la lega professionistica del basket statunitense: un esperimento irripetibile nella cosiddetta bolla di Orlando, che però non ha convinto i giocatori (a partire dal più noto di tutti, cioè Lebron James), che hanno a più riprese invocato il ritorno del pubblico in carne e ossa.
Allora, forse, bisognerebbe tornare a guardare all’arte. Nella nota correlazione tra teatro e peste teorizzata da Antonin Artaud si ribadisce che «la peste coglie immagini assopite, un disordine latente, e spinge d’improvviso fino a gesti estremi; e anche il teatro prende dei gesti e li spinge al limite: come la peste ribadisce il legame fra ciò che è e ciò che non è, fra la virtualità del possibile e ciò che esiste nella natura materializzata». Se estendiamo il teatro agli spettacoli dal vivo ecco che potremmo individuare, a quella che fino a un anno fa sarebbe stata descritta come una distopia alla Black Mirror, una possibile alternativa. Che parte dalla costruzione di un immaginario altro e alto. Davvero vogliamo stare ancora più tempo davanti a uno schermo, a un tablet, a un pc, a uno smartphone? «C’è un incredibile voglia di arte e cultura, da fruire senza mediazioni, insieme agli altri» racconta Domenico, un sassofonista che ho incontrato durante la manifestazione Per una società della cura. «Personalmente da anni mi piace esercitarmi, qui a Roma, sotto alcuni dei ponti più noti di questa città. C’è un’acustica particolare, che mi ispira. Se fino a qualche mese fa la gente mi guardava dall’alto, con un po’ di curiosità per poi tornare alle proprie faccende, oggi invece mi raggiungono sotto e mi ascoltano. Ovunque vada si formano gruppi in ascolto».
Per dirla coi Quintorigo: sogni o bisogni? Se coi numeri dei contagi attuali invocare la riapertura degli spazi culturali può apparire controproducente, bisogna osservare che un anno, il 2020, passato a lavorare e poco più, è ancora più frustrante. Siamo di fronte al rischio che emerga un’idea capitalista di essere umano che concepisce la propria vita esclusivamente attorno al lavoro, per poi tornare nella propria abitazione e lì coltivare, da solo, il proprio orticello culturale. In questo modo si sacrificano le nostre esistenze sull’altare del consumismo. Le case dove noi ci nascondiamo, le definiva Giorgio Gaber nel suo capolavoro C’è solo la strada, sono diventate il nostro rifugio, la nostra oasi, reclusione e via di fuga (culturale, s’intende). Invece di concentrare gli sforzi su nuove tecnologie vale la pena creare, ricreare e immaginare altri modi di stare insieme al tempo della pandemia. Partendo dalle rivendicazioni di chi lavora nel settore e allargando lo sguardo. Sogni e bisogni, ancora una volta.
Questo articolo è stato pubblicato su Jacobin Italia il 4 dicembre 2020