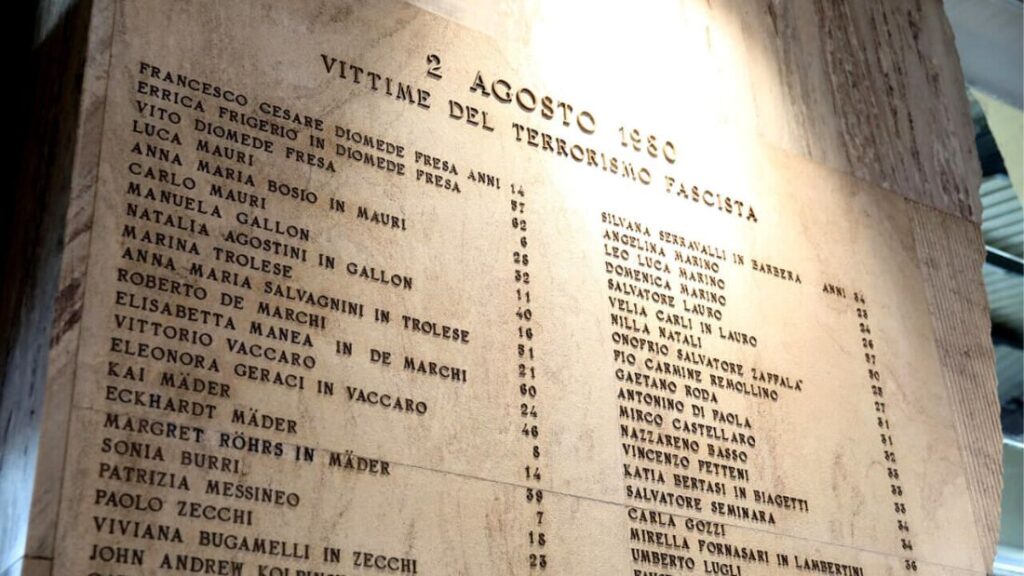Occorre mettere in campo tutta la spesa pubblica che serve avendo chiaro che la scomparsa dell’inflazione e l’enorme mole di risorse garantite dalla Bce renderanno il debito pubblico l’ultimo dei problemi dei prossimi anni. I vincoli “contabili” in vigore anche solo un anno fa sono regole preistoriche. L’analisi di Alessandro Volpi.
La rabbia sociale è un aspetto che la storia ha sempre legato alle epidemie e alle carestie. Spesso per capirne le ragioni servono i numeri, crudi. In Italia esistevano 3,2 milioni di lavoratori precari nel dicembre 2019, prima della tempesta epidemica che, in moltissimi casi, li ha travolti. Esisteva poi una platea di almeno 3,7 milioni di persone formata dai lavoratori irregolari, ovvero da coloro che lavorano senza essere messi in regola dal punto di vista contrattuale, fiscale o contributivo. In realtà l’Istat non censisce i lavoratori irregolari in quanto tali, ma fa riferimento tecnicamente a unità di lavoro a tempo pieno (Ula), che potrebbero valere più di un lavoratore ciascuna. In questo senso se ci sono due persone che lavorano in nero mezza giornata vengono conteggiate come una sola unità di lavoro a tempo pieno, ma sono due individui coinvolti dal lavoro irregolare; è evidente dunque che i lavoratori irregolari sono ancora di più di quelli stimati.
Raggiungere con forme di sussidio questa porzione enorme del mondo del lavoro composta da precari e irregolari è estremamente complesso, se non si ricorre a forme di reddito universale; non raggiungerla significa però, in questa fase difficilissima, alimentarne il senso di abbandono e l’inevitabile rabbia. Considerazioni analoghe sono possibili per i troppi esclusi dai decreti ristoro; dai dipendenti delle mense, a quelli dei circoli ricreativi, agli agenti di commercio, agli autisti dei bus turistici, ai lavoratori delle lavanderie industriali. In sostanza milioni di persone sono ormai a ridosso della soglia della povertà o l’hanno già oltrepassata perché privati, di fatto, di ogni forma di lavoro. A loro vanno aggiunti tutti quelli “ristorati” poco o tardi, il numero dei quali rischia di aumentare molto per effetto della scelta del secondo dei già citati “decreti ristoro” di definire gli indennizzi in base alle zone di rischio epidemico in cui è diviso il Paese. Stabilire infatti che solo nella “zona rossa” verranno risarcite per intero le perdite, al di là di una apparente ragionevolezza, significa non tenere conto del rapidissimo peggioramento delle condizioni delle attività economiche delle altre zone che rappresentano la gran parte del Paese per le quali già la prima tranche dei ristori previsti si rivela inadeguata.
Alla luce di ciò, aver finanziato una serie di decreti per oltre 100 miliardi di euro e aver bloccato i licenziamenti rappresenta, certo, uno sforzo importante ma non basta per due ragioni. La prima è costituita dal fatto che tali misure si indirizzano, in larga misura, a soggetti almeno parzialmente protetti, tipici di una società “di massa” che ormai è stata sostituita da una feroce molecolarizzazione, composta da centinaia di migliaia di piccole attività, spesso prive delle risorse per affrontare le crisi. La seconda, più banale ma decisiva, si lega a un impoverimento che è ben superiore agli oltre 100 miliardi di euro messi in campo. Per questo serve uno sforzo pubblico ulteriore, di natura universalistica appunto, per evitare che la legittima rabbia si trasformi in odio sociale e bisogna fare presto. Gran parte dell’Europa ha intrapreso forme più o meno dure di lockdown, a cominciare da Francia e Germania che, non a caso, hanno annunciato le restrizioni nello stesso giorno. Quasi contemporaneamente alle dichiarazioni franco-tedesche, Christine Lagarde ha affermato che la Banca centrale europea farà di tutto per sostenere “i debiti nazionali”, lasciando capire ai mercati la disponibilità da parte dell’istituto di Francoforte di mettere in circolo rapidamente altri 500 miliardi di euro per l’acquisto di titoli pubblici e privati e di offrire alle banche tanta liquidità remunerandola all’1% se indirizzata a famiglie e imprese. In altre parole, di fronte all’incapacità di produrre reddito diffusa in tutto il Vecchio continente e generata dalla paralisi indotta dalle restrizioni, la Bce non ha esitato un attimo a sostenere, di fatto, il finanziamento senza limiti della spesa pubblica necessaria. In una simile situazione non hanno davvero più alcuna ragione di essere i vincoli “contabili”, dettati dalle ormai preistoriche regole nate in Europa a metà anni Novanta.
Il rapido infiammarsi delle proteste sociali, l’impoverimento reale di milioni di italiani, la totale incertezza del futuro obbligano a non limitare gli interventi pubblici a forme di “ristoro” costruite su scostamenti del deficit e su un maggior debito misurati, appunto, in base a parametri in uso anche solo un anno fa. Se l’ulteriore scostamento del deficit richiesto al Parlamento da parte del governo aumenterà di 15 piuttosto che di cinque miliardi di euro, non cambierà molto in termini di finanza pubblica mentre cambierà molto per la tenuta sociale del Paese. È il momento di mettere in campo tutta la spesa pubblica che serve avendo chiaro che la scomparsa dell’inflazione e l’enorme mole di risorse garantite dalla Bce renderanno il debito pubblico l’ultimo dei problemi dei prossimi anni. Del resto, si utilizza di frequente il paragone fra l’attuale pandemia e una guerra; nel caso italiano, dopo la prima Guerra mondiale il debito pubblico era esploso al 160% del Prodotto interno lordo per effetto dell’enorme massa di debiti di guerra che, poi, non furono mai pagati dallo Stato italiano ma che erano serviti a evitare l’affamamento del Paese.
Questo articolo è stato pubblicato su Altreconomia il 16 novembre 2020