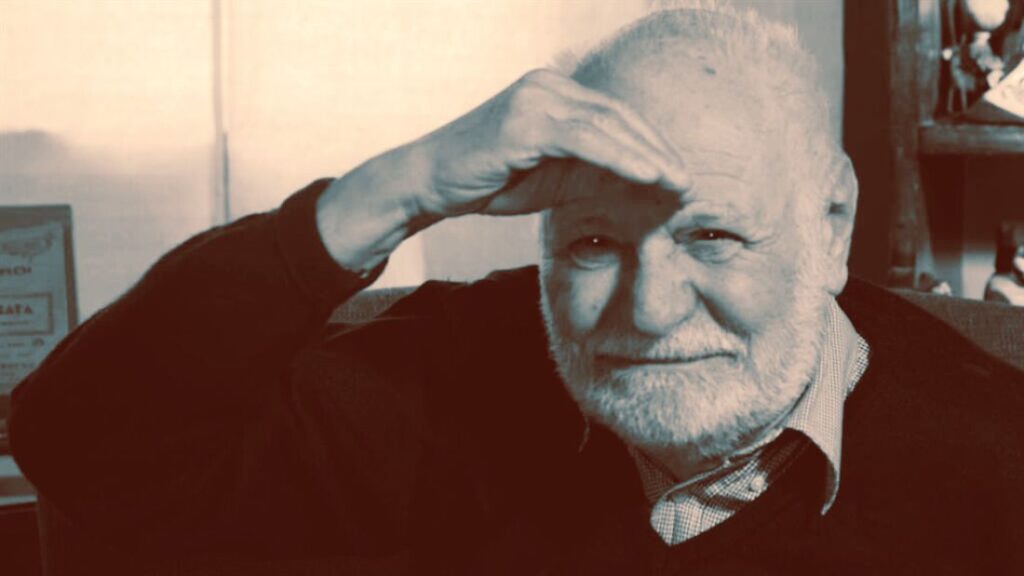Per uno sguardo curioso sulla finale dell’ottava edizione del Premio Scenario infanzia 2020
Non suoni rituale il mio personale richiamo alle emozioni del cuore, nell’accostarmi al ripensamento attento, amorevole, curioso di ciò che ho avuto l’onore di visionare in questa niente affatto scontata ottava edizione della finale di un riconoscimento prezioso quale il Premio Scenario Infanzia, ospitato presso il Damslab di Bologna.
Dico questo perché, come sappiamo, l’anno difficilissimo per tutti e che ancora non possiamo certo archiviare nei suoi aspetti più incogniti, ha segnato anche una crisi e un generale ripensamento rispetto a tutti i meccanismi di creazione e fruizione artistico performativa.
Una situazione che certo ha toccato nel vivo non solo grandi istituzioni consolidate, ma anche e soprattutto compagini di giovani talenti in formazione quali quelle che si affacciano soprattutto alle selezioni di Scenario, un premio a caratteristiche peculiari, costruite soprattutto sulla necessità di ascolto, accompagnamento, verifica e respiro progettuale di cui formazioni ancora acerbe hanno assolutamente bisogno. Un premio dunque che sfugge ai clichè di competizione per posizionarsi piuttosto sul terreno di una messa in rete virtuosa di saperi e competenze, sulla possibilità di incontro, confronto, discussione che aiuti gli artisti a “vedersi” nel proprio fare, soprattutto in un caso come questo in cui la sottotitolazione del premio ci indirizza programmaticamente alla messa in campo di nuovi linguaggi per nuovi spettatori.
In questa edizione, si è stati costretti a saltare a piè pari la cruciale fase delle tappe di selezione, in cui gli artisti portano normalmente un assaggio di 20 minuti del loro lavoro, sicché ben 14 lavori si sono presentati al rush finale mostrando 15 minuti di elaborazione e mettendo certo in difficoltà, per ricchezza e varietà di spunti, la giuria presieduta da Giuliano Scarpinato, vincitore della manifestazione del 2014. Ma naturalmente, la vicenda pandemica – anche se non apertamente trattata in nessuno dei lavori e solo accennata qua e là da qualche mascherina inserita nel pattern drammaturgico anche in scena oltrechè ovviamente, come da protocollo, tra il pubblico di osservatori, studenti e operatori che incornicia il dialogo tra giuria e teatranti – ha riverberato sul tutto. Il lungo lockdown ha certo costretto a modalità di lavoro inedite e ridimensionate e soprattutto ha interrotto il dialogo già intrapreso da molti gruppi tramite laboratori con il pubblico destinatario principe di tutta questa operatività creativa e cioè bambini e giovanissimi, compresi in un range molto ampio e dunque assai diversificato di fascia anagrafica tra la scuola materna e gli istituti superiori.
Generazioni
Vorrei soffermarmi proprio sugli aspetti anagrafici della questione perché, al di là delle necessarie esigenze di categorizzazione cognitiva che già metterebbero al centro complesse questioni pedagogiche, neurolinguistiche, psicologiche, ma anche, in controluce, questioni sociali ed etnicoculturali, non secondarie rispetto alla definizione dei linguaggi e del loro grado di ricezione, esiste probabilmente un tema globale di mission – anche rispetto ad essi, per così dire –, oltre quella che non sia puramente espressiva, intrinsecamente artistica, già propria del Teatro, e un problema di relazioni istituzionali e territoriali che chiamano in causa in primis le scuole e il loro grado di accoglienza, laicità, aderenza ai contesti.
In qualche modo, nonostante i diversi livelli di maturazione dei progetti, almeno per ciò che riguarda gli 8 progetti visionati da me, prevalentemente inerenti fasce d’età superiori o quantomeno a partire dai 10 anni, non si potrebbe dire che i futuri spettacoli, destinati a dilatarsi per misure variabili dai 40 minuti all’ora circa, tranne qualche eccezione, non siano godibili anche per un pubblico adulto; o meglio, che i temi trattati non siano ascrivibili anche a diversi range generazionali, a partire da quello degli stessi proponenti, in verità spesso non troppo distanti in età dai fruitori privilegiati. Resta dunque, in buona sostanza, difficile definire se questa tornata alla fine ci offra più che uno spaccato dello stato delle cose giovanili in funzione pedagogica, alcune possibili chiavi autorappresentative di una generazione di teatranti venti-trentenni e della loro formazione, oppure ancora possa mai offrire strumenti autorappresentativi per una generazione ancora in erba, fluida dentro le convenzioni anagrafiche delle classi scolastiche ed obiettivamente gravata già di debiti, urgenze, problemi irresoluti o difficilmente risolvibili inerenti l’essenza stessa della specie umana prima ancora di aver sciolto alcuni nodi identitari fondanti. Così non deve meravigliarci affatto, se, ancora una volta, per ragazzi piccoli e grandi, il modulo della fiaba sembri fornire elementi di realtà e la realtà tingersi di una mediazione fiabesca o quantomeno fumettistica in diversi lavori visti.
Identità e conflitto
Nell’era dei numerosi post, inerenti in qualche modo sia la capacità di rappresentare, sia persino di narrare, vedendo affievolirsi qualsiasi epica possibile, modello o ruolo credibile, ma anche entrando in crisi una certa idea di immediatezza performativa, anche l’identità, terreno di contesa tra tensioni diversificate di passato, presente, e curiosamente, se vogliamo, ma anche significativamente, molto meno di futuro, in qualche modo si presenta come un puzzle da costruire.
In effetti, nelle discussioni con le giovani compagnie, che sono uno dei tratti più belli di questo premio così significativo per tutti gli osservatori che possono parteciparvi, il tema del frammento, della tessera, del collage da ricomporre è risultato determinante, come pure quello della possibile struttura in quadri dello spettacolo compiuto a venire.
In qualche modo sembra dominante una volontà di sapere, di conoscere, che però contemporaneamente viene enunciata come impossibile, quantomeno nella forma storica sequenziale, verticale, gerarchica ma tutto sommato logica che le attribuiamo normalmente. Il posizionamento di fatti, discorsi, percezioni è orizzontale, in affiancamento anche rispetto al passato e le cesure, più che dal Tempo, sono date dagli argomenti. Il conflitto come categoria frontale di scontro tra opposte visioni pertanto, quello che poi dovrebbe condurre ad un esito terzo, sembra latitare per chi stenta a trovarsi persino un posticino nel mondo. Falso movimento? I giovani si scoprirono e inventarono come gruppo, come categoria o ceto sociale che poteva fare massa critica, già a partire dal dopoguerra e l’esplosione delle band nei decenni a venire, con tutta una loro mitologia, un album di martiri e di eroi tra contestazione e dissipazione, forse ha espresso benissimo tutto questo in maniera indelebile considerato l’impatto anche commerciale dell’insieme. Oggi se potevamo aspettarci forse un linguaggio più gergale, un accenno alle periferie, qualche radiolone in scena, una maggior pregnanza musicale, qualche tematica di genere o di interculturalità forte, rimaniamo spiazzati, perché sembra dominare un senso generalizzato di solitudine, anche in quei lavori che si sporgono fuori dalla cameretta: in ogni caso, persino le atrocità e assurdità delle guerre di ieri e di oggi vengono sentite, assunte, partendo da una molla di infelicità personale, da un bisogno individuale di ridefinirsi.
Il mondo degli adulti
È un fatto, che con accenti e per motivi diversi, sembri mancare all’appello una intera generazione di mezzo, quella dei genitori, ancora soggetti attivi in qualche modo e infine anche rieducabili per esempio nel bellissimo e ancora efficacissimo spettacolo di Giuliano Scarpinato, vincitore del premio edizione 2014.
Mentori di una generazione che ha probabilmente un’idea del documentarsi assai diversa da quella che fu, basandosi su blocchi tematici, portato certo delle nuove forme di enciclopedizzazione e inventariazione del reale, rimangono i nonni, o meglio le nonne, o comunque enigmatiche vecchie signore, certo imparentate con le fiabe, che agiscono sempre e comunque il loro potere da spazi angusti, preferibilmente bauli, miniwunderkammer, come a dirci che la memoria da collettiva si va interiorizzando. Oppure certo, si potrebbe interpretare tutto questo anche come un nuovo discorso che carsicamente si viene delineando, un bisogno di verità, dopo quello di realtà, che non può che esplicarsi come sofferta ricerca personale, bisogno di autenticazione individuale: non possiamo decifrare credibilmente il presente se non conosciamo un prima di cui sentiamo avere sinceramente il bisogno… e pazienza se le grandi parole, i grandi ideali maiuscoli rimangono fuori dal gioco. Del resto, l’ambiente iperreale in cui siamo immersi, da un lato ci chiede di identificarci di continuo e fornire assicurazioni sul nostro non essere ectoplasmi, dall’altro ci impedisce di distinguere il vero dal falso. La verità assume cosi il sembiante di una domanda a risposta multipla e il contesto non aiuta la decodificazione. Né la scuola né la famiglia sembrano fornire un supporto emotivo in questa esperienza di quête. Senza però che i lavori visti prendano di petto questo grosso scoglio della mancanza di empatia, di adesione sentimentale ai valori di riferimento, a patto che esistano, della coerenza tra vissuti, comportamenti e atteggiamenti. Il mondo adulto che viene accennato in sottofondo è solo noiosamente, approssimativamente “criticone”, senza neppure avere il coraggio di essere prescrittivo. Piuttosto è imbevuto di conformismo, contraddittorio in tutto il suo stesso percorso.
Critica del reale
Per questo, forse, è impossibile agire apertamente un conflitto o tentare di acquisire una metodologia di critica del reale presente. Sembrano essere dunque sorta di guide in questo bisogno di verità sottinteso, che deve necessariamente accompagnarsi ad un distanziamento, ad un contenimento della sofferenza, pupazzi, marionette, maschere, oggettti transazionali di varia natura mobile e meccanica. Le onniscienti e onnipresenti tecnologie sono alternativamente stregonesche, tutoriali, surrogati di parental control. In gran parte dei lavori presentati sembra anche sbiadire il tema delle disuguaglianze, a meno che non siano lette da parte di chi improvvisamente uscito dalla cameretta può rendersi conto del proprio privilegio per contrasto con la situazione estrema della guerra in Siria. Tuttavia, evidentemente, questa uniformità di ambiente sociale non consente allo stesso tempo solidarietà e cooperazione se dobbiamo invocare un esempio in tal senso dalla società delle formiche, come si evince da uno degli spettacoli dedicato al range anagrafico più classico, quello delle elementari. Insomma, orizzontali nel tempo e nello spazio, ma tutto sommato… distanti, e a questo punto viene difficile pensare che la pesante condizione di questi mesi con il suo portato di introspezione e chiusura forzata verso l’esterno, non abbia influito in questo pattern contenutistico-espressivo. Per questo, azzardo che sarà molto importante vedere come questi progetti potranno svilupparsi da qui in poi: nulla mi sembra scontato e prevedibile in quello che ci possiamo aspettare di vedere. La questione delle definizioni e aggiustamenti per il pubblico su base anagrafica, certo non è stato solo un problema di chi scrive, ma anche delle due giurie, quella studentesca dell’osservatorio critico coordinato da Fabio Acca e quella ufficiale che si trova a gestire in qualche modo diversi livelli di approfondimento tematico-linguistico e anche diversi livelli di esperienza, padronanza dei mezzi e della scrittura, da parte delle compagnie. Pertanto appare più che giustificato il ricorrere specialmente quest’anno ad ex-aequo e naturalmente a menzioni, che sono senza portafoglio sì, ma aprono all’interesse di critici, giornalisti ed operatori; ed appare significativo come in effetti i lavori premiati siano quelli su cui si è discusso collettivamente di più per ragioni spesso opposte.
Autobiografia di una memoria
Il discorso fin qui condotto sulla leva autobiografica come ponte sulla conoscenza di un possibile sé sociale, di specie, l’assenza della figura parentale, quale valore attribuire al passato, alla memoria, quand’anche filtrata dall’interno borghese, il tema del puzzle casuale per la ricostruzione di una memoria, una ricerca di verità, affidata a voci documentaristiche esterne a quelle dei soggetti in scena, un racconto di vita di fatto, smentito dalla negazione del proprio status di attori, quindi di possibili credibili narratori, sono tutti elementi compresenti nel progetto che complessivamente ha avuto più riscontri tra le varie giurie, ovvero Arturo di Nardinocchi-Matcovich da Montesilvano. Un lavoro di grandi potenzialità centrato sulla simmetrica scomparsa prematura dei padri della coppia di vita e di scena, un tentativo più che di elaborazione di un lutto, di esorcizzazione del medesimo. Il titolo del lavoro, molto toccante emotivamente, non è riferito al nome di alcuno dei congiunti evocati, ma allude al romanzo di Elsa Morante L’isola di Arturo e forse per aggiungere un pizzico di distacco, di dialettica di ruolo ad un’opera intrisa di nostalgia per la mancanza fisica della persona, gioverebbe giocare di più sull’ispirazione anche letteraria, tutto sommato abbastanza assente anche nella preparazione e documentazione di immaginario della gran parte dei lavori presentati in generale.
La Storia collettiva…
Casa nostra di Hombre Collettivo di Parma, ex aequo della giuria con Arturo, si presenta come un lavoro estremamente ambizioso che parte dalla fatidica cameretta di giochi per tentare l’assalto all’oscuro e complicato mondo degli sporchi giochi della politica adulta, tentando di ricostruire, con un’accattivante estetica pop di sicuro impatto, gli ultimi 40 anni di storia nostrana con tutto il loro carico di umane miserie e modelli di costume trash. Il lavoro è coraggioso fino all’incoscienza, chiamando in causa da monitor televisivi d’ordinanza, con nomi e cognomi, protagonisti tuttora in auge, seppure ammaccati, della cronaca e della politica. Un lavoro che fa sicuramente discutere, molto nobile nelle intenzioni di parlare della storia più prossima, notoriamente la meno conosciuta, che accetta di correre diversi rischi insiti nelle sue stesse dichiarazioni d’intenti, prese per così dire a prestito da un’illustre penna di magistrato, e che però decontestualizzate e inserite in un organismo-spettacolo pienamente immerso nell’estetica del senza parole (tranne quelle delle televisioni appunto, che naturalmente ha un perché preciso) e dei frammenti in orizzontale, potrebbero contribuire forse ad un compiacimento divertito quanto impotente dell’intelligenza. Ovviamente la speranza è che non cinismo ma curiosità, consapevolezza e infine indignazione siano gli esiti ultimi di questo interessante progetto, che appunto ha il merito di sganciarsi dall’intimismo per certi versi dominante persino in alcuni altri lavori che tangono la Storia, quella vera, che tutti, oggi più che mai ci sovrasta minacciosa.
…e le storie individuali
Brigitte e le petit bal perdu della deliziosa Nadia Addis e From Syria: is this a child? da un’idea dell’altrettanto bella e determinata Miriam Selima Fieno, che guida una complessa compagine dall’alessandrino, si situano con le menzioni (non ho potuto vedere il terzo progetto menzionato, Il vestito nuovo dell’Imperatore) ai poli del discorso tracciato dagli spettacoli succitati e sono estremamente rappresentativi delle tendenze descritte sin qui. Nel lavoro di Addis, la nostalgia, il rapporto malinconico con il passato, il microcosmo chiuso dei nostri ricordi è esemplificato da un elegantissimo lavoro per famiglie della durata di sette minuti che mixa sapientemente marionette manovrate a vista con la scenografia rétro che esce da una valigetta portatile, la struggente musica del tango, l’irresistibilità evocativa, anche se forse non proprio infantile, sul quesito dei quesiti riguardante appunto il nostro rapporto con la perdita.
From Syria, viceversa, sembra essere l’unico progetto che si occupi del mondo, un mondo divenuto altro per l’asperità del conflitto più che per la lontananza geografica, ma ora, causa pandemia, tornato veramente ad essere distante, irraggiungibile. Per questo lavoro in particolare possiamo parlare di progetto di lungo corso e ampio respiro, visto che per parlare di guerra, morte, distruzione, profughi, diversità culturali ai bambini e ragazzi in modo molto diretto, esso si avvale di tecniche miste da docufiction, piani interpretativi intersecantesi tra biografico e politico, individuale e collettivo, coinvolgendo reti associative e territorialità, rapporto con paesi di mediazione quali il Libano, diverse fasce di età a confronto. E soprattutto presenta una protagonista essa stessa bambina, Giorgia, che cresce insieme allo spettacolo e accetta di esporre una elaborazione live non solo delle sue opinioni, del suo rapporto, molto maturo per la sua età, con i profughi siriani, ma anche in parallelo, della sua pur breve biografia e degli aspetti privilegiati e insieme dolorosi della sua condizione di ragazzina bianca borghese e occidentale.
La ragazzina Giorgia, davvero sorprendente in scena e nella vita, si confronta con quella che per lei è una autentica tragedia, ovvero la separazione dei suoi genitori, che interrompe bruscamente l’inanellarsi di eventi piacevoli, vissuti fin lì in assenza di masochismo da cameretta, che era la sua esistenza, e affronta in sottotesto, al di là del reiterato buonismo peraltro sincero come viene autodichiarato in una esemplificazione estrema di teatro-verità nel corso dello spettacolo – e doveroso, aggiungo –, il tema centrale della crescita. Ovvero il confronto con la sofferenza e con l’altro, fuori da ogni protezionismo giustificatorio e autoassolutorio. Quello che fa dire, per esempio, a Giorgia, che ci sono assenze e assenze: i suoi genitori non sono comunque morti, differentemente da quelli di altri, apparentemente selezionati da una roulette impazzita. Non dunque percezioni, ma dati di oggettività. Storia e storie individuali si intrecciano strettamente, ma in qualche modo, molto originalmente si respinge anche qui la narrazione, perché si sceglie di mostrare nel suo farsi il dipanarsi di quel che succederà. La pandemia ha aggiunto incognite in più ad una vicenda umana, ma anche allo svolgimento di uno spettacolo sicuramente emozionante.
Il bilancio di questa difficile edizione nella ricchezza delle proposte suona anche come una chiamata alla ricognizione delle emozioni di cui abbiamo bisogno in un mondo senza eroi né modelli, ma forse non ancora cosi beato come lo intendeva la vulgata brechtiana.