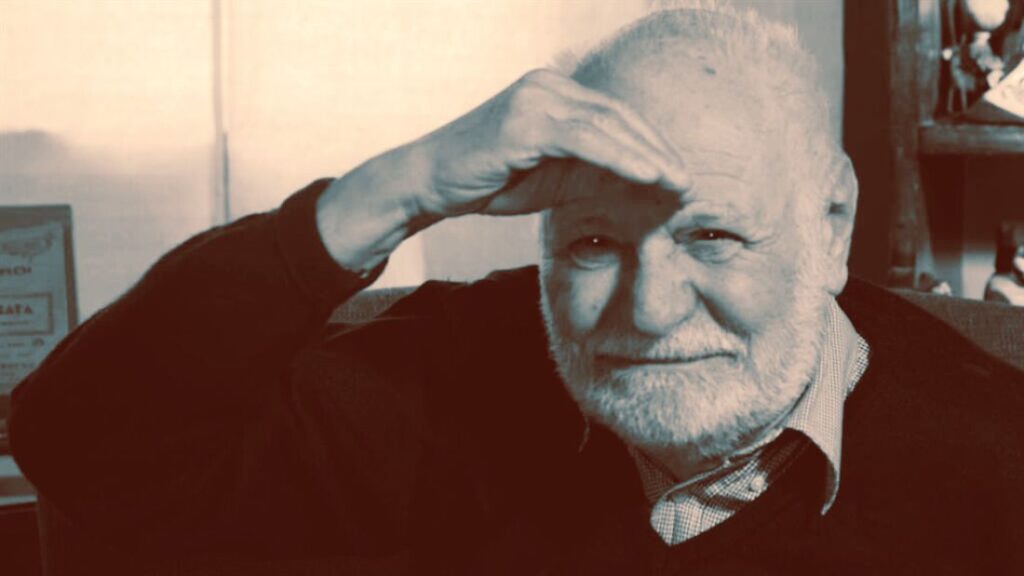Grazie a una mobilitazione e a un’affluenza record, Biden batte in modo netto Trump, anche se perde il senato. La voglia di tornare alla normalità, al tranquillo consenso centrista bipartisan, è però un’illusione che si scontrerà con la realtà
Trump ha perso e Biden ha vinto, nettamente. Dopo qualche giorno di incertezza, dettato in realtà più dall’estrema cautela con cui i media hanno trattato le presidenziali, dopo la figuraccia di quattro anni fa, oltre che dell’enorme numero di voti postali a causa della pandemia, il risultato è ormai indiscutibile. Il presidente uscente ha strepitato per un po’ di brogli e ricorsi, ma l’impressione è che l’élite repubblicana non sia disposta a seguirlo su quella strada con la compattezza che sarebbe necessaria, anche se chiaramente la maggioranza conservatrice nella Corte Suprema resta un pericolo.
Nell’elezione a cui ha partecipato il maggior numero di persone della loro storia, gli Stati uniti d’America si affidano a Joe Biden e Kamala Harris: un anziano senatore bianco della costa est e un’arrembante ex magistrata law and order californiana di origine nera, giamaicana e asiatica, entrambi saldamente ancorati al consenso centrista. Una vittoria tutta liberal, che però non è stata il trionfo preconizzato da molti: le masse di repubblicani delusi dall’estremismo di Trump e dalla sua gestione della pandemia non si sono viste, le valanghe di milioni investiti nel cercare di conquistarli per ottenere la maggioranza al senato sono state bruciate, e la destra reazionaria è sconfitta ma non battuta.
Biden ha vinto sull’onda di una voglia di normalità, di ritorno a un tranquillo consenso centrista bipartisan, di nostalgia per un’epoca in cui lo scontro razziale, sociale e culturale era meno appariscente se non meno violento. Una volontà di normalizzazione destinata con ogni probabilità a scontrarsi con la realtà, tra pandemia, crisi economica alle porte, tensioni razziali senza precedenti ed emergenza climatica che incombe. Il rischio che, come già accaduto con Barack Obama, la delusione delle speranze democratiche porti a un nuovo backlash reazionarioè molto concreto. La differenza è che stavolta c’è un embrione di sinistra organizzata a lavorare in senso opposto: la rielezione trionfale di Alexandria Ocasio-Cortez e del resto della Squad, le quattro deputate di sinistra elette nella scorsa legislatura, il successo di una candidata targata Black Lives Matter e Dsa (Democratic socialists of America) come Cory Bush, insieme a tante piccole vittorie referendarie ed elettorali in giro per gli Stati uniti, mostrano, almeno in potenza, un terzo incomodo tra normalizzazione centrista ed estremismo reazionario.
Bye-Bye!
Donald Trump ha perso, ha passato un paio di giorni a twittare in caps lock di brogli, golpe e battaglie legali, e poi se n’è andato a giocare a golf. Sic transit la gloria del massimo esponente della destra mondiale, l’uomo che ha portato i neonazisti alla Casa Bianca, l’avanguardia del backlash reazionario contro l’ondata progressista. In termini elettorali la sconfitta è netta: circa 5 milioni di voti (il conteggio non è ancora terminato) di differenza. Nonostante lo stesso Trump abbia preso parecchi voti in più di quattro anni fa, il grosso dell’aumento dell’affluenza è andato a vantaggio di Biden, che migliora di oltre 10 milioni di voti il risultato di Hillary Clinton. Rispetto a Clinton, Biden riconquista alcuni stati chiave per i democratici nella cosiddetta Rust Belt, l’area industriale e post-industriale del Nord (Michigan, Wisconsin e Pennsylvania), e porta a casa anche uno stato del Sud, la Georgia, e uno dell’Ovest, l’Arizona, con ogni probabilità grazie al ruolo decisivo rispettivamente di neri e latinos. Cinque vittorie decisive, in una mappa elettorale che, con il cristallizzarsi della culture war a partire dagli anni Novanta, è diventata sempre più difficile da modificare in maniera radicale nei suoi assi portanti (Nord-Est e costa ovest ai democratici, Sud e grandi pianure ai repubblicani). La Georgia, in particolare, dopo il riallineamento politico post-segregazione, era diventata un feudo repubblicano: quella di Biden è la seconda vittoria democratica in quello stato negli ultimi quarant’anni.
Insomma, l’idea di una vittoria mutilata, di misura, per il rotto della cuffia è conseguenza soprattutto di meccanismi mediatici: l’abitudine alla maratona elettorale notturna che si conclude con la telefonata dello sconfitto e il discorso del vincitore è ormai fortemente radicata nei format televisivi, ma stavolta è andata diversamente, un po’ per il rallentamento delle procedure di scrutinio determinato dall’uso massiccio del voto postale, un po’ per la cautela dei grandi network, che non volevano vedere le proprie previsioni smentite dai fatti, come quattro anni fa. A questo va aggiunta l’incapacità di buona parte dell’establishment liberal, soprattutto nei media, di fare i conti con la sconfitta di Hillary Clinton: le elezioni del 2016, invece di essere analizzate come la risicatissima sconfitta di una pessima candidata, sono state ammantate di un alone quasi sovrannaturale. Il complotto russo, l’offensiva hacker, Cambridge Analytica, l’onnipotenza dei social, la capacità di Trump e dei suoi di leggere quasi magicamente la pancia del paese: le tante leggende nere costruite per non accettare la sconfitta di Hillary Clinton hanno diffuso nel tempo un terrore irrazionale nell’establishment democratico. Se il maleficio è avvenuto una volta, potrebbe capitare di nuovo. E invece è bastato un candidato un po’ meno impopolare di Hillary Clinton e una campagna elettorale condotta in maniera un po’ meno miope, per far scomparire all’improvviso tutta la magia.
La sconfitta di Trump ha una portata globale che non va sottovalutata. Da una parte, la sua presidenza è stata drammatica in politica estera, con buona pace dell’illusione rossobruna secondo cui si sarebbe trattato di un isolazionista meno pericoloso, sul piano internazionale, degli interventisti democratici: record di bombardamenti sull’Afghanistan, ritiro dall’accordo con l’Iran e dai trattati sui missili atomici con la Russia, sostegno ai golpe in Venezuela e Bolivia, riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele, guerra commerciale con la Cina, sostegno ai sauditi in Yemen, uscita da Oms e Unesco, ritiro dall’accordo di Parigi sul clima… Dall’altra, l’esempio e il sostegno di Trump sono stati fondamentali per la crescita dell’ondata reazionaria: dal Brasile all’India, dall’Ungheria al Regno Unito passando per l’Italia, non si può sottovalutare il ruolo simbolico e materiale che può avere il sostegno di Washington nella crescita dell’internazionale nera. Come non si può sottovalutare il ruolo di Trump nella legittimazione, simbolica e materiale, dell’estrema destra. Un presidente che dopo un corteo esplicitamente neonazista come quello di Charlotteville nel 2017, con conseguente attacco omicida ai manifestanti antifascisti, dichiara che «c’erano brave persone da entrambe le parti» non può essere liquidato come un politicante come un altro. Il giorno della sua sconfitta è un giorno di liberazione che va celebrato.
E però dobbiamo ricordarci che pochi mesi fa questa sua sconfitta era tutt’altro che scontata. Durante le primarie democratiche, i sondaggi davano Trump vincente contro qualsiasi democratico tranne Bernie Sanders e, di misura, Joe Biden. Lo stesso Biden, candidato debole e reduce da sconfitte cocenti nei suoi precedenti tentativi, ha resistito a lungo alle pressioni per candidarsi, pensando che fosse velleitario opporsi a un presidente uscente, soprattutto alla luce del ciclo economico favorevole su cui Trump poteva contare. Già è raro che un presidente uscente perda, ma perdere con il Pil in crescita e la disoccupazione in calo è pressoché impossibile. A far cambiare il clima è stata soprattutto la pandemia di Covid-19, che ha visto Trump alla guida del partito globale dei negazionisti in nome del Pil e gli Stati uniti in testa alla tragica classifica delle vite umane perse. La scommessa di Trump e di tutta la destra negazionista, cioè non fermare il contagio per non fermare l’economia, è stata persa, perché la diffusione sfrenata del contagio ha finito inevitabilmente per far crollare anche l’economia. Il risultato è che, secondo gli exit poll della Cnn, il 41% degli statunitensi ritiene che la sua condizione economica sia migliorata rispetto a quattro anni fa, e al 72% vota Trump, mentre il 58% ritiene che sia peggiorata o sia rimasta uguale, e vota Biden rispettivamente al 74% e al 64%.
Senza l’elemento economico a proprio favore, l’elezione si è concentrata sulla polarizzazione pro e contro Trump. Mentre quattro anni fa Trump era sì impopolare per milioni di statunitensi, ma altrettanto lo era Hillary Clinton, stavolta la candidatura di un personaggio molto meno controverso e visibile ha fatto la differenza: tra il 71% che dice di aver votato perché convinto del proprio candidato, ha vinto Trump 52-47, mentre tra il 24% che sostiene di aver votato principalmente contro l’avversario, è finita 67-30 per Biden. Il candidato democratico fa il pieno di chi quattro anni fa votò Clinton, porta dalla propria parte pochissimi ex elettori di Trump (appena l’8%), ma soprattutto sbanca tra chi nel 2016 votò per altri candidati (62%) e chi non andò a votare (61%). La differenza sembra tutta lì: l’affluenza è cresciuta dal 56% al 67%, e i 6 milioni di voti che quattro anni fa andarono al libertarian Gary Johnson e alla verde Jill Stein sono stati quasi completamente assorbiti dai due candidati principali.
Insomma: più che aver convinto la base avversaria, Biden è riuscito ad allargare la propria, riportando a votare, e a votare democratico, chi, per i motivi più vari, non ne aveva voluto sapere di votare Clinton. Dal punto di vista razziale e di genere, esattamente come quattro anni fa, Trump vince solo tra i bianchi, sia uomini sia donne, mentre perde in tutti gli altri gruppi. Il presidente uscente, addirittura, riduce lo svantaggio con l’avversario democratico tra neri e latinos, e aumenta il proprio vantaggio tra le donne bianche: la categoria decisiva, ancora una volta, sembrano essere i maschi bianchi, tra i quali Biden resta in svantaggio ma risulta molto meno impopolare di Hillary Clinton, recuperando ben 13 punti percentuali. La vittoria nella Rust Belt è anche figlia di questi dati, anche se rischia di essere fuorviante concentrarsi sulle percentuali in un contesto di grande aumento dell’affluenza.
Numeri che determinano una netta sconfitta, parola che però non è parte del vocabolario di Trump. La sua narrazione politica è tutta costruita sulla retorica del successo e dell’imbattibilità, la stessa che portava Silvio Berlusconi a vantarsi delle Coppe dei Campioni vinte nelle tribune politiche, e del resto neanche Silvio ha mai accettato, in tutta la propria vita politica, una sconfitta elettorale senza parlare di brogli. Eppure stavolta l’arrogante «Bye-Bye!» che Trump è solito dedicare a chi lo contesta durante i comizi, è rivolto a lui: se ne dovrà andare, e lo sa.
A destra, la sconfitta di Trump ha gettato in un gelido imbarazzo un partito repubblicano che non ha mai amato The Donald ma che ne ha avallato e sostenuto ogni scelta e che ora, fondamentalmente, non sa che fare. A congratularsi con Biden per la vittoria sono pochissimi (tra cui l’ex presidente George W. Bush e il candidato del 2012 Mitt Romney), così come, per la verità, sono pochissimi a unirsi al coro trumpiano contro i presunti brogli: la grande maggioranza dell’establishment repubblicano, guidato dall’ineffabile senatore del Kentucky Mitch McConnell, fresco di rielezione, si barcamena tra silenzi imbarazzati e dichiarazioni ambigue. L’impressione è che nessuno escluda la via della battaglia legale, sapendo di poter contare su giudici federali, e soprattutto, una Corte Suprema, fortemente caratterizzati in senso conservatore, ma che, d’altra parte, nessuno veda spiragli concreti di vittoria su quel fronte. Se nel 2000, per scippare la sacrosanta vittoria ad Al Gore, bastò fermare il dovuto riconteggio in Florida, stavolta si tratterebbe di ottenere un riconteggio in diversi stati e un’esclusione del voto postale dalle basi legali piuttosto fragili. Ne vale veramente la pena? L’intera élite repubblicana in campo politico, legale, economico e mediatico si mobilitò allora a sostegno del figlio di un ex presidente, ex direttore della Cia ed ex collaboratore di Reagan e Nixon: sarebbero disposti a fare lo stesso per Trump?
La normalità era il problema
La risposta per ora sembra negativa, anche perché queste elezioni sono andate male per Trump ma non per il partito repubblicano. Se la vittoria di Biden è stata netta, dando ragione ai sondaggi della vigilia, dove invece i commentatori hanno sbagliato di grosso è stato nel prevedere un’onda blu che avrebbe coinvolto anche camera e senato, ridisegnando in senso liberal la mappa politica americana. Così non è stato. Il conteggio del senato al momento è in pareggio 48-48, ed è estremamente improbabile che il risultato finale veda i democratici in vantaggio, mentre alla camera il partito di Biden dovrebbe riuscire a mantenere la maggioranza, seppur perdendo seggi invece di guadagnarne. Controllare il senato, per i repubblicani, significa poter mettere il veto di fatto su buona parte delle scelte del presidente Biden, sia in termini di bilancio sia soprattutto nelle eventuali nomine giudiziarie. Un campo, quello della magistratura, in cui la destra è già in una botte di ferro, data la maggioranza conservatrice 6-3 che caratterizza la Corte Suprema.
Insomma, se Joe Biden e Kamala Harris sono riusciti a non emulare il disastro di Hillary Clinton e battere Trump, non si può dire che abbiano avuto un impatto positivo sulle chance di vittoria del proprio partito. Il messaggio democratico a queste elezioni è stato fondamentalmente «non siamo Trump», e ha un difetto: non funziona quando sulla scheda non appare il nome di Trump. La strategia di riempire la convention democratica di interventi di repubblicani, da Colin Powell a John Kasich, per dare l’idea di una grande coalizione patriottica contro il matto alla Casa Bianca, si è dimostrata miope: non solo Trump ha sostanzialmente ripreso tutti i voti repubblicani che aveva preso quattro anni fa, conquistandone addirittura di nuovi, ma soprattutto i candidati repubblicani a camera e senato sono andati meglio di lui.
In particolare, sono risultate disastrose campagne come quella del cosiddetto Lincoln Project, un gruppo di consulenti politici repubblicani che ha lanciato una serie di iniziative anti-Trump, raccogliendo milioni dagli elettori democratici per sostenere non solo Biden ma anche candidati democratici centristi in seggi tradizionalmente repubblicani: di fatto, milioni di dollari sono stati bruciati in campagne mediatiche prive di qualsiasi effetto. Un quarto di miliardo di dollari, raccolti dai democratici nei giorni drammatici della morte della giudice suprema Ruth Bader Ginsburg, è stato investito in poche campagne per il senato in Kentucky, South Carolina, Texas e Alabama: tutti collegi in cui i candidati repubblicani hanno vinto con distacchi in doppia cifra. Così com’è risultata miope la scelta di non dare troppa battaglia in parlamento contro la nomima dell’ultraconservatrice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema, per non antagonizzare troppo la base repubblicana, base che in realtà era già sveglia, determinata e mobilitata, per Trump ma soprattutto per i candidati conservatori a camera e senato.
La strategia centrista e low-profile scelta dai democratici, insomma, alla ricerca dei famigerati «Biden republicans», ha mostrato limiti evidenti, e se non è riuscita nel miracoloso disastro del 2016, non ha neanche sbancato come molti si aspettavano. Il ticket, del resto, non era dei più forti: la vicepresidente Kamala Harris si ritirò dalle primarie già a dicembre 2019, prima dell’inizio del voto, non essendo mai decollata nei sondaggi, mentre Joe Biden arrivò quarto in Iowa, quinto in New Hampshire e secondo in Nevada, prima di cogliere l’unica vittoria in South Carolina e ricevere l’immediato sostegno di tutto il partito compresi buona parte dei suoi concorrenti. La serata del 2 marzo, in cui Pete Buttigieg, Amy Klobuchar e Beto O’Rourke si presentarono sul palco insieme a Biden per sostenerlo, fu una dimostrazione di compattezza dell’establishment democratico dietro cui molti vedono la mano dell’ex presidente Barack Obama. Obama, del resto, non ha fatto mancare al suo ex vice il supporto, contribuendo a creare quella sensazione di «ritorno alla normalità» che è stato il tema dominante della campagna Biden. Dopo quattro anni di follia, rumore, tensione, crisi, scontri razziali, emergenza climatica, pandemia, non può non essere attraente l’idea di tornare a qualche anno fa, a una politica più rassicurante e meno presente nelle nostre vite.
La maggior parte delle persone non ha voglia di pensare tutti i giorni alla politica, di indignarsi tutti i giorni contro il presidente, di porsi continuamente il problema di posizionarsi sul tema del giorno. Un presidente normale, di cui potersi fidare e di cui non doversi occupare: ecco quello che in molti hanno visto in Joe Biden. Un democratico normale: sostenuto dal sindacato e finanziato da Wall Street, antirazzista e amico dei segregazionisti, progressista nel linguaggio e tradizionale nei valori. Un profilo che si completa perfettamente con quello di Kamala Harris, prima donna a essere eletta alla vicepresidenza, un passaggio reso ancora più storico dal mix razziale afrocaraibico-asiatico che ne caratterizza il background. E reso ancora più splendidamente liberal dal profilo law and order, in particolare nei confronti delle comunità di colore, che l’ha caratterizzata durante la sua carriera in magistratura, nonché dalla facilità con cui ha saputo, negli anni, abbracciare posizioni progressiste quando se ne poneva l’occasione, come nel caso della battaglia per la sanità pubblica universale, per poi abbandonarle quando il vento è cambiato. Il ritorno del neoliberismo progressista in tutto il proprio splendore.
Ciò non significa, però, che l’elezione di Biden e Harris possa essere liquidata come un’operazione dell’élite, come si è letto in questi giorni. Settantacinque milioni di voti (e ancora si sta contando) non sono certo l’élite. Biden e Harris hanno vinto nelle fasce a basso reddito, tra le persone di colore, nelle città. E hanno vinto, certo, sull’onda di una campagna elettorale miliardaria, ma anche di una mobilitazione popolare straordinaria. Le elezioni americane sono molto spesso se non sempre, soprattutto quando si sconfigge un presidente uscente, delle piccole insurrezioni. Ci vuole l’attivazione di centinaia di migliaia di persone per portarne decine di milioni a votare per cacciare l’attuale inquilino dalla Casa Bianca. Se il Michigan è tornato democratico, è anche grazie a campagne come quella della deputata socialista di origine palestinese Rashida Tlaib: il 94% raggiunto a Detroit sarebbe stato impensabile senza quel livello di organizzazione grassroots. Lo stesso discorso vale per la Georgia, dove la mobilitazione di massa di attivisti e attiviste afroamericane ha portato a un ribaltamento storico, come per Philadelphia, città che è stata determinante per la vittoria di Biden in Pennsylvania. Black Lives Matter, Sunrise Movement, Dsa, Justice Democrats: c’è anche una galassia progressista, working-class, ambientalista, giovanile e di colore dietro alla sconfitta di Trump. Quando Biden dichiara di aver messo insieme una delle coalizioni più ampie della storia degli Stati uniti dice il vero: dietro la sua vittoria ci sono, in modi diversi e in forme diverse, sia Wall Street sia Black Lives Matter, sia gli scioperi degli insegnanti sia i finanziamenti della Silicon Valley. Chi segue la politica con forti appartenenze ideologiche, com’è il caso tra i redattori e tra molti lettori di questa rivista, compreso chi scrive, tende spesso a vedere le distinzioni politiche in maniera molto netta ed evidente: Bernie Sanders è un socialista, Biden e Harris due liberali, c’è chi sta da una parte e chi sta dall’altra. La realtà della base democratica è molto più sfumata: la stragrande maggioranza degli elettori democratici condivide in grandissima parte la piattaforma socialista di Sanders, è favorevole alla sanità pubblica universale, a un aumento del salario minimo, a una tassazione più redistributiva, a maggiori tutele sul lavoro, ma allo stesso tempo considera Biden e Harris dei punti di riferimento e mette la sconfitta di Trump in cima alla lista delle priorità. Ama la giovane outsider di sinistra Alexandria Ocasio-Cortez ma ammira anche la vecchia volpe parlamentare centrista Nancy Pelosi. In questo, per quanto il contesto sia diverso, soprattutto per le caratteristiche personali del presidente eletto, non può che tornare in mente il precedente dell’elezione di Obama del 2008.
Il problema, al di là delle preferenze personali, è che quell’esperimento ha già fallito nei due mandati di Obama, al termine dei quali, andrebbe ricordato, ha vinto le elezioni Donald Trump. Vincere le elezioni sulla base di una grandissima ondata di mobilitazione popolare con venature progressiste e poi non incidere se non in forma limitatissima sulla vita materiale delle persone significa alimentare in forma potentissima il motore del risentimento, quella macchina infernale da cui escono i voti per la destra peggiore. Se dopo due mandati di Obama è arrivato Trump, dà i brividi pensare a chi potrebbe arrivare dopo un mandato Biden-Harris. Soprattutto se teniamo conto che le posizioni di destra radicale incarnate da Trump non sono una sua invenzione effimera ed estemporanea, ma un tratto ormai strutturale all’interno del partito repubblicano. Quella destra non sparirà con il parrucchino biondo che l’ha incarnata in questi quattro anni.
I presupposti per la svolta centrista e business-friendly ci sono tutti. L’establishment mediatico liberal ha passato i giorni dell’incertezza a sparare a palle incatenate contro la sinistra. Il calo democratico nella contea di Miami, in particolare, attribuito alla mobilitazione della comunità cubana contro il «rischio socialista», è stato preso a pretesto per un attacco martellante contro Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez e qualsiasi figura politica di sinistra, con l’idea che se i fantomatici «Biden republicans» non si sono visti è perché la sinistra li ha spaventati, così come se la base conservatrice si è mobilitata, è perché le piazze di Black Lives Matter hanno polarizzato troppo. Come se anche Obama, all’epoca, non fosse stato tacciato di socialismo ed estremismo dalla propaganda repubblicana. In piena maratona elettorale, la Cnn intervista l’ex governatore repubblicano dell’Ohio, e sostenitore di Biden, John Kasich, al grido di «i democratici si devono rendere conto che l’estrema sinistra è quasi costata loro le elezioni». La ricreazione è finita, tutti a casa. Si poteva manifestare contro il razzismo e chiedere una sanità universale sotto il cattivone Trump: sotto Biden, è ora di abbassare i toni e allinearsi alle aspettative limitate del consenso centrista.
Alternative
Alla fine le elezioni 2020 non sono state come quelle del 1968, un trionfo law and order contro le proteste di piazza, ma neanche come quelle del 1932, una svolta politica che aprì spazio alle rivendicazioni popolari verso il New Deal. La destra è stata sconfitta, ma gli spazi per una svolta a sinistra sembrano ridotti.
Due diverse interviste pubblicate nel weekend dal New York Times rendono bene l’idea: da una parte il deputato democratico della Pennsylvania Conor Lamb attaccava la sinistra sostenendo che «messaggi come il taglio dei fondi alla polizia o la fine del fracking sono impopolari e irrealistici» e hanno danneggiato il partito; dall’altra, la sua collega di New York Alexandria Ocasio-Cortez metteva in guardia contro l’immobilismo centrista del partito. «Bisogna che i miei colleghi capiscano che non siamo il nemico – ha detto Ocasio-Cortez – Che la loro base non è il nemico. Che Black Lives Matter non è il nemico, che la sanità pubblica universale non è il nemico. Non lo dico per vincere la battaglia interna. È che se continuano ad andare nella direzione sbagliata, stanno apparecchiando la loro stessa obsolescenza».
La battaglia, ora, è quella sulla transizione di Biden verso la Casa Bianca e sulle nomine che la contraddistingueranno. Il clima politico rispetto a pochi giorni fa è drasticamente più a destra: l’idea di un Sanders ministro del lavoro è fuori discussione, si ragiona di nomi moderati e rassicuranti, con magari qualche repubblicano a dare l’idea di una nuova fase bipartisan. «La storia del partito tende a essere che dopo una grande eccitazione dal basso per essere eletti, poi quelle comunità vengono subito abbandonate dopo le elezioni – ha ricordato Ocasio-Cortez – Penso che la transizione ci indicherà se l’amministrazione avrà un approccio aperto e collaborativo o meno. La transizione di Obama segnò la traiettoria che ci portò alla sconfitta elettorale del 2010 [alle elezioni di midterm dopo la vittoria del 2008, ndr]. Le decisioni prese nella transizione, e chi fu messo in posizioni di leadership, segnarono, prevedibilmente, la strategia del governo».
La differenza, rispetto all’era Obama, sta nell’esistenza di una sinistra, per quanto di dimensioni ancora limitate. Le due deputate socialiste uscenti, Alexandria Ocasio-Cortez e Rashida Tlaib, sono state confermate con percentuali bulgare, e a loro si aggiungono altri due membri dei Democratic Socialists of America: Cori Bush, eletta nel Missouri, attivista di Black Lives Matter fin dai tempi di Ferguson e Jamaal Bowman, eletto a New York. Altri deputati progressisti, sostenuti dai Justice Democratics sono stati rieletti: Raúl Grijalva, Ro Khanna, Ayanna Pressley, Ilhan Omar e Pramila Jayapal, a cui si aggiungono Marie Newman e Mondaire Jones. I Dsa hanno eletto inoltre cinque socialisti nel parlamento statale di New York, tre in quello della Pennsylvania e altre rappresentanze in Minnesota e Montana. Sul piano referendario, la Florida ha votato per l’aumento graduale del salario minimo fino ai 15 dollari all’ora, numerosi stati hanno approvato l’aumento dei finanziamenti alle scuole pubbliche, il Colorado ha respinto una serie di norme antifemministe, l’Oregon ha fatto passare un aumento delle tasse ai ricchi per finanziare l’asilo nido universale, per non parlare dei numerosi stati che hanno legalizzato la marijuana. La galassia progressista, working-class, ambientalista, giovanile e di colore di cui si parlava prima, è un campo. Questa mobilitazione è stata fondamentale per la vittoria di Biden: può andare sprecata nella delusione del suo operato, o può essere organizzata.
Come abbiamo scritto tante volte, non si può tornare a Obama perché Obama c’è già stato. Un pezzo significativo della società americana, anzi, tanti pezzi diversi dal punto di vista sociale, generazionale e razziale, sono già disillusi verso il liberalismo. Sanno bene che il «ritorno alla normalità» non ha nulla da offrire. Molti di loro hanno votato Biden per cacciare Trump, ma sanno bene che, di fronte a sfide come la pandemia o l’emergenza climatica, la presidenza Biden è un calcio un po’ più in là al barattolo. Meglio che inciampare e sbattere il naso a terra, ma la soluzione, se c’è, è altrove, e si giocherà sia nelle piazze dei prossimi mesi e anni, sia nelle urne delle elezioni parlamentari del 2022 e presidenziali del 2024.La sfida, di fronte al rischio che la gioia per la cacciata di Trump si trasformi presto in delusione per la riproposizione della solita governance neoliberista, è quella dell’organizzazione. Che la strada sia, come sostengono molti a sinistra, la creazione di un partito autonomo, oppure, come ritengono altri, la crescita dell’influenza della sinistra dentro il partito democratico, il passaggio necessario è lo stesso, e cioè il rafforzamento dei meccanismi di coordinamento tra eletti, movimenti, sindacato e organizzazioni politiche che hanno permesso vittorie decisive a livello locale, e che risulteranno determinanti nelle battaglie a venire.
Questo articolo è stato pubblicato su Jacobin Italia il 9 novembre 2020