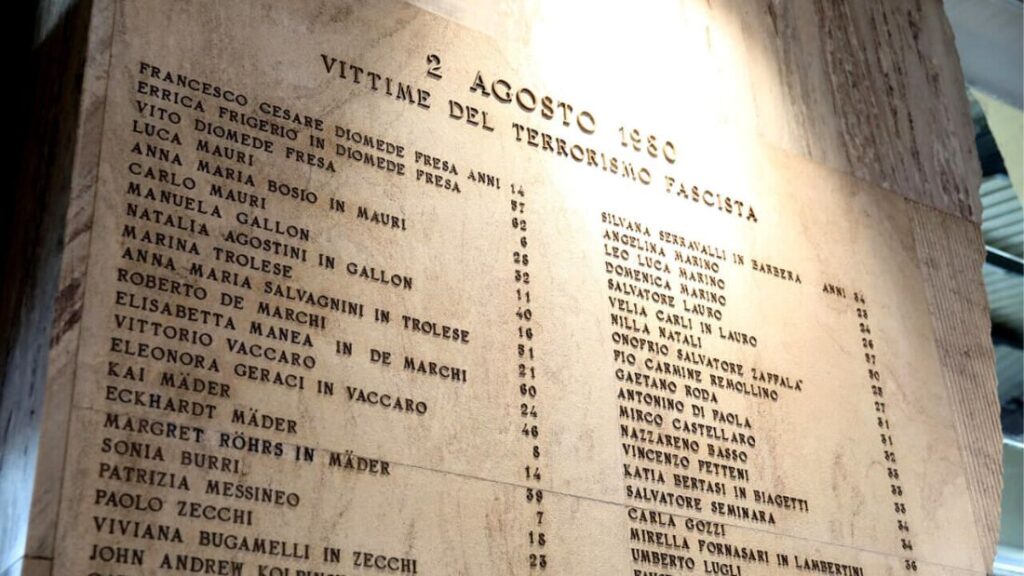Donald Trump. Molte cose possono ancora accadere prima del 20 gennaio alle 12, ora locale, quando Joe Biden dovrebbe giurare come 46° presidente degli Stati Uniti
È fatta. Forse. Mentre il mondo civile tira un sospiro di sollievo al pensiero che il gangster approdato nel 2016 alla Casa Bianca se ne vada, sarà bene ricordare che l’annuncio dell’Associated Press «Biden presidente-eletto» non è sufficiente.
In tempi normali lo sarebbe e lo sconfitto telefonerebbe al vincitore per congratularsi, ma questi non sono tempi normali e Trump non è un politico normale bensì un megalomane narcisista e violento. In effetti, molte cose possono ancora accadere prima del 20 gennaio alle 12, ora locale, quando Joe Biden dovrebbe giurare come 46° presidente degli Stati Uniti.
Prima di tutto i conteggi dei voti devono essere terminati e in tre stati chiave, Pennsylvania, Wisconsin e Georgia le schede saranno ricontate. Occorre poi che gli stati certifichino la vittoria e assegnino il pacchetto dei delegati nel collegio elettorale a Biden: dovrebbe accadere anche in Arizona, portando il totale complessivo del candidato democratico a 306 grandi elettori. Questi si dovranno poi riunire nelle capitali dei rispettivi stati il 14 dicembre e votare effettivamente per Biden (e gli altri 232 per Trump).
Occorre notare che però i grandi elettori non sono obbligati a votare per il candidato che rappresentano. Benché il fenomeno sia raro, i faithless electors esistono: per esempio nel 2016 ben sette grandi elettori votarono per un candidato diverso da quello per cui avrebbero dovuto. Tre voti andarono a Colin Powell, uno a Bernie Sanders, uno a John Kasich, uno a Ron Paul e uno a un capo Sioux.
Voti perfettamente validi e quest’anno, se il margine nel collegio elettorale fosse molto piccolo, la corruzione o l’intimidazione potrebbero rovesciare un risultato che oggi tutti danno per scontato.
Probabilmente non accadrà: i tweet roboanti di Trump e dei suoi scherani, gli appelli alla Corte Suprema e le tecniche intimidatorie sembrano per ora minacce a vuoto. Il tentativo di mantenersi al potere pur avendo ricevuto ben quattro milioni di voti meno di Biden, un golpe bianco con l’aiuto dei giudici amici della Corte Suprema, in queste ore sembra fallito. Sui motivi di questo fallimento vale la pena di soffermarsi.
Donald Trump è un uomo di televisione, quindi non legge. Se lo facesse, avrebbe tenuto sul comodino The Dictator’s Handbook di Bruce Bueno de Mesquita, che è un serio scienziato politico americano e spiega a lunghezza di 322 pagine perché «i cattivi comportamenti sono quasi sempre buona politica». Purtroppo, in questo sottotitolo del libro, la parola chiave è «quasi»: non sempre mentire, intimidire, creare lager per i migranti, violare le regole e minacciare gli avversari è davvero una buona politica.
Trump ha un talento naturale per le bugie e il suo stile provocatorio, i suoi i comportamenti da bullo di cortile piacciono a decine di milioni di americani. Questo non è sorprendente: le personalità autoritarie spesso attraggono le folle, è una malattia della democrazia da cui non siamo vaccinati. Quando il gioco si fa duro gli aspiranti dittatori che vogliono mantenersi al potere devono però seguire il manuale perché i golpe, i semi-golpe e le elezioni truccate non sono cose da dilettanti.
E il manuale prescrive: prima di tutto occorre il cash, la grana, i dobloni, o magari i Bitcoin, insomma qualcosa con cui corrompere chi potrebbe ostacolare i propri piani. Trump forse è ricco e forse no, ma comunque è sempre stato piuttosto sparagnino con i suoi soldi: per esempio vinse la campagna elettorale del 2016 spendendo molto meno di Hillary Clinton e non risulta che quest’anno ne abbia usati, come fanno molti politici negli Stati Uniti.
Secondo: occorre essere certi dell’appoggio dei settori che contano nel paese, in particolare dei militari (de Mesquita ha letto Mao: «Il potere nasce dalla canna del fucile».
Al contrario, Donald Trump si è circondato immediatamente di generali ma poi li ha licenziati tutti: Jim Mattis, Michael Flynn, H. R. McMaster. Non solo: ha comprato un sacco di giocattoli per le forze armate ma ha offeso eroi di guerra intoccabili come John McCain (prigioniero in Vietnam e poi senatore). Ha insultato le famiglie di caduti in Afghanistan, insomma non ha capito che mantenere la lealtà dei militari esige qualcosa di più che immaginare parate di stile nordcoreano a Washington.
Terzo: l’establishment conta, e se un aspirante dittatore vuole mantenersi al potere dopo la fine del suo mandato, occorre che esso sia d’accordo. I finanzieri sono stati ovviamente felici dei lussuosi regali fiscali dell’amministrazione Trump ma sono sufficientemente rassicurati dal vittorioso Joe Biden per essere certi che il nuovo presidente non toccherà i loro privilegi. L’indice Dow Jones non ha fatto una piega quando Trump lanciava i suoi tweet incendiari, considerandoli parte dello spettacolo, non annunci di guerra civile.
Insomma: Trump ha dietro di sé 70 milioni di voti ma né l’oro né la spada, per citare il titolo di un celebre libro di Charles Tilly sulle radici del potere negli ultimi mille anni. Per questo ha fallito (salvo sorprese da qui al 20 gennaio).
Questo articolo è stato pubblicato su Il manifesto l’8 novembre 2020