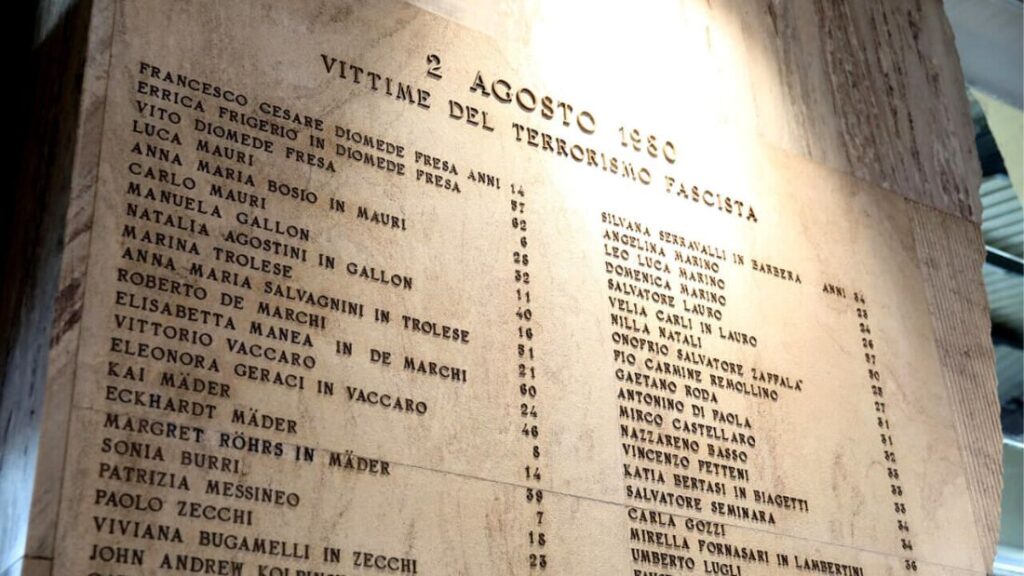Un sovrumano silenzio e una profondissima quiete gravano sulla vita dell’Università italiana e il fatto che il ministro che la governa sia un ex rettore, un uomo che viene da quel mondo, non sembra cambiare le cose. La nostra Università, quale protagonista attivo della vita civile del Paese, non c’è più. E non l’ha uccisa il Covid 19, ma un insieme di processi e di scelte, che l’hanno radicalmente trasformata.
È antropologicamente cambiato il corpo dei docenti. Da 10-15 anni ha lasciato l’insegnamento un’ampia schiera, quella che potremmo chiamare la generazione dei maestri. Studiosi che dagli anni ’50 in poi hanno portato, accanto ai saperi delle loro discipline, un grande afflato civile, legato alle sorti del paese. È poi seguita un’altra generazione di insegnanti, quelli che da studenti hanno attraversato l’esperienza del ’68 e comunque si sono formati nell’Italia dei conflitti sociali e delle grandi manifestazioni di massa.
Oggi, nella fascia alta dei docenti, dominano figure anche scientificamente attrezzate, ma che vivono il proprio lavoro come un ritaglio specialistico, finalizzato a dei risultati da certificare presso agenzie di controllo. Sono sotto l’assedio quotidiano di un flusso continuo di disposizioni normative, soffocati da compiti organizzativi mutevoli, spesso di difficile comprensione, da pratiche quotidiane di interpretazioni e applicazioni che sottraggono tempo alla ricerca e a un insegnamento non di routine. È comprensibile che questi docenti non abbiano molti legami con la vita politica e culturale della società.
Più in basso lavorano le figure dei ricercatori, che devono attraversare un lungo purgatorio di precarietà, impegnati non a realizzare ricerche fondative per il proprio profilo di studiosi, ma per produrre quanto più possibile titoli – anzi “prodotti” come vengono definiti con gergo di fabbrica – per salire la scala della carriera accademica.
Qui, al gravissimo scadimento scientifico e culturale, che dà luogo a pubblicazioni seriali di brevi articoli e saggi di scarso valore, si accompagna una subalternità politica dei giovani ricercatori. Grazie alla riforma Gelmini queste figure, oggi come nel peggiore passato, debbono la propria possibilità di carriera alla fedeltà ai professori ordinari, e soprattutto alla propria latenza politica, al loro carrieristico conformismo.
Infine un altro grande mutamento ha cambiato i connotati degli studenti. In linea di massima – e questo appare in maniera parossistica nelle Facoltà umanistiche – non studiano per un itinerario formativo, ma vanno a caccia di crediti da mettere insieme secondo una disposizione cumulativa, finalizzata ai risultati, che distrugge alla radice lo studio quale esperienza di riflessione. I ragazzi oggi non ascoltano lezioni, ma corrono da una cattedra all’altra a raccattare punteggi. E occorre ricordare che mai una generazione era stata così tenacemente avversata, come quella dei nostri ragazzi, ai quali viene impedito di proseguire negli studi con ogni mezzo, dal numero chiuso in tante facoltà all’aumento delle tasse universitarie.
Da questo mondo regredito, schiacciato sotto il peso di una ideologia produttivistica che soffoca ogni visione generale, incatenato alla precarietà, non può più venire alcun moto di ribellione, né tanto meno un conato di revisione dello status quo. È necessario che a intervenire sia dunque il ceto politico di governo e lo deve fare al più presto, anche perché molti miglioramenti sono possibili senza esborsi finanziari.
È necessario abolire l’Anvure e i suoi criteri di valutazione industriale della ricerca, cancellare i crediti a partire dal lemma finanziario che li designa, rivedere il 3 più 2 e i percorsi delle lauree brevi, riformare i criteri dell’accesso alla docenza, bandendo la precarietà che è il vessillo funesto dell’ideologia neoliberistica, la pestilenza culturale universale da cui dipendono i fallimenti a catena del nostro tempo.
Nell’Università è urgente un’opera demolitrice di delegificazione. Liberiamo i docenti da compiti inutili di controllo produttivistico. Ma forniamo anche risorse per fare accedere una nuova leva di docenti, che ha accumulato studi ed esperienze e vive ai margini.
Nel momento in cui l’Ue rivede alcuni dei suoi erronei fondamenti costitutivi, occorre ricordarsi che l’Università è una loro vittima, a partire dal cosiddetto “processo di Bologna”. Non avrei tante speranze, tuttavia, in queste possibilità, se non fosse che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunziato un convegno internazionale sul nuovo umanesimo. Dopo decenni di emarginazione dei saperi umanistici dalle nostre università e dalla considerazione pubblica, questa è una novità che sorprende e che ci dà qualche speranza.
Questo articolo è stato pubblicato su Emergenza Cultura il 2 ottobre 2020