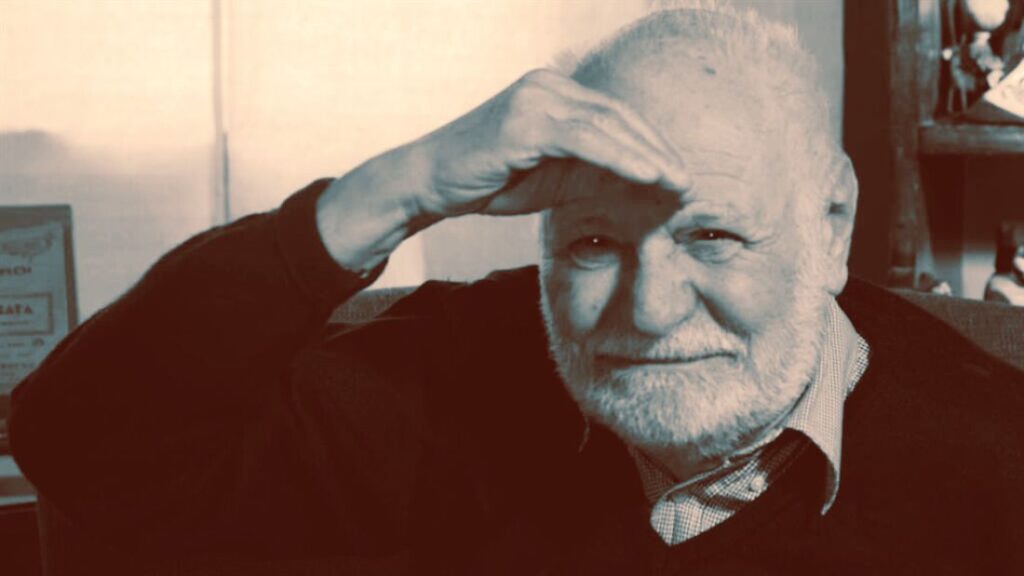Da Lodi a Bergamo, dal presunto paziente zero alla teoria dei camion dell’esercito che all’alba trasferivano un carico tragico di bare, lasciandoci una immagine che resterà nella memoria… La metà dei morti contati in Italia sono stati cittadini lombardi. Cittadini lombardi sono stati il quaranta per cento dei contagiati. Sono numeri dell’Istituto superiore della sanità, numeri imprecisi, imperfetti, comunque in divenire. Alla Lombardia resta ad esempio il record dei positivi del dopo ferie, dell’impennata di fine agosto… La Lombardia (o almeno una parte della Lombardia, quell’imprevisto triangolo rosso tra Milano e i confini con il Veneto e l’Emilia) ha condotto la danza del virus in Italia, fino ai più nefasti epiloghi, ha condizionato la difesa e poi la controffensiva, attraversando momenti che lasciavano temere la resa.
La Lombardia è la regione più popolosa d’Italia (dieci milioni di abitanti nel 2019), la più ricca, dove si concentrano attività industriali e terziarie di ogni genere, centro di scambi internazionali, meta turistica (quindici milioni di turisti all’anno). A Milano arrivano da ogni angolo del mondo, attratti da feste, mostre, saloni, movide, negozi, eccetera eccetera, tutto ciò che fa consumi e che, dall’Expo in poi, fa anche il cosiddetto “modello Milano”, che riempie d’orgoglio sindaco e amministratori, che può incantare l’occasionale passeggero, che premia chi è già stato premiato dalla sorte, che lascia indietro migliaia e migliaia di cittadini, che discrimina e che illude all’apparenza di un benessere diffuso e sottocosto.
Quasi per uno scherzo, per una sorta di legge del contrappasso, il coronavirus si è sistemato in alcune delle zone più opulente della regione e d’Italia, tra fabbriche e capannoni, capitali della logistica stile Amazon e grattacieli del terziario: nel Lodigiano, nella Bergamasca, nel capoluogo naturalmente. La resistenza a chiudere, al di là delle strumentali polemiche su chi dovesse decidere, viene da lì: dal rapido conto dei fatturati che si sarebbero assottigliati per via del lockdown, dalla previsione della crisi o dalle speculazioni dei furbi. Così anche per Milano, non certo risparmiata, malgrado gli incoraggiamenti del sindaco Sala: “Milano non chiude”.
A distanza di mesi, a risultati rilevati prima del “liberi tutti” agostano, si è dovuto constatare come la chiusura sia stata l’unica misura efficace, ovunque e pure in Lombardia, ovviamente, malgrado l’efficienza lombarda avesse lasciato supporre altri strumenti, altri rimedi, altra forza, in virtù della sua modernità, del suo dinamismo, persino del suo civismo, ma anche di quella “eccellenza” in campo sanitario, sempre vantata dai suoi presidenti regionali, da Formigoni ai leghisti Maroni e Fontana, e dai loro assessori. È accaduto, invece, al picco epidemico, raggiunto nella seconda metà di marzo, ciò che meno ci si doveva attendere: che un sistema ospedaliero tanto esaltato sopravvivesse a stento sull’orlo del baratro, costretto a inventare posti letto in terapia intensiva, costretto a rimediare corridoi e stanze abbandonate da tempo o a inventare improvvisate tendopoli (merito degli alpini a Bergamo), costretto a chiedere a medici e infermieri sacrifici (e persino, in non pochi casi, la vita). Costretto persino a inseguire ovunque nel mondo quei presidi elementari come le mascherine o i camici (con relativi scandali, coinvolti personaggi come il presidente Fontana e i relativi parenti o come l’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, indagata per frode in commercio, falso documentale, violazione dei dazi doganali, causa appunto l’importazione di materiali fuori norma venduti comunque per buoni).
Il quadro lo si legge dipinto con precisione in un articolo inviato al prestigioso “New England Journal of Medicine” dai medici rianimatori dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: “La situazione è disperata, lavoriamo ben al di sotto dei nostri standard di cura. Si attendono ore per un posto letto in terapia intensiva. I pazienti più anziani non vengono rianimati e muoiono da soli senza cure palliative appropriate…”.
La crudeltà della condizione era stata dichiarata senza ipocrisie negli stessi giorni da un documento pubblicato dalla Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), impressionante fin dal titolo: “Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili”. Cioè l’etica clinica tirata in ballo per decidere chi salvare e chi no, quando i mezzi non bastano per tutti. Come spiegavano i medici che avevano preparato le raccomandazioni, “uno scenario di questo genere è sostanzialmente assimilabile all’ambito della medicina delle catastrofi”.
Il linguaggio è inerte, come una previsione del tempo, la logica fredda e spietata: salvare chi più merita, perché è giovane, perché gli si attribuiscono prospettive di vita più lunga e migliore. Fino alla cinica constatazione a bilancio delle perdite, constatazione divenuta senso comune: beh, in fondo muoiono solo i vecchi e più di tutti i vecchi malati, quasi una liberazione per loro, un pensiero che è ricorso in lungo e in largo. Tutto si poteva comprendere e giustificare nel segno della “catastrofe”, provocata dal morbo straniero (l’invasione degli ultracorpi).
La “catastrofe” ha messo a nudo, alle prese con l’emergenza, l’inadeguatezza del “modello sanitario”, che aveva messo in piedi dalla fine degli anni novanta Roberto Formigoni, il ciellino trasferito alla corte di Berlusconi, il presidente regionale (tra i primi, a scegliere per sé la definizione di “governatore”), travolto nel 2013, a metà del quarto mandato, dagli scandali e dalle accuse, ancora agli arresti domiciliari, dopo la condanna per associazione a delinquere e corruzione ai danni proprio di quel “sistema sanitario”, che lui aveva caldamente promosso e che i suoi eredi leghisti, Maroni e Fontana, hanno via via perfezionato. Le origini della “catastrofe” stanno lì, in quelle politiche, riassumibili nella progressiva esaltazione del “privato” a detrimento del “pubblico”. Formigoni aveva affermato il principio della “libertà di scelta”: al cittadino la facoltà di decidere a chi rivolgersi, ospedale pubblico o clinica privata. Per consentirlo la Regione di Formigoni aveva foraggiato l’imprenditoria sanitaria perché realizzasse strutture i cui servizi sarebbero stati rimborsati da risorse pubbliche. Si costruiva, si adattava: cliniche, ambulatori, laboratori. Un fiume di soldi per i privati, pronti a intervenire là dove i vantaggi si prevedevano più consistenti, ben consapevoli che allestire e gestire un “pronto soccorso” o posti letto in terapia intensiva, per fortuna non sempre occupati, costa moltissimo e rende poco, quasi uno spreco secondo una logica aziendale, mentre un reparto di cardiochirurgia frutta copiosamente, perché un intervento al cuore vale trenta/quarantamila euro (con il risultato che la Lombardia può contare trentaquattro reparti di cardiochirurgia, quanti esistono in un paese intero come la Francia). Senza peraltro che per il mutuato comune le attese per una visita specialistica o per un esame diminuissero. A pagamento tutto si risolve nel giro di pochi giorni, senza lo spettro di una sola coda.
La salute è diventata un affare. Basta qualche locale dove sistemare macchinari per radiografie, ecografie, colonscopie, secondo il più diffuso armamentario di esami diagnostici, e una convenzione regionale per prosperare. Il privato esegue, la Regione paga, il paziente s’adatta: prima o poi una malanno si scoprirà, con relativo carico di farmaci (altra manna per l’industria farmaceutica), un’ulteriore dose di controlli, svariate terapie (la fisioterapia imperversa, anche quando basterebbe un po’ di sana ginnastica preventiva), interventi, ricoveri… Una macchina perfetta, che grava sul bilancio dello Stato centrale e di conseguenza sulle spalle del contribuente onesto. La strategia lombarda che ha moltiplicato il peso della sanità privata e quindi la spesa ha trovato il contrappeso nella corsa al risparmio a scapito del pubblico: tagli dunque dalla legge finanziaria in giù, colpendo la cosiddetta medicina territoriale, tornata di moda in questi tempi epidemici, ma già definita da Maroni obsoleta. Oggi la Lombardia è la regione con il minor numero di medici di base in rapporto alla popolazione (1 ogni 1.400), superata solo dalla provincia autonoma di Bolzano. Il “medico della mutua” o il “medico condotto” da indispensabili riferimenti e formidabili diagnostici sono spesso diventati solo dispensatori di ricette e sottoscrittori di esami inutili (Alberto Sordi alias dottor Guido Tersilli aveva previsto tutto). Con la scusa della loro inadeguatezza sono stati cancellati decine di piccoli presidi ospedalieri distribuiti nelle varie provincie, utilissimi luoghi di interlocuzione per gli stessi medici di base. Con il risultato di smantellare una rete che avrebbe potuto agire da filtro preventivo e da prima efficace selezione dei casi di covid, registrati fin dall’autunno scorso, come si è scoperto poi: ma a chi poteva rivolgersi il nostro “medico della mutua”?
L’inadeguatezza di una organizzazione sanitaria concentrata sui grandi ospedali è stata sancita anche da un rapporto della Corte dei Conti: “Se aveva sicuramente una sua giustificazione a tutela della salute dei cittadini la concentrazione delle cure ospedaliere in grandi strutture specializzate riducendo quelle minori che, per numero di casi e per disponibilità di tecnologie, non garantivano adeguati risultati di cura, la mancanza di un efficace sistema di assistenza sul territorio ha lasciato la popolazione senza protezioni adeguate”.
A proposito di “risparmi” si dovrebbe aggiungere che ormai anche per il giovane medico d’ospedale si viaggia a contratti a termine, co.co.co, precariato, a millecinquecento euro al mese.
La riforma lombarda verrà probabilmente riformata: una scadenza era stata fissata per questo stesso anno.
Ma prima che all’ingegneria sanitaria, si dovrebbe pensare alla cultura, ripristinando l’idea che non sono leciti gli affari in nome della salute e che la ricerca del profitto fa a pugni con la salute, che non si può accettare che il mercato, dei farmaci o delle radiografie o della chirurgia (molti ricorderanno il caso della clinica Santa Rita, dove si decidevano interventi spesso inutili, talvolta letali) diventi il faro anche della salute, in preda al consumismo, come qualsiasi oggetto del nostro orizzonte merceologico. Sfogliare le pagine di un giornale qualsiasi o guardare la televisione è un continuo incappare nella proposta di vitamine, antidepressivi, integratori, analgesici, antinfiammatori, sonniferi, eccetera eccetera.
Si dovrebbe tornare alla politica, una politica dei valori contro una politica a caccia solo del consenso con le armi della demagogia e dell’opportunismo, inconsistente di fronte al potere economico, con il quale intrecciare alleanze occasionali del tutto indipendenti da un disegno orientato al bene comune. La Lombardia ha offerto il suo esempio: pessimo, come attesta per giunta il continuo strumentale conflitto elettoralistico innescato dai vertici regionali contro il governo, quando le circostanze chiedevano la massima collaborazione. Chi più chi meno tutti colpevoli: ci si può indignare di fronte alla impresentabile volgarità di una destra senza costrutto, senza intelligenza, solo urlacci di propaganda, ma non si può occultare la fragilità di una sinistra che non sa costruire una propria identità e neppure una propria unità. Poi c’è il “popolo”. Ma che cosa può dare il “popolo”, altra tessera del nostro disastro?
Questo articolo è stato pubblicato su Gli Asini il 15 settembre 2020
Foto di Anna Castellone