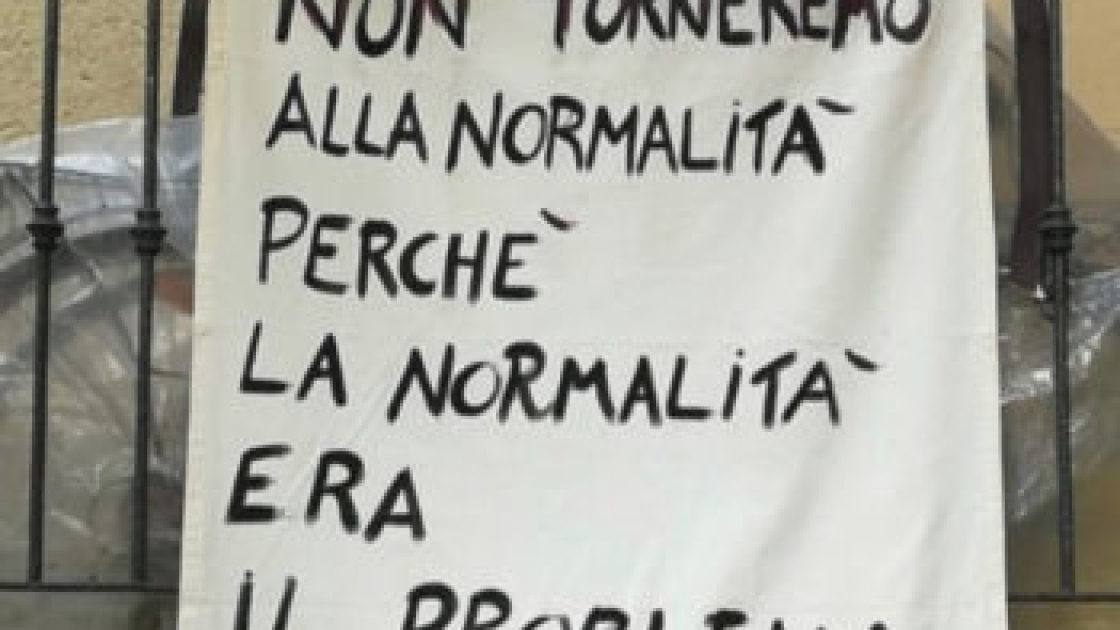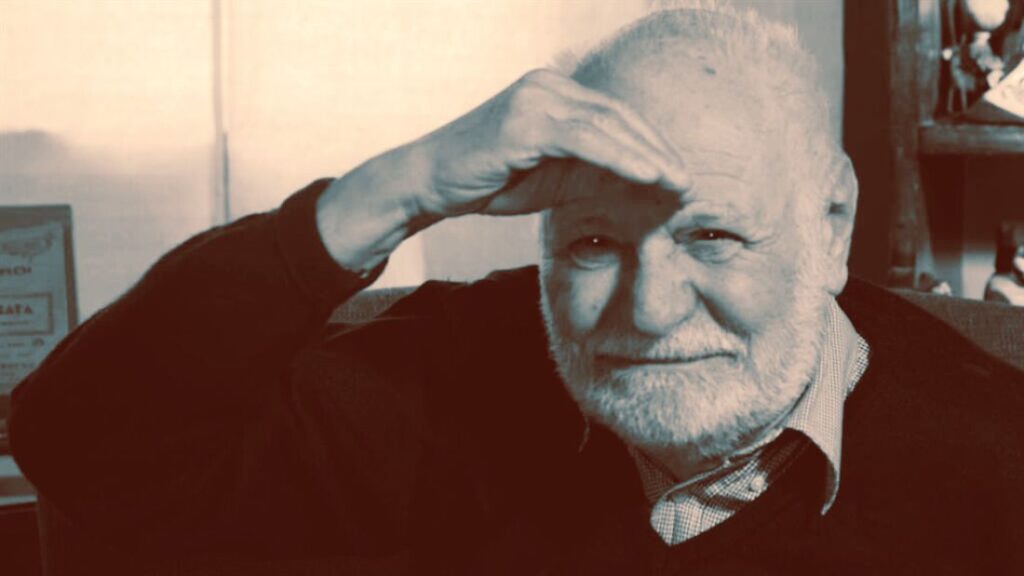La partita fiscale si è aperta con l’usuale lessico mellifluo. Tanto squillante nel sottolineare chi ne trarrà vantaggio quanto reticente nell’indicare chi pagherà il conto. L’erario si pavoneggia elencando le sue presunte virtù: equo, trasparente, efficiente. Lungimirante e benefico si preoccuperà di parità di genere, salute del pianeta e dei suoi abitanti, di innovazione, creatività, realizzazione di sé.
Quasi la pubblicità di un’azienda universitaria telematica. E, non troppo in vista e con molto pudore, la parolina «progressività» non può essere evitata. Del resto sta scritta nella Costituzione e, visti i precedenti, non dovrebbe spaventare nessuno. L’importante è mascherare squilibri e rapporti di forza dietro il «bene supremo della nazione». Questo quadro universalmente rassicurante fa a pugni con l’asprezza dello scontro che si prepara per la distribuzione delle risorse, cospicue ma comunque mai sufficienti, mobilitate (al momento solo nelle intenzioni) per fronteggiare la crisi economica su cui la pandemia si è innestata conducendola alle sue estreme conseguenze.
Il mercato, cui l’ideologia dominante riserva da decenni l’ultima parola, si è in larga misura ritirato in una palude da cui emergono pochi isolotti di accresciuta ricchezza. E se restaurarne il predominio rimane l’obiettivo principale dei suoi sacerdoti, le imprese puntano per l’intanto a occupare interamente lo spazio «fuori mercato» dell’intervento pubblico. Imponendosi come unico soggetto capace di trasformare queste risorse in una «ripresa» che coincida, va da sé, con lo sblocco del processo di accumulazione.
Fatto sta che in un contesto di diseguaglianza estrema il mercato (che comporta una diffusa capacità di spesa) non può essere riattivato da quegli stessi soggetti (economici e politici) che questa diseguaglianza hanno prodotto e continueranno a produrre. A maggior ragione in presenza di un crollo catastrofico i cui tempi di recupero si annunciano non brevi, il reddito si impone come una «variabile indipendente» dai tempi e dall’entità dei profitti. Una priorità assoluta, insomma, come lo è stata la salute dei cittadini nella fase più acuta della pandemia. La riforma fiscale è con tutta evidenza il principale teatro di questo conflitto.
Vi si fronteggiano principalmente due ideologie: quella dell’imprenditore privato e quella dell’imprenditore pubblico. Entrambe con la pretesa di mirare al benessere generale della comunità per il tramite del lavoro. La prima promettendo uno «sgocciolamento verso il basso» della ricchezza prodotta nel processo di accumulazione, la seconda imponendosi come timoniere politico dello sviluppo, delle sue forme, dei doveri e degli obblighi che vi sarebbero connessi. Gli uni rimpiangendo i tempi d’oro delle reaganomics, gli altri la Cassa del Mezzogiorno e la programmazione.
Quanto questi modelli vadano a cozzare con la realtà contemporanea, con le sue condizioni oggettive e aspettative soggettive non è difficile percepire. Sul fallimento del neoliberalismo come «nuova ragione del mondo» (che coincide in realtà con il suo pieno successo) è quasi superfluo ritornare, tante sono ormai le analisi e i riscontri fattuali. Ma anche le dottrine dirigiste, che pregustano una riscossa, dovrebbero fare i conti con la realtà delle classi politiche che il presente ci offre, con i loro processi di formazione, con il deperimento delle pratiche democratiche, con il fatto che il rapporto squilibrato e autoritario tra governanti e governati non è esclusivamente riconducibile all’invadenza dei poteri economici.
Arroganza, ignoranza e stupidità fanno la loro parte. Con il tramonto della contingenza storica che alla programmazione aveva offerto ampi spazi di agibilità e consenso sociale. Tra i due «imprenditori» che si accingono a spartirsi le risorse del dopo Covid, laddove il «dopo» resta per ora una pia speranza, le forze sociali travolte dalla crisi devono porsi come un terzo incomodo. Intendendo con questo che le politiche fiscali non possono essere lasciate a una partita truccata tra governo e confindustria, tra rappresentanze politiche e imprenditori, tra una presunta sinistra e una riconoscibile destra, ma devono essere assunte come un terreno di scontro e rivendicazione diretta.
Come è accaduto in Francia con il movimento dei gilet jaunes che ha messo in crisi il decisionismo di Macron, trascinandosi dietro buona parte dei francesi a partire dalla contestazione di un’accisa. Governi, imprenditori, corporazioni, tutti reclamano sovvenzioni «a fondo perduto». Perché mai precari, esclusi, cittadini già impoveriti e travolti dalla crisi non dovrebbero reclamare a loro volta reddito «a fondo perduto»? Non certo più aleatorio come fattore di rilancio dell’economia di quanto non lo siano le belle parole del governo e le pretese a muso duro di Confindustria. E se l’Europa diffida di un paese come il nostro che a fronte di un enorme debito pubblico dispone di un’ancora più enorme ricchezza privata, forse il problema non riguarda solo gli arcigni burocrati di Bruxelles.
Questo articolo è stato pubblicato su Il manifesto l’11 luglio 2020