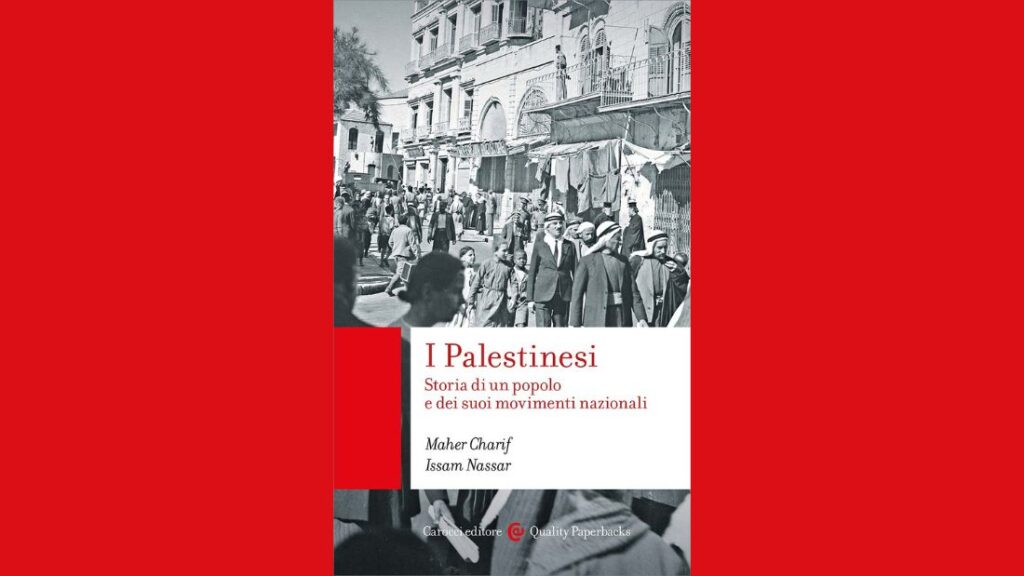di Sergio Sinigaglia
Periodicamente entrano nelle nostre case immagini del conflitto israelo-palestinese. Per alcuni secondi ci appaiono i volti di giovanissimi che fronteggiano l’esercito israeliano. Un esercito anche esso fatto di altrettanti giovani. Questa guerra interminabile iniziata ben prima della nascita dello Stato israeliano, quindi un secolo fa con i primi flussi migratori dall’Europa, potrebbe essere letta anche così: giovanissimi contro altri giovani.
La differenza è che quasi sempre a rimanere morti sul terreno sono i primi, visto che da una parte ci sono sassi, dall’altra mitra, fucili e carri armati. Dunque per pochi secondi vediamo quei volti adolescenziali, fieri quanto ribelli e rabbiosi, ma nulla sappiamo delle loro storie, della loro sofferenze, delle umiliazioni e dei soprusi che tutti i giorni devono subire. Chi scrive ha avuto l’opportunità di conoscere alcune delle loro storie, storie tremende, che qui non arrivano, perché relegate nel dimenticatoio, o meglio censurate perché non si devono sapere.

Dal 22 al 30 marzo si è recata in Palestina una delegazione di dieci persone, per iniziativa della bella associazione “Madri per Roma città aperta”. L’ha fatta nascere Stefania Zuccari, dopo l’assassinio del figlio Renato Biagetti, un compagno del centro sociale Acrobax, accoltellato a morte l’estate del 2006 in un agguato fuori dal centro da parte di un commando fascista. A lei si è affiancata Rosa Piro, mamma di Dax, altro compagno dei centri sociali, ucciso a Milano nel marzo del 2003. A seguire Haidi Giuliani, e altre donne coraggiose, soprattutto di Roma, i cui figli militavano e militano soprattutto in Acrobax. Chi ha vissuto la tragedia di vedere ucciso il proprio figlio ventenne, non si è chiusa nel proprio lutto silenzioso, ma ha trovato una energia eccezionale per tramutare l’immenso dolore, in impegno civico e sociale.
Da anni girano il mondo per incontrare analoghe associazioni, dall’Argentina alla Spagna, alla Francia. La scelta del viaggio è stata dettata anche dall’aver deciso di devolvere l’incasso del libro dedicato a Renato da parte di Zerocalcare, ad un progetto di scuola di danza per bambini palestinesi a Ramallah. Alla loro delegazione si sono aggiunti due compagni di Roma della mia generazione e il sottoscritto. Gerusalemme, Betlemme e Ramallah le nostre tappe, accompagnati dai compagni e delle compagne del Fronte Popolare per la liberazione della Palestina, storica organizzazione di sinistra della Resistenza palestinese.
In particolare ci ha fatto da fondamentale e fraterna guida Lalib (il nome come gli altri che faremo è di fantasia, per evitare eventuali “noie”, anche se ci è stato detto “no problem”…), un compagno trentacinquenne che dalla nascita vive nel campo profughi “Aida Camp” di Betlemme una comunità di seimila persone. Parlavamo di storie dolorose, ma sarebbe meglio parlare di storie agghiaccianti. A Gerusalemme ci sono state aperte le porte di due famiglie del quartiere palestinese di Shufat, alla periferia della città.
I famigliari di Abdil, la cui grande foto sorridente giganteggia nella sala dell’appartamento, ci hanno raccontato come è stato ucciso. Durante il Ramadan del 2014, è stato rapito da una squadraccia di coloni, tre in tutto, il più giovane aveva diciotto anni, il più vecchio ventotto. Con l’auto lo hanno portato in un bosco confinante con il quartiere. Gli hanno messo in bocca un tubo di gomma, inalato del gas e dato fuoco. È morto bruciato vivo.
Una volta tanto, di fronte a tanta efferatezza, i tre sono stati arrestati. I difensori hanno cercato una scappatoia facendo riferimento ad una ridicola “infermità mentale”, ma la stessa moglie del ventottenne li ha smentiti. Sono stati condannati a pene varianti tra i venti e i venticinque anni. Il secondo incontro ci ha fatto conoscere le famiglie di due cugini, Nassan e Demah, rispettivamente quindici e tredici anni. Nel 2015 il primo viene investito volutamente da una macchina piena di coloni. Una volta a terra infieriscono su di lui.
Allora il cuginetto nel vedere la scena, va verso un posto di blocco di soldati. La dinamica è stata ripresa da una telecamera posta sulla strada. Il padre ce l’ha registrata nel cellulare. Si vede il ragazzino camminare verso il gruppo di militari. Ad un certo punto parte una raffica e viene freddato. Una vera e propria esecuzione sommaria. Assurda, senza un motivo, se non quello di terrorizzare, annientare. Un episodio analogo ci verrà raccontato a Betlemme. In questo caso la vittima aveva quindici anni ed era appena uscito da scuola. Un soldato dalla torretta posta nel grande muro che dal 2003 ha iniziato a ghettizzare ulteriormente la popolazione, lo ha freddato.
E a proposito di muro, la maggior parte dell’opinione pubblica mondiale crede che esista solo quello di Betlemme, alto come una palazzina di due/tre pani. Ma ormai muri sorgono un po’ ovunque, circondano Gerusalemme, li trovi nella zona di Ramallah. Ufficialmente sono stati eretti per mettere fine agli attentati stragisti nei confronti della popolazione civile israeliana. E in effetti gradualmente sono cessati. In realtà è evidente come siano strumenti fondamentali nel processo di totale ghettizzazione in atto, a vantaggio degli insediamenti dei coloni che oramai sono diffusi in ogni parte del territorio. Una pulizia etnica strisciante. Centinaia, migliaia di case stanno accerchiando i palestinesi. In questo quadro chi può cerca di emigrare, la maggior parte non può permetterselo e cerca di convivere con l’occupazione, impresa ardua se non impossibile.
Ramallah è una città di quattrocentomila abitanti, è chiamata la “Milano palestinese”. Traffico frenetico, grandi palazzoni. Qui abbiamo incontrato l’associazione delle donne legate al Fronte, che sin dalla prima Intifada 1980, si batte per la parità dei diritti tra uomo e donna, in una società profondamente maschilista e soprattutto da decenni rifluita nel tradizionalismo religioso. Sono veramente poche le donne che vedi girare con abbigliamento normale. La maggior parte ha la testa coperta dal velo e il vestito lungo. Ogni tanto incontri qualcuna che ha coperto anche il viso. Anche tra le stesso compagne del Fronte alcune hanno il fazzoletto in testa. La responsabile dell’associazione ci dice che negli anni Settanta la situazione era ben altra. Poi qui come in altre parti del mondo la dimensione religiosa ha egemonizzato la società.
Nei giorni in cui siamo stati in Palestina, il solito razzo lanciato da Hamas verso Tel Aviv, velleitario quanto fortunatamente inefficace, ha scatenato la rappresaglia israeliana che si è espressa con due giorni di bombardamenti su Gaza. Nella periferia di Ramallah, verso il tardo pomeriggio di mercoledì, abbiamo incrociato gruppi di giovani che fronteggiavano soldati israeliani. Il giorno dopo a Betlemme in un campo profughi c’è stata una irruzione dell’esercito per individuare un giovane paramedico palestinese ricercato da tempo. Lo hanno trovato e ferito mortalmente. Labil ci mostra dal telefonino la foto del ragazzo che sulla barella fa il segno di vittoria. Morirà dopo pochi minuti.
Queste alcune delle storie che abbiamo ascoltato, delle cose viste durante la settimana di permanenza. Ci sarebbe da scrivere molto altro. Per esempio raccontare come durante il Sabbath a Gerusalemme tutto si ferma. Locali chiusi, metropolitana di superficie non funzionante per 24 ore. E la scena se la prendono loro, i barbuti ebrei ortodossi, con i loro caratteristici vestiti neri, sono adulti, ma sono spesso accompagnati dai figli giovanisismi. Non molto tempo fa tiravano sassi contro i loro concittadini che non rispettavano le regole del Sabbath, si permettevano di girare in auto e avere un comportamento non consono. Ora sembrano aver vinto loro. Nell’albergo in cui abbiamo dormito per due notti, il sabato non ci hanno rifatto il letto; il pomeriggio quando siamo rientrati e abbiamo provato a chiedere un caffè, ci è stato risposto che non era possibile a causa delle festività. Eppure chi lavora nella struttura non porta la kippah. Non sembra ostentare simboli religiosi. La sensazione è che hanno paura di rappresaglie.
La società israeliana appare sempre più militarizzata e fascistizzata. Le imminenti elezioni vedranno, dicono alcuni, la sconfitta dell’ormai impresentabile Netanyahu. Ma il probabile vincitore potrebbe essere un generale…insomma dalla padella alla brace. Un contesto politico dove a dettare legge sono i coloni, veri e propri protagonisti della vita del Paese. Eppure un anno fa a Tel Aviv di questi tempi c’è stata una manifestazione di centomila persone contro questa situazione. Qui non se n’è saputo nulla. “Non vogliono che queste notizie circolino…” mi dice Lalib che non pronuncia mai la parola “Israele”, ma significativamente “Terre del 48”. E a una mia specifica domanda risponde che come Fronte non hanno nessun contatto con i gruppi di opposizione, a dire il vero sempre più isolati, che sono contro l’occupazione.
E allora l’interrogativo grande come il mondo con cui siamo ripartiti è stato “Come se ne esce ?”. Lo abbiamo provato a chiedere ai sette fratelli di una famiglia di Betlemme che entrano ed escono dalla prigioni israeliane. Uno ha risposto sibillino: “dal cimitero…”.
La mia impressione è che due sono le possibili soluzioni. Una imposizione internazionale che “costringa” ad un accordo di pace i due schieramenti, ma come ha sottolineato Lalib, Usa e Europa sono schierate, al di là di alcune frasi di circostanza, con Israele. Inoltre l’unica soluzione non può più essere “due stati nazionali”, ma semmai un progetto che porti al superamento di Israele per un territori liberato dalla barriere etniche, religiose e culturali, sul modello federativo democratico che ha oggi come imprescindibile riferimento il Rojava.
E allora ci piace pensare che tra i tanti ragazzini che con coraggio ogni giorno sfidano la violenza dell’occupazione, possa esserci un futuro Mandela che si elevi su tutto e su tutti, avviando un processo di liberazione che contagi anche la società israeliana. Un’utopia? Forse…
La Palestina nel cuore, la Speranza nel cuore.
Questo articolo è stato pubblicato dallo Spazio Autogestito Arvultura