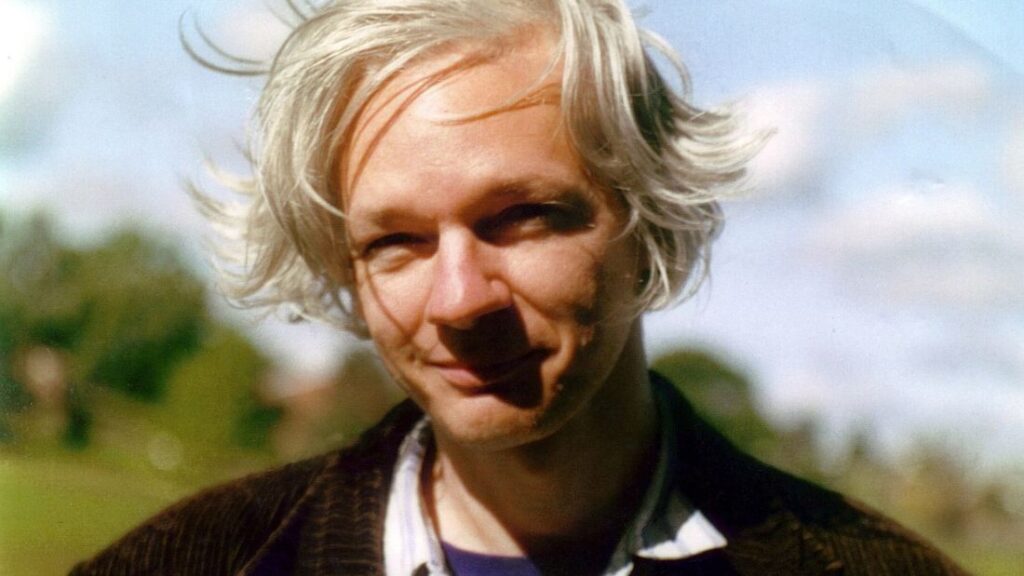di Elettra Santori
Sulle facciate del Palazzo di via Curtatone, a Roma, è ricomparso l’anonimato di una volta, dopo i giorni tumultuosi dello sgombero dei migranti. Si presentava così, dismesso e apparentemente disabitato, anche quando lo frequentavo io, il Palazzo della Federconsorzi, sul finire del 2014. Lavorando nel campo dell’intercultura, avevo saputo da due colleghe, vicine ad ambienti parrocchiali, dell’occupazione di quel grosso edificio anni Cinquanta da parte di rifugiati eritrei scampati al grande naufragio di Lampedusa nell’ottobre 2013; ma, come seppi poi, vi si erano insediati anche eritrei da lungo tempo qui in Italia, e altri migranti, etiopi e somali per lo più.
All’epoca erano circa 400 persone in tutto, non ancora le 500 (secondo alcuni 800) di cui si è parlato in questi giorni. Le Istituzioni pagavano agli occupanti l’acqua e l’elettricità, e questo dava una parvenza di legalità alla loro incongrua presenza in un edificio razionalista vincolato dalla Sovrintendenza dei Beni culturali. Z., una mia collega, anche lei rifugiata eritrea, giunta in Italia ai tempi della guerra di indipendenza dall’Etiopia, aveva contatti con alcuni dei rifugiati di via Curtatone tramite la sua parrocchia, e aveva organizzato, assieme ad un’altra collega, una raccolta volontaria per i suoi connazionali, coinvolgendomi nel reperimento e nella distribuzione degli aiuti.
Ci davamo appuntamento il sabato pomeriggio e partivamo con la macchina carica di roba proveniente dai centri parrocchiali di raccolta dell’usato o smaltita dalle nostre case. Via Curtatone ci accoglieva silenziosa e intorpidita dal relax del fine settimana. Dall’esterno del palazzo, nulla lasciava trapelare la presenza di 400 migranti, come ci fosse in loro l’intento di non dare nell’occhio, di scivolare in sordina nella vita di un quartiere di uffici e sedi prestigiose.
Il portone era sempre chiuso, per entrare avevamo bisogno di un contatto interno da avvisare una volta arrivate sul posto; e quel contatto per noi era S., un’eritrea sui vent’anni, gentile e determinata, la figura snella modellata dai jeans skinny e da t-shirt che una qualsiasi adolescente italiana non avrebbe sdegnato di indossare. Lavorava a servizio in una casa romana e parlava un italiano non stentato. Il portamento ritto e svelto, nulla a che vedere con la curva supplice delle spalle ossute che caratterizzava gli altri eritrei di sbarco recente, lasciava intravedere la sua consapevolezza di uno scarto di destini tra lei e i suoi connazionali, verso cui pure si prodigava. Scendeva ad aprirci il portone assieme a qualche altro migrante, e ci aiutava a scaricare la macchina, che traboccava di buste di cibo, vestiti, scatole di piatti e bicchieri spaiati, posateria rimediata, casalinghi, mobiletti, giocattoli.
La distribuzione degli aiuti avveniva nell’atrio del palazzo, vicino a una vecchia guardiola malmessa, e non si svolgeva secondo regole precise: i migranti che si trovavano per caso a passare di là si avvicinavano, osservavano, sceglievano, sgomitavano per i pezzi più appetibili; poi allertavano col telefonino gli amici ai piani superiori, in qualche modo fortuito la voce del nostro arrivo si spargeva nel palazzo e un nugolo di migranti arrivava a spartirsi il carico. Qualcuno si avvicinava per farci richieste al di là della dignitosa sopravvivenza: vestiti nuovi e alla moda, televisori a schermo piatto … Z. li rimbeccava prontamente nel suo mai appannato tigrino, Mica è la slitta di Babbo Natale, questa.
Le rimanenze le riponevamo nell’atrio, ammassate nella guardiola deserta, in attesa che qualche interessato le notasse e se le portasse nel suo alloggio. Poi salivamo ai piani superiori per consegnare la roba che i migranti avevano richiesto personalmente a Z. e che eravamo riuscite a reperire nelle nostre case o nei centri di raccolta: materassi, tavolini, stand appendiabiti, scarpe, pacchi di vestiti per bambini divisi per fasce d’età … L’ascensore del palazzo non era funzionante, dovevamo salire a piedi e caricarci i pesi a spalla.
Nelle consegne ai piani ci accompagnava S., a volte qualche volenteroso che casualmente incrociavamo per le scale si offriva di aiutarci, ma in genere chi aveva già ottenuto la sua parte di “provvidenza”, o non ne era il destinatario, non aveva interesse a sobbarcarsi il fardello della roba destinata ad altri. Non c’era tra i migranti una solidarietà traversale, il sentimento spontaneo di appartenenza a un qualche noi – “noi sopravvissuti al Mediterraneo”, “noi esuli”, “noi disperati”. Proprio come accade tra gli ospiti casuali di un albergo o gli inquilini di un condominio in una qualsiasi grande città.
Ad ogni rampa di scale si apriva un ballatoio su cui sfociavano lunghi corridoi, e su questi sfilavano, una affianco all’altra come in un hotel, le stanze dei migranti che un tempo erano state uffici. In ogni stanza, una famiglia, o un singolo migrante. E un bagno per ogni piano. Dietro ogni porta, una storia di miseria, dignitosa o estrema, ma anche di piccolo riscatto. La stanza di S. sembrava una camera d’albergo, umile ma vivace e ordinatissima: un letto che di giorno serviva da divano, decorato con cuscini variopinti, una pianta grassa su uno scaffale, un tavolo da pranzo coperto da una tovaglia etnica e, alle pareti, la croce copta e le stampe a colori della Madonna col bambino, sgargianti di rosso e turchese.
Ma in altre stanze la situazione era ben diversa: famiglie con tre o più figli costrette in un locale angusto, l’aria pesante di chiuso e di cucina, la scorta d’acqua raccolta nei secchi, i pavimenti sporchi di immondizia e rifiuti. Tra la rada mobilia e i materassi addossati alle pareti per ricavare spazio, bambini di pochi mesi giocavano e mangiavano seduti per terra, raccattando dal pavimento quello che gli cadeva di bocca. Il focolare domestico era un fornello portatile appoggiato direttamente sul pavimento, alimentato con le bombole a gas, sulla cui manutenzione ed efficienza non avrei potuto giurare.
I bagni comuni sembravano in condizioni accettabili (ma per quanto ancora? mi chiedevo), mentre sui corridoi cominciavano ad addensarsi sporco e polvere. Nell’insieme non sembrava un inferno, ma piuttosto una terra di nessuno in cui sarebbe potuto accadere di tutto – viavai di clandestini e scafisti, racket degli affitti -, come difatti, in seguito, molto probabilmente è accaduto. Mancavano sorveglianza, regole, assistenza costante, servizi sociali organizzati, la presenza evidente e tangibile delle istituzioni. In questo mondo fluido e sdrucciolevole, io e le mie compagne ci aggiravamo come falene sbandate in una colonia post-apocalittica.
Le mie visite a via Curtatone si interruppero all’inizio del 2015, quando la buona volontà naufragò in una sensazione di inefficacia e povertà di mezzi.
Avevo comprato una scopa, una paletta e un set per lavare i pavimenti, da portare a via Curtatone, ed ero indecisa se regalarli direttamente a qualcuno dei più bisognosi o farne un bene comune per la pulizia dei corridoi – ma, in quest’ultimo caso, a quale dei quattro piani assegnarlo? E a chi lasciarlo in custodia, in mancanza di un portiere all’ingresso o quantomeno di una persona di riferimento per la pulizia degli spazi comuni? Non sapevo a quale opzione dare la priorità.
Fu la confusione al momento della distribuzione del carico a decidere per me: il set nuovo di zecca sparì nelle mani di qualcuno più svelto degli altri, ed io rimasi con la sensazione di aver fatto un torto a tutti quelli che la mia modesta generosità non era riuscita a raggiungere, più che un regalo al lesto che se ne era appropriato. Avevo avuto lo slancio del cuore, ma non la prontezza della pianificazione. Lo stesso difetto di una certa accoglienza all’italiana, che lascia entrare masse di derelitti con la leggerezza del cuore, senza tracciare binari oltre la prima stazione dell’ospitalità, e poi lascia fare il resto alla vita (o alla Provvidenza) e alla sua arte combinatoria, sperando che nel lungo periodo il caos prenda forma e si sistemi da sé.
Ma le persone non sono merci che possono essere movimentate da Lampedusa a via Curtatone, e da via Curtatone al magazzino successivo: sono progetti di vita, viaggiano su binari lunghi. Chiediamoci quanti di questi progetti possiamo prenderci in carico dal loro sbarco in poi, e commisuriamo alle nostre realistiche possibilità l’ampiezza della nostra accoglienza. Meglio molto a pochi che briciole di elemosina a tutti.
Ps: ho saputo che adesso S. si è “sistemata”: ha sposato un commerciante eritreo che viveva da tempo qui in Italia, e ha avuto una bambina.
Di tutti gli altri occupanti di via Curtatone che ho conosciuto, non so.
Questo articolo è stato pubblicato da Micromega online l’11 settembre 2017