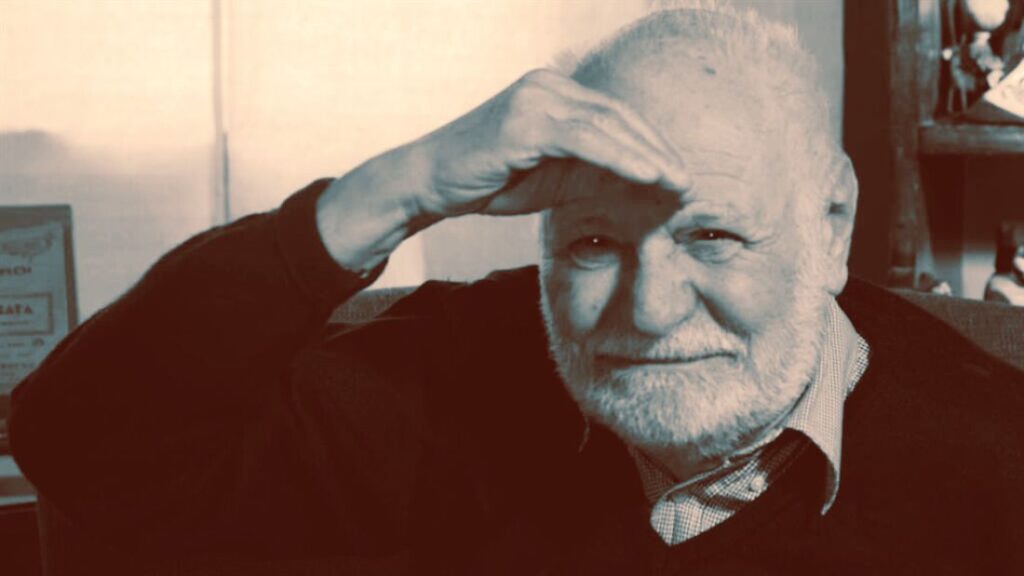di Luca Mozzachiodi
Una delle più radicate e diffuse idee sulla poesia, o se non altro una di quelle che più affliggono chi non condivida posizioni da cultore della bellezza ma almeno si interroghi sui rapporti tra arte e società è quella della cosiddetta poesia civile che vediamo sempre più istituzionalizzarsi in monografie, festival, premi, studi accademici ma che nasconde notevoli rischi di impoverimento tanto per la poesia quanto per una riflessione autentica sulla società. Più volte mi sono trovato ad esprimere la mia opposizione a questo modo di pensare il lavoro dei poeti, ma visto che inevitabilmente, come tutti i discorsi fintamente progressisti, pare ammorbare l’aria qualsiasi cosa si faccia e posizione si prenda ritengo non privo di utilità, non solo per difesa del mio lavoro ma anche come possibile orizzonte per quello di altri involti negli stessi problemi, riportare una parte consistente di un mio scritto ad un critico che, con sincera partecipazione, si proponeva di recensire un mio libro. Non me ne voglia l’amico se traggo spunto da una comunicazione personale per offrire in sintesi una critica della poesia civile che a quanto pare continua a dimostrarsi una presa di distanza essenziale.
L’idea che esista una poesia civile e che meriti e debba essere analizzata secondo principi propri ha un’ideologia sottesa ed espressa in maniera inconsapevole: presuppone l’esistenza di una civitas da intendere come comunità organica per cultura e consenso democratico intorno a valori da difendere appunto “civicamente” come ad esempio la memoria di taluni eventi storici e la generica asserzione di petizioni su diritti umani, diritti civili e buongoverno (potrà apparire sciocco o demodé farlo notare ma questo include naturalmente una lode della concezione liberale della democrazia, come valore intrinseco e non relativo).
Dal punto di vista più culturale e letterario questa concezione è risolutamente (e barbaramente) contenutista: la “civicità” di una poesia sarebbe una faccenda della materia poetica, di ciò di cui la poesia parla. Una poesia, ad esempio, che parla della strage di Bologna sarebbe poesia civile, possiederebbe un suo potenziale di denuncia e dunque il poeta civile avrebbe in qualche modo un mandato o una posizione di coscienza per esercitare la sua denuncia, il suo intervento di posizionamento in versi, che rientra nella funzione di acculturazione sociale diffusa di quella civitas di cui sopra (potremmo dire che si tratta di una sorta di Repubblica Platonica con i poeti riammessi) e la funzione del poeta vedrebbe essenzialmente la persuasione e l’esortazione come fine e la letteratura come mezzo, o come valore in sé ma passibile di un utilizzo mediale.
Ora cercando di articolare e criticare questa impostazione devo anzitutto notare che questa civitas è una rappresentazione puramente ideologica e illusoria, non esiste e decenni di elogio della solidarietà, dell’eguaglianza di fatto sotto il grande ombrello del democraticismo nazionale (occidentale? Europeo? Progredito? Liberale?) non sono bastati a costruirla perché nei fatti, nella struttura, le diseguaglianze permangono e anzi si radicalizzano. L’unità, anche la nostra se vogliamo, anche solo la piccola unità di persone che leggono o scrivono poesia, non esiste perché nella società siamo individuati (per classi?) e opposti anche se per incapacità, o per mancanza di volontà o per immaturità della situazione, non esplicitiamo coscientemente l’opposizione in conflitto.
La prima spontanea domanda dunque è a quale gruppo si rivolgerebbe la poesia civile? Troppo spesso pare avere per destinatario questa comunità di valori inesistente e rivelarsi dunque molto meno civile di una lirica intimista d’amore. Oltretutto valori, virtù e posizioni cui si riferisce sono spesso ben relativi ed essa sarebbe ben più settaria di una poesia dichiaratamente di parte, e qui abbiamo già delineata l’ombra di quel pensiero reazionario sulla poesia civile di cui ho parlato nel congedo del libro. Insomma l’idea diffusa intorno alla visione della società che l’etichetta di poesia civile sottintende si fonda su presupposti falsi, parziali e assolutamente conservatori.
Il poeta che si pensa civile in Italia oggi è più un poeta avvocato che un combattente, dà, come troppo spesso si dice, voce agli oppressi, dimenticandosi che si tratta di una falsificazione perché gli oppressi non parlerebbero con quella voce, ma infine, e veniamo alla seconda domanda, se il poeta civile è l’avvocato chi è il giudice? Forse almeno in parte proprio chi contemporaneamente garantisce il permanere di quelle situazioni di oppressione e i denari per centri studi, università, festival, riviste, laboratori in cui si fa o si parla di poesia civile, chi controlla il processo per cui possiamo agevolmente comprare un libro di cosiddetta poesia civile sulle condizioni della Palestina ma assai meno agevolmente possiamo organizzarci per fare sì che tali condizioni cessino.
Spesso ho l’impressione poi che in una certa idea diffusa di poesia civile sia tacitamente presente il pensiero di un cattolicesimo ambiguo e strisciante che vede nei poveri e negli oppressi (ovviamente rigorosamente senza distinzioni ma come categorie generali) l’oggetto della carità; così implicitamente guerre, sfruttamento, disuguaglianze, ci lasciano il piacere di una grande poesia, la gioia di essere buoni e d’accordo, persino la meraviglia di essere poeti, (ci sono voluti 68 milioni di morti perché potessimo gioire di una poesia di Brecht).
Ancora più spesso poi mi sembra che oggi l’etichetta di poesia civile serva a dare una verniciata nobilitante al buon senso e a far passare in secondo piano la qualità del pensiero e della riuscita letteraria attraverso il ricatto dei buoni sentimenti: sta davvero male, nella società letteraria, dire che una poesia per i palestinesi è davvero brutta e che non serve (e questo era ovvio e giusto) ai palestinesi e meno ancora (e questo era molto meno ovvio ed è invece una colpa) alla poesia.
Siamo entrati dunque nel secondo campo della questione: per quel che riguarda il contenutismo io, che detesto il formalismo e ancora di più tutte le forme di critica non dialettica che ragionano in base alla distinzione tra forma e contenuto, o se si preferisce tra materia e struttura, ho diverse riserve. La prima mi è data dalla consapevolezza dell’ambiguità della poesia e del suo fondarsi sulla contraddizione irrisolta. Una poesia (si parla della vera poesia, non dei pensierini ritmati in versi) è sempre ricca e ambigua anche quando vuole essere chiara.
Se si hanno dei problemi, diciamo così, di contenuto, se si avverte l’esigenza di dire qualcosa civicamente, come forma di azione sociale è assai meglio agire appunto, o esplicitare la questione in prosa e una poesia che sostituisce ciò che può essere detto in prosa non può che essere una pessima poesia; il problema fondamentale è però che proprio in virtù di tale ricchezza non si può dire che una poesia parli di qualche cosa, una poesia sulla strage di Bologna non è, o al limite non è solo, una poesia sulla strage di Bologna. Pensare che una poesia parli delle sue parole scritte è una forma di incomprensione, una lettura superficiale e riduttiva. Va da sé che non può essere un ragionamento sul contenuto a determinare la natura di una poesia.
La seconda riserva, che è per la verità più un dubbio, è legata al pensiero, che ha tutta una sua tradizione e fu anche di Adorno, per cui l’elemento di eversione nell’opera d’arte, la sua alterità in opposizione allo stato di cose presente sarebbe dato da fattori formali e strutturali più che di contenuto per cui nel mio caso mi sono chiesto, e mi chiedo se la mia poesia non debba la sua forza di contestazione non a quello che dice ma a come ha scelto di dirlo, non cioè dal raccontare di campi di sterminio, disoccupazione, morti in mare, repressioni poliziesche, idee reazionarie e rivoluzionarie, ma nell’organizzarsi in lunghi poemi e nelle calcolate architetture dei libri, così opposte all’accelerazione dei tempi della produzione culturale, dell’acculturazione di massa e della lettura individuale e all’impressionismo da poesia ready made che vive nell’eterno presente dell’esperienza: come ho scritto il poema è l’esperienza che costruisce il soggetto opposta a quella che lo fraziona.
Ripeto, si tratta solo di un dubbio riguardo una possibilità, ma si tratta di una possibilità troppo ricca di implicazioni per poterla scartare pregiudizialmente senza averci davvero pensato (i civilisti della poesia potrebbero su questa strada scoprire che Rentocchini è molto più civile di D’Elia per esempio).
L’ultima riserva che è la maggiore e ricomprende le altre e in qualche modo tutto il discorso fin qui svolto è la certezza che lo statuto sociale di un’opera non viene dato solo dall’opera stessa, dalle parole scritte, ma da tutto il suo processo di elaborazione, produzione, diffusione, ricezione e appropriazione sociale, l’intero suo arco di vita in quanto prodotto (merce), quindi non basta un certo argomento a definire il rapporto tra poesia e società e qualificarla come civile e opposta a determinate condizioni.
Questo è il paese di poesie insurrezionali e poemetti sulla decadenza repubblicana pubblicato da Mondadori e da Einaudi (dal gruppo Fininvest). Con questo non voglio invocare un’impossibile e sciocca idea di separatezza, piuttosto semmai ricordare che oggi massimamente, ma era già così da decenni, non esiste un fuori dal mercato, un esterno al capitale e allo sfruttamento in cui porsi per denunciare in nome di civici valori, una posizione neutra della coscienza del poeta e bisogna saperlo, sopportare la contraddizione non cancellarla con un colpo di virtù.
I poeti non hanno più, ammesso che lo abbiano mai avuto, un mandato relativo all’espressione di posizioni politiche sulla società perché si sono sfaldate quelle forme di aggregazione sociale e di reciproco riconoscimento che facevano sì che complessivamente e collettivamente, gruppi, posizioni, idee, comunità, partiti, classi e financo interi popoli (ma in particolarissime condizioni) potessero sentirsi rappresentati nei versi e nelle idee di un autore, oggi un poeta rappresenta perlopiù solo se stesso e certamente non si recupera, ed è giusto che sia così, quando si parla per qualcuno significa spesso che c’è qualcuno che non può parlare.
Lo statuto precedente non si recupera, meno che mai, anche nelle forme o nei casi in cui questo potrebbe essere invece utile, facendo a chi grida più forte in qualche lettura o spettacolo come dovrebbe andare il mondo invece di come in effetti va.
Perché il fatto è che come va non lo sappiamo. Mi si potrà rispondere che è dovere del poeta dire la verità, denunciare, certo. Il problema è che per poter dire la verità bisogna saperla e per saperla occorre ricercarla e per ricercarla occorrono strumenti e domande giuste, tutte cose che noi non abbiamo, ci manca oggi una vera completa analisi critica della società, abbiamo solo analisi e visioni parziali; alla luce di tutto questo pare invece che per qualche ragione spiegabile solo con un culto sbagliato ma profondamente radicato intorno alla figura del poeta si dia per scontato di sapere la verità che si deve dire nel momento in cui si recita una poesia “civile”, ma spesso non la si è cercata, sembra stare lì bella e pronta per essere scritta con uno sforzo di buona volontà del poeta, il quale spesso per inciso diviene per trasmutazione magica senza studio e militanza pratica di nessun tipo un pubblicista politico e un analista della società.
Mal ne avranno i sociologi, gli storici, gli studiosi di politica, i militanti, che evidentemente oltre al non possedere una conoscenza vera e completa della nostra società non sono nemmeno capaci di scrivere una poesia! Soffriamo un po’ tutti di questo autoinganno, ma sarà bene allora vaccinarsi, porsi e porre dei limiti, riconoscere la propria parzialità e se occorre rivendicarla. Far pubblicare una recensione a un proprio libro sotto la pretenziosa e impolitica definizione di diagnosi poetica e presa di posizione poetica sulla Civitas mi sembra ben oltre questi limiti se anche si potesse fare.
Perché non lo posso fare? Perché le mie esperienze di scrittore, di studioso e soprattutto di lettore, mi fanno conoscere bene lo statuto di merce del libro di poesia, troppo per non sapere che l’etichetta di poesia civile, sociale, politica, è un’etichetta commerciale, serve a vendere un prodotto. Ho già spiegato in dettaglio l’inconsistenza teorica di questa categoria e anche dal punto di vista critico letterario è un’idiozia palese, una sorta di immaginario sottogenere come il dramma di cappa e spada o il romanzo di esplorazioni, ma la visione della società, della politica e della storia non sono fattori esteriori come la divisione in atti, l’ambientazione, il tipo di personaggi, che si possano cambiare semplicemente per convenzione di genere e la riduzione della realtà a tematica civile per poesie di genere convenzionale è precisamente quel pensiero reazionario a cui facevo riferimento.
Si tratta di definizioni di comodo e sbrigative che critici e studiosi molto ciarlieri e mondani amano sostituire in una continua affabulazione ad un serio e faticoso confronto con il testo, per incasellarlo immediatamente in una posizione già nota; dovrebbero sapere che tra la loro operazione e quella di chi incolla le etichette ai vasetti di marmellata non c’è grande differenza: pesche, fragole, more ognuno nella sua cassetta pronto per essere spedito, così il consumatore acquista quella che più gli piace senza sorprese e senza sorprese è il libro di poesia civile dove il buon lettore sa già che tipo di poesia troverà, pronta per essere letta, ma già masticata e digerita perché qualcosa non vada di traverso. Su questa complicità e coimplicazione tra critica e mercato, spesso assai poco lungimirante da parte degli studiosi e accettata senza un minimo di consapevolezza e di resistenza molto è stato detto e si dovrebbe dire ancora.
Anche per questo i laboratori e i festival di poesia civile fanno paura oltreché essere aberranti e ridicoli. Sono istituzionalizzazione e valutazione (con annesso premio o prezzo) della coscienza.
Ora è evidente che io non possa contrastare tutto il mercato, ma posso scegliere un piccolo editore militante invece che uno generalista o un grande gruppo aziendale, così come non si può sconvolgere alla radice l’industria culturale e l’editoria, ma posso e devo resistere alle etichette e alle operazioni digestive, in special modo a quelle che fanno della civiltà e della politica conflittuale un genere letterario. Dobbiamo ricordarci, perché fa ancora parte delle nostre risorse di scrittori, che il mezzo non è innocente e per questo non posso accettare con leggerezza pur di una recensione e purché se ne parli che il mio libro compaia in un numero speciale su quella che voi chiamate poesia civile per tutte le ragioni che spero di aver chiarito; parlare da una prospettiva sbagliata di un libro può essere peggio che tacerne.