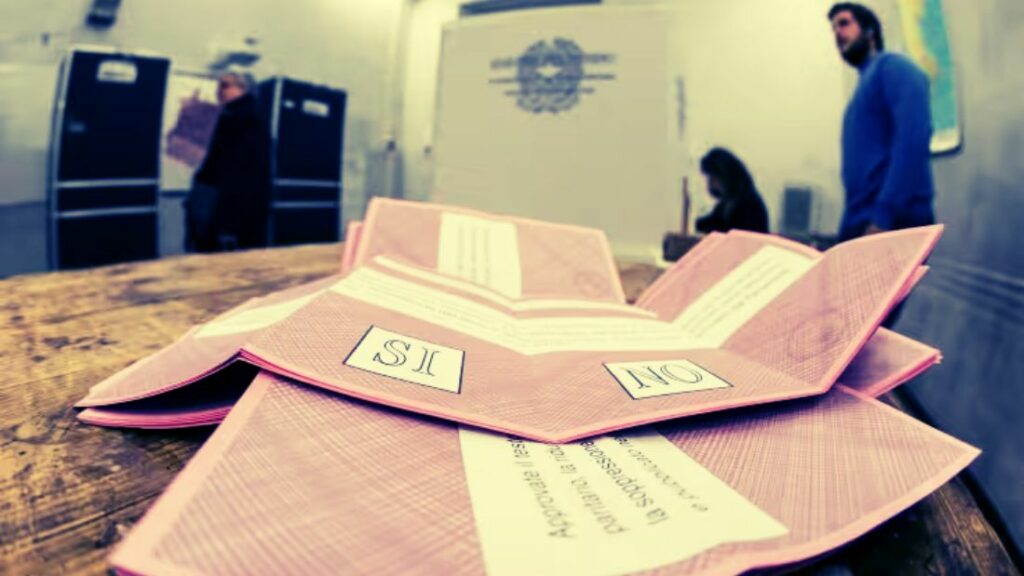di Alfonso Gianni
Per cercare di apporre una foglia di fico su quello che stavano facendo, i sostenitori dell’inserimento nella nostra Carta del principio del pareggio di bilancio lo hanno chiamato “equilibrio tra le entrate e le spese”. Ma la sostanza rimane quella. Per la prima volta nella nostra Costituzione è stato posto un vincolo cogente sulla spesa pubblica, tale da mutilare una delle funzioni essenziali di uno Stato – la manovra di bilancio – e contraddire un filone fondamentale del pensiero economico del Novecento, quello che sostiene la necessità di aiutare lo sviluppo economico attraverso congrui e intelligenti investimenti pubblici e di farlo proprio nei periodi di crisi, anche in deficit.
In sostanza con quell’atto il parlamento italiano si è assunto la storica responsabilità negativa di espungere la teoria keynesiana dalla nostra Costituzione. A farlo è stata una maggioranza composita ed ibrida, guidata da Mario Monti. Dove non era giunto il neoliberismo nelle sue formulazioni classiche susseguenti al celebre manifesto di Mont Pelerin del 1947 e nelle sue espressioni politiche più coerenti è arrivato un governo, quale quello presieduto da Mario Monti, definito “tecnico”, che secondo alcuni avrebbe dovuto rappresentare una semplice transizione da Berlusconi verso una “democrazia normale”. Si è poi visto con chiarezza che non si trattava di questo e il segnale più rilevante fu proprio l’approvazione di quella sciagurata riforma costituzionale dell’articolo 81.
Sarebbe ingiusto accollare tutta la responsabilità della costituzionalizzazione del pareggio di bilancio alla maggioranza che sorreggeva il governo Monti, anche se il suo contributo fu decisivo e niente affatto obbligato da presunti vincoli europei. In realtà la questione di una possibile modificazione dell’articolo 81 della nostra Costituzione era già entrata da tempo, anche se con diversa intensità, nel dibattito politico e nelle sedi istituzionali.
All’interno di più vasti progetti di revisione costituzionale, sono comparse più volte proposte di modifica dell’articolo 81 della Costituzione, accomunate dall’intento di introdurre in Costituzione il vincolo del pareggio di bilancio, senza che però si addivenisse mai alla loro definitiva approvazione. Se ne parlò infatti nella Commissione bilaterale Bozzi del 1983, in quella De Mita-Iotti del 1992 e in quella diretta da D’Alema. Venendo ai giorni nostri è stato il governo Berlusconi a proporre un disegno di legge al riguardo, che poi con Monti è stato approvato. Del tutto indifferente a questo dibattito il debito italiano, derivante da tutt’altre ragioni, cresceva dal 60% del 1982 ad oltre l’attuale 135%.
Una volta approvata la manomissione restavano aperte solo tre strade per tornare al testo precedente della Costituzione. Il rovesciamento per via elettorale di quella maggioranza e il definirsi di un percorso contrario al precedente, sempre ai sensi dell’articolo 138 rimasto immodificato, per una contro modifica parlamentare del nuovo testo costituzionale attraverso le tradizionali quattro letture. Ma quella strada venne subito chiusa dall’esito delle elezioni politiche del 2013 e dalla formazione del governo Renzi.
La seconda strada è stata posta in essere da uno schieramento trasversale, ove cioè figurano politici, intellettuali e sindacalisti che svariano dalla destra della fu Alleanza nazionale a esponenti e “consigliori” del Partito democratico, fino alla stessa Cgil. Uno schieramento di partenza abbastanza sorprendente, ma non inusuale in prove referendarie. Secondo i proponenti non si tratterebbe tanto di cancellare il principio del pareggio di bilancio dalla nostra Costituzione, quanto di togliere quelle eccessive asperità che la legge italiana ha introdotto e che non sono richieste dalla stessa Unione europea. Nella nota giuridica di accompagnamento alla proposta referendaria si legge infatti che «l’obiettivo complessivo dei quesiti è dunque modificare in più punti la legge n. 243 del 2012 che ha dato attuazione al principio costituzionale di equilibrio del bilancio (si noti che non si usa il termine pareggio di bilancio accettando la foglia di fico dei suoi ideatori) ed esattamente abrogare quelle parti che prescrivono un’applicazione nazionale esasperata e pertanto ingiusta degli obblighi di bilancio assunti in sede europea».
Qui si tocca un punto essenziale dell’intera vicenda. In effetti non è affatto vero che l’Unione europea ha esplicitamente chiesto di introdurre in Costituzione la normativa sul pareggio di bilancio. D’altro canto la Francia di Hollande, pur allineandosi subito al principio, si è ben guardata di accoglierlo nel dettato costituzionale. Non c’è dubbio che in sede europea si siano prodotti una serie di documenti, che vanno nella direzione dell’introduzione del principio del pareggio di bilancio e di norme che garantiscano l’applicazione di politiche di austerità. Come il Patto euro plus – accordo però non giuridicamente vincolante adottato dai Capi di Stato e di governo nel marzo 2011 – che inviterebbe gli Stati dell’eurozona, e non solo, a recepire nelle Costituzioni o nella legislazione nazionale le regole del Patto di stabilità e di crescita.
Lo stesso Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nella Unione economica e monetaria, cosiddetto Fiscal compact, – concordato al di fuori della cornice giuridica dei Trattati – all’articolo 3 ha impegnato le Parti contraenti ad applicare e introdurre, entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato stesso, con norme vincolanti e a carattere permanente, preferibilmente di tipo costituzionale, alcune norme, in primo luogo quella che il bilancio dello Stato deve essere in pareggio o in attivo. Il giro di vite europeo è stato quindi molto stretto e doloroso, ma un vero e proprio obbligo generalizzato alla costituzionalizzazione del pareggio di bilancio è solo una invenzione che è servita per giustificare la scelta della maggioranza del parlamento italiano, evitando così di assumersene la piena responsabilità. Quindi se si volesse essere fedeli all’indicazione europea non basterebbe mitigare la nuova formulazione dell’articolo 81, ma toglierlo dalla Costituzione o rovesciarne completamente il significato.
Ma c’è altro pericolo che incombe sulla iniziativa referendaria. È infatti dubbio che la Corte Costituzionale dia il via libera ai quesiti proposti. La ragione non sta tanto nel fatto che una materia come questa invade il campo del secondo comma dell’articolo 75 della Costituzione che recita: «Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali». I proponenti del referendum hanno infatti evitato di proporre abrogazioni di parti di trattati internazionali, ma si sono concentrati sulla legge applicativa del nuovo articolo 81, che è una legge ordinaria. Appunto la legge 243/2012. Solo che questa è una “legge rinforzata”, secondo quando prevede esplicitamente il comma sesto del novellato articolo 81 della Costituzione, ovvero richiede per la sua approvazione la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale prevede che in un caso del genere non sia possibile l’apposizione di quesiti referendari abrogativi. Ce lo dice la sentenza 16/1978 della Corte, finora mai smentita, che descrive i casi di inammissibilità di richieste referendarie, considerando tra queste anche “gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare”, come è appunto il caso delle leggi rinforzate come la 243/2012. È quindi assai difficile, a meno di un cambiamento di direzione nel consolidato criterio di valutazione della Corte Costituzionale, che i quesiti referendari superino il vaglio di ammissibilità.
Resta un’ultima strada: quella di una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare. La possibilità che diventi legge è ovviamente incerta. Ma meno di un quesito referendario se fosse respinto dalla Corte. In assenza di un regolamento delle Camere o meglio ancora di una norma legislativa che imponga l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare entro un certo periodo, e comunque entro la legislatura durante le quali sono presentate, è evidente che le leggi di iniziativa popolare incontrano difficoltà ad arrivare in porto. Ma nessuno vieta di unire alla lotta contro il pareggio di bilancio quella per una modifica della normativa che regola la discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare.
Nel contempo la legge di iniziativa popolare ha un vantaggio indubbio sul referendum: è propositiva e non solo abrogativa. Il testo di proposta di legge attorno a cui ha lavorato un gruppo di giuristi, fra i quali Azzariti e Rodotà – e che verrà depositato in Cassazione il 16 settembre – è molto semplice. Si basa sul principio che i vincoli di bilancio non possono violare i diritti fondamentali delle persone.
Sì tratta di inserire così, in Costituzione, un principio fondamentale, del tutto coerente con la prima parte e tutto l’impianto del nostro dettato costituzionale: il primato dei diritti delle persone – fra i quali rientrano la soddisfazione gratuita di quei bisogni su cui si è venuto costruendo lo stato sociale nel Novecento – sulle compatibilità di bilancio e sui vincoli internazionali in materia. Come è noto analogo principio è inserito nelle più recenti e avanzate Costituzioni moderne, in particolare modo di paesi dell’America latina. Non si tratta ovviamente di copiare norme che traggono origine da storie politiche, sociali ed economiche diverse, ma di muoversi verso quella indispensabile universalizzazione dei diritti, quella costituzionalizzazione della persona, che è parte integrante della lotta contro l’arretramento e la devastazione di democrazia, di solidarietà, di socialità, di civiltà imposte dalle presunte leggi economiche del neoliberismo.
Aprire una campagna su una simile proposta di legge di iniziativa popolare ha anche altri importanti significati. Smonta in partenza la propaganda di chi vuole manipolare la Costituzione in senso regressivo, che attribuisce a chi vi resiste la qualifica di conservatori. A parte che è cosa saggia conservare ciò che è buono – e questo è valido anche nei processi apertamente rivoluzionari – in questo modo si risponde in positivo a quella campagna denigratrice, dimostrando che una manutenzione intelligente e accrescitiva in senso valoriale della nostra Costituzione è necessaria e può essere operata senza stravolgerne i principi fondamentali, ma, al contrario, implementandoli.
Infine una campagna di massa per la raccolta di firme attorno ad una simile proposta di legge ha il pregio di unire finalmente ciò che è rimasto diviso: i temi che riguardano l’economia e quelli che concernono gli assetti istituzionali e costituzionali, peraltro in una dimensione che è di tipo europeo, vista la connessione logica-politica della questione del pareggio di bilancio con la governance economica della Ue, le politiche di austerità e in particolare il fiscal compact. L’abolizione di quest’ultimo non è materia che può essere risolta in un solo Paese, ma è la fondamentale battaglia da fare per la modifica della politica economica europea. La campagna contro il pareggio di bilancio in Italia la può aiutare.
Wolfgang Munchau, direttore del Financial Times Deutschland, si è domandato in una recente intervista a un quotidiano italiano «come un economista del calibro di Mario Monti abbia potuto firmare un trattato (quello sul Fiscal Compact) che, se applicato alla lettera, porterà l’Italia al fallimento: ridurre al 60% il debito in venti anni significa andare incontro ad una recessione che sottrarrebbe il 30-40% del Pil nello stesso periodo. Un disastro, e la fine dell’euro». Touché.
Infine questa campagna si legherà, concettualmente e attualmente, a quella per il no il referendum “confermativo” delle modifiche costituzionali che sono tuttora in discussione nei due rami del Parlamento (dalla questione del Senato alla modifica dei poteri delle regioni).
L’aggravarsi della crisi sta convincendo anche i portatori di teorie mainstream del fallimento di tutte le teorie legate all’austerity. È vero: queste teorie hanno ancora il bastone del comando in mano, ma il loro consenso è in caduta. Alcuni parlamentari del Pd, come Fassina ed altri, hanno dichiarato che introdurranno nella discussione sulle riforme costituzionali che approdano alla Camera, la cancellazione del pareggio di bilancio. Avessero fatto mancare la maggioranza dei due terzi a suo tempo, oggi saremmo già in un’altra condizione. Ma meglio tardi che mai. Persino gli economisti del Fmi riconoscono che il valore del moltiplicatore di sviluppo economico derivante dall’incremento della spesa sociale è certamente e nettamente superiore a quello che può derivare da una riduzione delle tasse. Il disorientamento culturale delle elites è molto evidente su questo punto.
Si potrebbe dire, rinnovellando una famosa frase di Gramsci, che viviamo in un’epoca di crisi in cui il vecchio sta morendo, ma il nuovo stenta a nascere. Aiutiamo questo difficile parto.
Questo articolo è stato pubblicato da Micromega online il 15 settembre 2014. Il testo integrale comparirà nel numero 33 della Rivista Alternative per il Socialismo, nelle librerie a ottobre