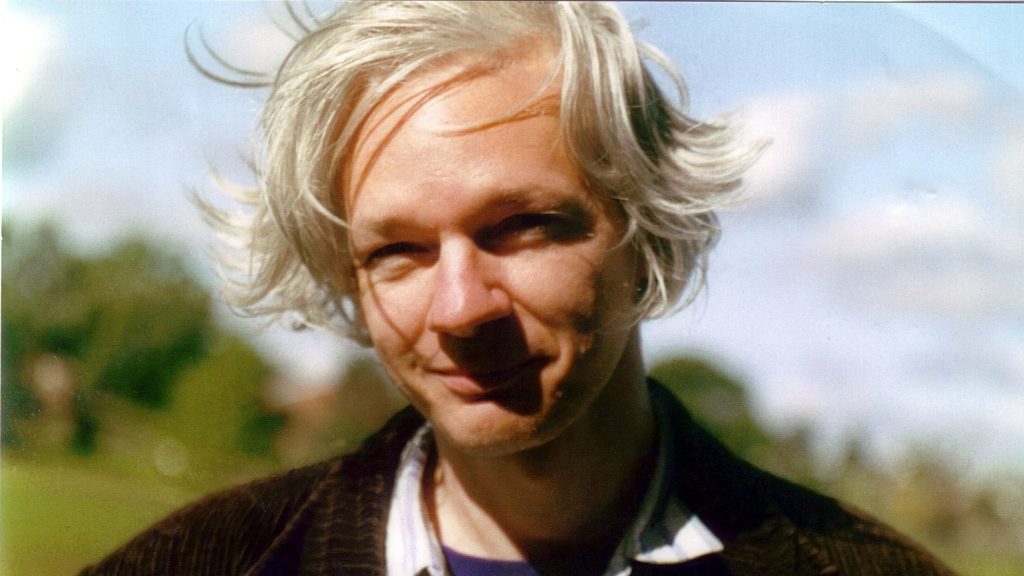di Maurizio Matteuzzi
La vera partita comincia adesso. E si annuncia molto difficile per il Venezuela bolivariano e tendenzialmente socialista, sia pure del particolare “socialismo del XXI secolo”. Ma assai inquietante anche per l’America latina progressista o di sinistra (a cominciare da Cuba), e per l’America latina in generale nel caso il “Venezuela saudita” e motore generoso dell’integrazione latino-americana entri in uno stato di fibrillazione destabilizzante. Del resto era immaginabile che la drammatica scomparsa di Hugo Chavez, il carismatico e solitario leader della rivoluzione democratica Hugo Chavez, vinto dal cancro il 5 marzo scorso, non potesse passare senza conseguenze e che il passaggio al dopo-Chavez fosse indolore e lineare.
Il candidato chavista Nicolas Maduro, erede designato del “Comandante”, suo “figlio” e suo “apostolo”, ce l’ha fatta. Per un soffio, ma ce l’ha fatta. 7 milioni 505 voti per lui, 7 milioni 270 mila per il candidato dell’opposizione Henrique Capriles, 50.7% contro 49%, secondo i dati ufficiali diffusi lunedì dal Consiglio nazionale elettorale e contestati da Capriles. Uno virgola 7 per cento e 235 mila voti di differenza su quasi 15 milioni di voti. Uno scarto così esiguo difficile da ingoiare per la metà del paese che vedeva in Chavez il demonio, e per quella destra che nei 15 anni di chavismo, incapace di vincere sul piano elettoral-democratico, è più volte caduta nella tentazione golpista.
Nelle elezioni presidenziali dell’ottobre 2012 Chavez aveva (stra)vinto ancora, lasciando Capriles 10 punti e un milione e 600 voti indietro (55% contro 45%), domenica scorsa Maduro ha perso, rispetto a sei mesi fa, ha perso più di 4 punti e Capriles li ha guadagnati. Almeno un milione di voti ha cambiato candidato. E i sondaggi che in genere davano a Maduro “almeno 10 punti” di vantaggio si sono liquefatti al momento del voto.
È il vecchio e sempre valido discorso del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Di certo il successo di Maduro è troppo striminzito per poter parlare, come ha fatto, di “trionfo elettorale”. Però, nonostante l’assenza del padre, il Venezuela chavista ha tenuto e ha vinto anche queste elezioni, 17 su 18 dal 1998 (e l’unica sconfitta, il referendum costituzionale del 2007, fu anch’essa come quella di Capriles domenica, per un soffio ma immediatamente riconosciuta dal “dittatore” Chavez). La destra, che non ha mai battuto Chavez nelle urne (e nelle piazze) non ha potuto battere neanche il suo fantasma che aleggiava intorno all’ erede, al “figlio” e “apostolo”.
Il voto di domenica e il successo di Maduro sono stati giudicati trasparenti e legittimi, stando non solo al CNE, che per la sua matrice chavista è visto con sospetto dall’opposizione, ma anche alle varie missioni di osservatori internazionali con grande scorno di diversi governi e giornali mainstream (fino al paradosso della missione di osservatori spagnoli, 7 deputati dei vari partiti, che ha dichiarato “all’unanimità”, compreso quindi il deputato del Partido Popular, che il risultato è “fiable”, mentre il ministro degli esteri del governo Rajoy e il quotidiano El Pais continuavano a sospendere il riconoscimento del risultato).
Capriles, si è rifiutato di piegarsi all’esito delle urne “finché” non fosse stata accettata la sua richiesta di riconteggio manuale, “voto per voto”, non fidandosi di quello elettronico. Richiesta subito fatta propria dal Dipartimento di Stato USA e dall’OSA, l’Organizzazione degli Stati Americani, comunemente noto come il Ministero delle colonie degli Stati Uniti, che non ha avuto problemi a riammettere l’Honduras del golpista Lobo dopo il golpe contro Zelaya del 2009 e non ha battuto ciglio di fronte al golpe parlamentare che nell’agosto 2012 ha rovesciato il presidente legittimo Lugo in Paraguay.
Poi ha invocato la piazza, che ha accolto l’invito con aggressioni ai chavisti e attacchi contro le sedi del PSUV, il Partido Socialista Unido de Venezuela, le emittenti televisive affini al chavismo come VTV e TeleSur, i medici cubani che lavorano nei centri sanitari aperti grazie alla Missione “Barrio adentro”. Ma Capriles dovrà rassegnarsi alla seconda sconfitta, in attesa delle prossime presidenziali del 2019, anche se ha in mano anche la carta del referendum abrogativo dopo i primi tre anni di mandato di Maduro, la stessa carta giocata e persa dall’opposizione contro Chavez nel 2004.
A meno che non voglia correre l’azzardo della destabilizzazione (che peraltro non si è mai fermata, come ha rivelato di recente la benemerita WekyLeaks pubblicando i cablo inviati a Washington nel 2006 dall’allora ambasciatore Usa Brownfield sull’andamento dell’operazione “Destabilize Venezuela”) contraddicendo però quell’immagine di recupero democratico che si è provato a dare a un’opposizione rabbiosa, classista e tendenzialmente golpista: di sé dice di non essere “né di destra né di sinistra ma solo progressista” (ma c’è che giura che in gioventù faceva parte dell’ultra-destra di “Tradizione, Patria, Famiglia” e ci sono video che lo immortalano mentre dà l’assalto all’ambasciata cubana durante l’effimero golpe anti-chavista dell’aprile 2002), assicura che il suo è il “modello Brasile” , un mix di politiche “pro-business” e di forti programmi sociali, tanto da confermare (ma “migliorandole”) le “misiones” chaviste e da proporre la nazionalità venezuelana per gli eroici e vituperati medici cubani (ma l’ex-presidente Lula lo ha gelato con un video in cui dice che lui è per “Maduro presidente e per il Venezuela sognato da Chavez”).
Il problema non sembra essere tanto Capriles. Il problema è Maduro. Che non ha la personalità, il prestigio e l’olfatto politico di Chavez. E che si troverà di fronte a scelte difficili in un paese diviso in due e orfano di Chavez. Ha vinto ma per un margine così stretto che non potrà non tenerne conto. Il suo programma – sicurezza per far fronte a una violenza allarmante (16 mila morti in un anno), lotta alla corruzione diffusa e alla inefficienza della burocrazia, rilancio e diversificazione di un’economia in affanno (inflazione al 20-30%, debito pubblico al 55% del pil, deficit fiscale al 12%) e troppo dipendente dal petrolio (e da un prezzo del barile che se scendesse sotto i 100 dollari sarebbe un disastro), conferma non così scontata dell’alleanza fra civili e militari, coltura dei germi di “poder popular” in chiave anti-burocratica, ruolo del PSUV come fucina di dibattito politico e non solo come rampa di carriera politica, mantenimento dei costosi programmi sociali all’interno (con relativa ed esorbitante spesa pubblica) e dei costosi programmi di sostegno al sogno dell’integrazione latino-americana.
Poi, niente affatto ultimo, c’è l’incognita del campo popolare e chavista, la cui unità è tutta da dimostrare e dove potrebbe essere già cominciata una resa dei conti. Diosdado Cabello, il grande rivale di Maduro per l’eredità di Chavez e “relegato” alla presidenza dell’Assemblea nazionale, non ha perso tempo per dire che i risultati di domenica impongono “una profonda autocritica”.
Dovrà portare avanti i sogni e i programmi di Hugo Chavez ma senza Hugo Chavez. Dovrà camminare con Chavez ma andare anche oltre Chavez. Non potrà fermarsi, in una sorta di rivoluzione nella rivoluzione. E con davanti un dilemma che ai più vecchi ricorderà quello a cui si trovò di fronte la Unidad Popular di Salvador Allende nel Cile primi anni ’70: “avanzar para consolidar” o “consolidar para avanzar”? Allora si sa come andò a finire. Ma era tanto tempo fa, un altro secolo. Forse questa volta andrà meglio.